FAMIGLIE QUEER That Certain Summer (1972): Scene Da
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Construction of Gender Roles and Sexual Dissidence on TV
The Construction of Gender Roles And Sexual Dissidence on TV Using Anglo-Saxon Paradigms to Re-read Catalan and Spanish Texts Ph.D. 2013 SILVIA GRASSI Cardiff University 1 Contents Abstract i Acknowledgements ii Introduction 1-20 Chapter 1: The Construction of Gender Roles in Soap Operas: Using Anglo-Saxon Paradigms to Re-read Catalan Texts 21-123 1.1 A Call to Action: Television as a Site for Feminist Struggle 22-33 1.2 How and Why Women Watch Television: From Content Analysis to Audience Analysis 33-42 1.3 Soap Opera: A ‘Female’ Genre? 43-51 1.4 How and Why Women Watch Soap Operas: An Analysis of this Genre’s Appeal for an Audience Constructed as Female 51-67 1.5 Are Soaps all the Same? An Analysis of National Differences within the Genre 68-80 1.6 Are Soaps a Safe Place? An Analysis of Models of Family and the Construction of a Sense of Community in Soaps 80-99 1.7 Learning From Soaps: An Analysis of Soap Operas’ Didactic Aspirations 99-120 1.8 Conclusions 120-123 Chapter 2 The Construction of Sexual Dissidence on TV Using Anglo-Saxon Paradigms to Re-read Spanish and Catalan Texts 124-223 2.1 Do Words Count? A Terminological Clarification 126-131 2 2.2 An Overview of Studies of Non-Heteronormative Content on TV 131-135 2.3 Why Television Counts: The Importance of Non-Heteronormative Media Images 135-141 2.4 Normalisation: Who Has the Right to Belong to a Normal Country? 141-163 2.5 Television’s Construction of Sexual Dissidence: The Dominant Paradigm of Essentialism 163-198 2.6 Constructing a Collective History 198-211 2.7 Television’s Depiction of the Role of the School System in Sustaining Heteronormativity 211-218 2.8 Conclusions 219-223 Conclusion 224-232 Appendix 1 233-273 Appendix 2 274-296 Bibliography 297-331 3 Abstract Taking as a starting point an interpretation of the television medium as an Ideological State Apparatus, in my thesis I examine how gender roles and sexual dissidence are constructed in Spanish and Catalan television series. -

Emmy Award Winners
CATEGORY 2035 2034 2033 2032 Outstanding Drama Title Title Title Title Lead Actor Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Lead Actress—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actor—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actress—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Outstanding Comedy Title Title Title Title Lead Actor—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Lead Actress—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actor—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actress—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Outstanding Limited Series Title Title Title Title Outstanding TV Movie Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Lead Actor—L.Ser./Movie Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Lead Actress—L.Ser./Movie Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actor—L.Ser./Movie Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actress—L.Ser./Movie Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title CATEGORY 2031 2030 2029 2028 Outstanding Drama Title Title Title Title Lead Actor—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Lead Actress—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actor—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actress—Drama Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Outstanding Comedy Title Title Title Title Lead Actor—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Lead Actress—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. Actor—Comedy Name, Title Name, Title Name, Title Name, Title Supp. -

UC Irvine Electronic Theses and Dissertations
UC Irvine UC Irvine Electronic Theses and Dissertations Title Queering and Qualifying the Wasteland: Network Television, Awards Discourse, and Gay Legitimation in Primetime from 1971-1995 Permalink https://escholarship.org/uc/item/0576m18j Author Kruger-Robbins, Benjamin Publication Date 2019 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE Queering and Qualifying the Wasteland: Network Television, Awards Discourse, and Gay Legitimation in Primetime from 1971-1995 DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Visual Studies by Benjamin Kruger-Robbins Dissertation Committee: Associate Professor Victoria E. Johnson, Chair Associate Professor Allison Perlman Professor Jennifer Terry © 2019 Benjamin Kruger-Robbins TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES iii ACKNOWLEDGMENTS v CURRICULUM VITAE vi ABSTRACT OF THE DISSERTATION x INTRODUCTION: GAY UPLIFT FROM THE TELEVISION WASTELAND 1 Taste Cultures and Media Pedagogy 3 Historicizing Quality TV 16 Chapter Summaries 25 CHAPTER 1: AWARDS DISCOURSE AND HISTORIES OF QUALIFICATION 33 The Emmys and Industrial Standards 34 The Golden Globes: Misfit Journalists and Queer Selections 48 The Peabody’s Academic Shifts 57 Conclusion: GLAAD, From Watchdog to Lapdog 66 CHAPTER 2: SUPERIOR PRODUCTIONS ON SENSITIVE TOPICS – ELEVATING 70 1970S GAY PROGRAMMING Mainstreaming Homosexuality in Early 1970s Urban Spheres 72 Dawn of 1970s “Relevance” Programming: -

Used at Home but Claimed As Business Example, Does Not Trigger an Audit, Though Stories Are Tux Laws Iire: Expenses) Are Particularly Strict
MAN(^HKKTKR HERALD, Thursday. Dfc. 13. 1984 MANCHESTER FOCUS SPORTS WEATHER BUSINESS Vocational teachers WFSB sing-along has Ray Page winner Cloudy tonight with Avoid tax audit triggers when preparing return nix pact 556 to 126 sign-along for deaf in debut with East freezing rain likely ... page 4 ... page 13 ... page 9 ... page 2 If you loiith an Internal Revenue Service tax audit, lor business automobiles is now limited to St,000. TO TAL GROSS RECEIPTS OF $100,000 OR MbRE: you can overcome the fear through a rational On Form 1040 business returns. Total Gross Receipts understanding of the tax-audit process. You needonly CASUALTY AND LOSSES: A casualty is required (TGR) computed by adding Schedule C gross receipts follow the proper filing techniques in this series to Y o u r to be "sudden, unexpected and unusual in nature." and Schedule F gross receipts. protect yourself. The meaning of those terms often engenders dispute. M o n e y 's The method of computing casualty losses has TOTAL POSITIVE INCOME (TPI) OF $50,000 OR The Internal Revenue Service has suffered a 5 changed. MORE: On Form 1040 non-bu.siness returns. Total percent cutback in staff since 1977. and with the W o rth Positive Income (T P I) includes wages, interest, severe shortage of work force cannot hope to audit Sylvia Porter HOME OFFICE DEDUCTIONS: Expenses in dividends, Schedule C and Schedule F net profits, and more than 1 percent to 2 percent of all returns filed curred in using a residence as an office are generally certain other income and distributions. -
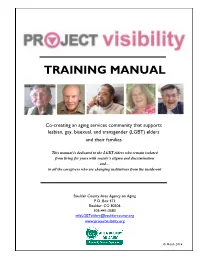
Project Visibility
TRAINING MANUAL Co-creating an aging services community that supports lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) elders and their families This manual is dedicated to the LGBT elders who remain isolated from living for years with society’s stigma and discrimination and… to all the caregivers who are changing institutions from the inside-out Boulder County Area Agency on Aging P.O. Box 471 Boulder, CO 80306 303-441-3583 [email protected] www.projectvisibility.org © March 2016 Table of Contents Welcome ....................................................................................................................................................... 3 Beginning with Basics: Terms and Concepts ............................................................................................... 4 Eight Basic Points about LGBT Elders (sidebar) ......................................................................................... 8 Frequently Asked Questions ......................................................................................................................... 9 Gay Grief. Ways to Show Culturally Competency in LGBT issues (sidebar) ............................................ 10 Reflections of a Lesbian Caregiver. Facts about LGBT Elders (sidebar) ................................................... 11 Studies about LGBT Elders (sidebar) ......................................................................................................... 12 The Power of Coming-out Stories (sidebar) ............................................................................................. -

Mapping the Landscape of Social Impact Entertainment
Bonnie Abaunza Neal Baer Diana Barrett Peter Bisanz Dustin Lance Black Johanna Blakley Caty Borum Chattoo Don Cheadle Wendy Cohen Nonny de la Peña Leonardo DiCaprio Geralyn Dreyfous Kathy Eldon Eve Ensler Oskar Eustis Mapping the landscape of Shirley Jo Finney social impact entertainment Beadie Finzi Terry George Holly Gordon Sandy Herz Reginald Hudlin Darnell Hunt Shamil Idriss Tabitha Jackson Miura Kite Michelle Kydd Lee Anthony Leiserowitz David Linde Tom McCarthy Cara Mertes Sean Metzger Pat Mitchell Shabnam Mogharabi Joshua Oppenheimer Elise Pearlstein Richard Ray Perez Gina Prince-Bythewood Ana-Christina Ramón James Redford Liba Wenig Rubenstein Edward Schiappa Cathy Schulman Teri Schwartz Ellen Scott Jess Search Fisher Stevens Carole Tomko Natalie Tran Amy Eldon Turteltaub Gus Van Sant Rainn Wilson Samantha Wright Welcome to the test — a major university research SIE’s work to date: the most effective Welcome center focused on the power of strategies for driving impact through entertainment and performing arts to storytelling; the question of when, inspire social impact. The structure of within the creative process, impact Note this new center would be built upon three should first be considered; the key role pillars: research, education and special of research to explore, contextualize initiatives, and public engagement, and help define the field; and the programming and exhibition. importance of partnering with the right allies across the entertainment At the time, there wasn’t a university and performing arts industries for new model fully focused on this topic that ideas, special projects and initiatives. I could draw upon for information as the field was in its infancy. -

Richard Levinson and William Link Collection
Finding Aid for the Levinson and Link Collection Collection Processed by: Maya Peterpaul, 7.17.18 Finding Aid Written by: Maya Peterpaul, 7.17.18 OVERVIEW OF THE COLLECTION: Origination/Creator: Levinson, Richard and William Link Title of Collection: Levinson and Link Collection Papers Date of Collection: 1949 -- 1986 Physical Description: 4 44 Boxes, 18.3 linear feet Identification: Special Collection #13 Repository: American Film Institute Louis B. Mayer Library, Los Angeles, CA RIGHTS AND RESTRICTIONS: Access Restrictions: Collection is open for research. Copyright: The copyright interests in this collection remain with the creator. For more information, contact the Louis B. Mayer Library. Acquisition Method: Donated by Richard Levinson with the cooperation of Rosanna Levinson. BIOGRAPHICAL/HISTORY NOTE: Richard Levinson was born on August 7, 1934 in Philadelphia, Pennsylvania, the son of Georgia (née Harbert) and Georgia Levinson. He married Rosanna Huffman on April 12, 1969, with whom he had one child, a daughter named Christine. Levinson died of a heart attack at the age of 52 on March 12, 1987, in Los Angeles, California. William Link was born on December 15, 1933 in Philadelphia, Pennsylvania, the son of Elsie (née Roerecke) and William Theodore Link, a textile broker. Levinson and Link met in 1946, on their first day of junior high school in Elkins Park, Pennsylvania. They bonded over a love of murder mysteries and magic tricks, and through their close friendship forged the beginnings of a life-long writing and producing partnership. During their time at Cheltenham High School, Levinson and Link worked together writing short stories, radio scripts, a musical (Election Time), and a mystery novel (House of Cards). -

American Television, Drama by Nathan G
American Television, Drama by Nathan G. Tipton Encyclopedia Copyright © 2015, glbtq, Inc. Entry Copyright © 2002, glbtq, Inc. Reprinted from http://www.glbtq.com Despite a steady increase in the number of "big screen" queer characters and queerly-themed movies, the overt presence of gays and lesbians on the American small screen has been (and continues to be) far more limited. As Suzanna Danuta Walters has explained, while film has long dealt with gay subjects (albeit in often stereotyped or "tragic" ways), television's explicitly family-centric format appeared to mandate that glbtq persons were simply not a part of families that made up "typical" family audiences. After all, Walters continues, the intense intimacy and centrality of television in the personal space of family life provides a particular type of viewing experience that is fundamentally distinct from the relative anonymity of movie theaters. Not surprisingly, this family-centrism is displayed most prominently in programs shown by the five broadcast television networks, ABC, CBS, NBC, The CW, and Fox. These networks have historically been reticent about tackling homosexuality in its multifarious forms, preferring instead to leave these programming decisions to the proliferating number of cable networks. Still, long before the advent of cable, broadcast networks were tentatively exploring homosexuality by vicariously inserting into dramatic television series stereotypically gay characters. Â Early Representations From 1968 to 1974, as Edward Alwood has explained, homosexuals on television were recognizable in programs such as Kojak, M*A*S*H, Police Woman, and Hawaii Five-O because of their routine representation as limp-wristed, effeminate drag queens who walked with a swish and talked in high-pitched voices. -

A R C H I V E S T U D Y G U I
Archive Study Guide: LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER TELEVISION: MADE-FOR-TV MOVIES ARCHIVE STUDY GUIDE In contrast to the stereotypical depictions frequently seen in episodic television programming over the past five decades, historically, many made-for-TV movies have reflected a more realistic approach to representations of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) communities and issues. As early as 1972, ABC’s That Certain Summer, explored the relationship between a divorced gay man and his son to warm critical reception and a subsequent Golden Globe award for “Best Movie Made for TV.” Similarly, ABC’s A Question of Love (1978) marked an early portrayal of a lesbian mother, her loving relationship with her domestic partner and their joint effort to retain custody of their children in a climate of homophobia. An Early Frost, broadcast on NBC in 1985, garnered wide acclaim and numerous awards as one of the first network programs to dramatically and sensitively examine the devastating impact of the AIDS crisis on a gay individual and his family. Unencumbered by pressures to accommodate advertisers, productions originating from the Public Broadcasting Service (PBS) and cable networks have consistently presented a wider range of earnest depictions of LGBT lifestyles than have been previously shown on television. HBO’s More Than Friends: The Coming Out of Heidi Leiter (1994) featured an early small screen same-sex kiss in its examination of a teenager’s realization of her lesbian sexual orientation. Showtime’s drama, Soldier’s Girl (2003) offered the true story of hate crime victim Barry Winchell, a 21-year-old private first class who falls in love with a transgendered nightclub performer. -

Books for You: a Booklist for Senior High Students
'DOCUMENT RESUME ED 130 270 CS 202 973 AUTHOR Donelson, Kenneth L., Ed.; And Others TITLE Books for You: A Booklist for Senior High Students. Sixth Edition. INSTITUTION National Council of Teachers of English, Urbana, PUB DATE 76 NOTE 490p.; Compiled by the Committee on the Senior High School Booklist of the National Council of Teachers of English AVAILABLE gRomNational Council of Teachers of English, 1111Kenyon Road, Urbana, Illinois 61801 (Stock No. 03626, $2.95 non-member, $2.25 member) .EDRS PRICE MF-$1.00 HC-$26.11 Plus Postage. DESCRIPTORS *Adolescent Literature; *Annotated Bibliographies; *Booklists; *Books; *High School Students; literature; Reading, Materials; Secondary Education; Teenagers ABSTRACT The books listed in this annotated bibliography have been selected to provide pleasurable reading for,high school students. Books are arranged alphabetically by author,under 43_main categories. Concluding the book are a directory of publishersand indexes of authors and titles. (JM) *********************************************************************** Documents acquired by ERIC include many informal unpublished * * materials not available from other sources. ERIC makesevery effort * * to obtain'the best'copy available. Nevertheless, itemsof marginal * * reproducibility are often encountered and this affects the quality. * * .of the:microfiche and hardcopy reproductions ERIC makes available * * via the ERIC Document Reproduction Service (EDRS). EDRS isnot * responsible for the quality.of the original document. leproductions* * supplied by EDRS are the best that can be made from the original. * *********************************************************************** . U.S. DEPARTMENT OF HEALTH. EDUCATION & WELFARE NATIONAL INSTITUTE DF EDUCATION THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRO- DUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGIN- ATING IT POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRE- SENT OFFICIAL NATIONAL INSTITUTE OF z EDUCATION POSITION OR POLICY. -

Columbia Pictures: Portrait of a Studio
University of Kentucky UKnowledge Film and Media Studies Arts and Humanities 1992 Columbia Pictures: Portrait of a Studio Bernard F. Dick Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Dick, Bernard F., "Columbia Pictures: Portrait of a Studio" (1992). Film and Media Studies. 8. https://uknowledge.uky.edu/upk_film_and_media_studies/8 COLUMBIA PICTURES This page intentionally left blank COLUMBIA PICTURES Portrait of a Studio BERNARD F. DICK Editor THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY Copyright © 1992 by The University Press of Kentucky Paperback edition 2010 Scholarly publisher for the Commonwealth, serving Bellarmine University, Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, The Filson Historical Society, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky University, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. All rights reserved. Editorial and Sales Offices: The University Press of Kentucky 663 South Limestone Street, Lexington, Kentucky 40508-4008 www.kentuckypress.com Cataloging-in-Publication Data for the hardcover edition is available from the Library of Congress ISBN 978-0-8131-3019-4 (pbk: alk. paper) This book is printed on acid-free recycled paper meeting the requirements of the American National Standard for Permanence in Paper for Printed Library Materials. -

Movies Made for Television, 2005-2009
Movies Made for Television 2005–2009 Alvin H. Marill The Scarecrow Press, Inc. Lanham • Toronto • Plymouth, UK 2010 Published by Scarecrow Press, Inc. A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, Maryland 20706 http://www.scarecrowpress.com Estover Road, Plymouth PL6 7PY, United Kingdom Copyright © 2010 by Alvin H. Marill All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the publisher, except by a reviewer who may quote passages in a review. British Library Cataloguing in Publication Information Available Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Marill, Alvin H. Movies made for television, 2005–2009 / Alvin H. Marill. p. cm. Includes indexes. ISBN 978-0-8108-7658-3 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-0-8108-7659-0 (ebook) 1. Television mini-series—Catalogs. 2. Made-for-TV movies—Catalogs. I. Title. PN1992.8.F5M337 2010 791.45’7509051—dc22 2010022545 ϱ ™ The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI/NISO Z39.48-1992. Printed in the United States of America Contents Foreword by Ron Simon v Acknowledgments vii Introduction ix Movies Made for Television, 2005–2009 1 Chronological List of Titles, 2005–2009 111 Television Movies Adapted from Other Sources 117 Actor Index 125 Director Index 177 About the Author 181 iii Foreword Alvin Marill has had one of the longest relationships in media history.