The Trento Law and Technology Research Group Student Paper N
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

International Technology Transfer Convention 2014
IP Awareness in Secondary and Tertiary Education- an Australian Perspective Zhuhai, Novemberr 06, 2019 Dr Andy Sierakowski, Former Chair, KCA and Chair International Committee ITTN Beijing INTRODUCTION : • My background: – Academic beginnings – Private sector – University technology transfer – KCA – Current role ITTN International Committee – who are we and what do we do? • Global advisory network to ITTN • Work closely with the ITTN Secretariat to promote international technology transfer between China and other countries • Conduct IP awareness and technology transfer training in China. • APEC projects in IP technology transfer in the Region. Published Technology Commercialization Handbook in APEC Economies, 2019, as a training aid. • More than 140 influential leaders from overseas international technology transfer organizations This talk: • Will focus largely on IP awareness and training as it relates to tertiary sector/ university technology transfer and IP commercialization • University of Western Australia, 2001-2014 and more recently on IP awareness training conducted in China on ITTN programs Some key Groups involved in IP Awareness training in Australia • IP Australia (Australian Federal Government agency that manages and registers various forms of IP protection) See www.ipaustralia.gov.au/ • Knowledge Commercialisation Australasia(a public-sector focussed organisation focussing on technology transfer) See https://techtransfer.org.au/ • Licensing Executives of Australia and New Zealand or LESANZ (the local chapter of LES) See https://www.lesanz.org.au/ -

Melbourne on Friday, 24 June 2016 at 8.41 Am
__________________________________________________________ PRODUCTIVITY COMMISSION INQUIRY INTO INTELLECTUAL PROPERTY ARRANGEMENTS MR J COPPEL, Commissioner MS K CHESTER, Deputy Chair & Commissioner TRANSCRIPT OF PROCEEDINGS AT PRODUCTIVITY COMMISSION, MELBOURNE ON FRIDAY, 24 JUNE 2016 AT 8.41 AM IP Arrangements 24/06/16 © C'wlth of Australia INDEX Page MR MARK SUMMERFIELD 557-571 AUSTRALIAN BOOKSELLERS ASSOCIATION MR JOEL BECKER 572-590 MR MARK RUBBO MR TIM WHITE ELECTRONIC FRONTIERS AUSTRALIA MR JON LAWRENCE 591-602 MR PETER DONOUGHUE 602-609 MS DEE WHITE 609-616 MR PETER GLEESON 617-624 ASSOCIATION OF LIQUOR LICENCES MELBOURNE MR CON SARROU 624-632 PENGUIN RANDOM HOUSE AUSTRALIA MS JULIE BURLAND 633-646 MS BRIONY LEWIS LAW COUNCIL OF AUSTRALIA MR RICHARD HAMER 647-659 QUALCOMM INCORPORATED MR ALEX ORANGE 659-672 MR PHIL WADSWORTH IPTA MR MICHAEL CAINE 673-686 TEXT PUBLISHING COMPANY OF AUSTRALIA MR MICHAEL HEYWARD 687-697 MR MARCUS FAZIO MS WENDY ORR 698-704 SCRIBE PUBLICATIONS MR HENRY ROSENBLOOM 705-712 IP Arrangements 24/06/16 © C'wlth of Australia HAPPY FINISH DESIGN MR NICK RENNIE 712-719 MR NICK GRUEN 719-727 MR DAVID DAY 727-730 IP Arrangements 24/06/16 © C'wlth of Australia RESUMED [8.41 am] 5 MR COPPEL: Good morning everybody. Welcome to the public hearings of the Productivity Commission Inquiry in Australia's Intellectual Property Arrangements. My name is Jonathan Coppel and I am one of the Commissioners on the inquiry and my colleague Karen Chester is the other Commissioner. 10 By way of background, the inquiry started with a terms of reference from the Australian Government in August 2015 to examine Australia's IP arrangements including their effect on investment, competition, trade, innovation and consumer welfare. -

Re-Thinking the Role of Intellectual Property
Re-Thinking the Role of Intellectual Property 1 Francis Gurry The context in which intellectual property (IP) operates in the contemporary world is vastly different from the one in which IP was born. The new context has changed the position of IP both in the economy and in society. It calls equally for a change in the way in which we think about IP and its role. Traditional Explanations for IP Let me start by recalling briefly the traditional explanations of why we have IP. There are four main reasons, applicable to varying degrees to all the rights that we characteristically consider to be IP rights. Oneset of explanations arises from the non-rivalrous nature of knowledge and information. Knowledge and information are private goods in production. They cost human and financial resources to create. In contrast, they are public goods in consumption. Once available, they may be used by another without lessening their enjoyment by the producer. This characteristic of knowledge was noticed by Columcille in his defence against the charge by Finnianin Ireland in the Sixth Century that he had copied the illuminations of a bible that Finnian had lent to him. When called before King Diarmuid to answer to the charge of theft, Columcille protested that he had not stolen anything, since Finnian still had his 1Director General, World Intellectual Property Organization (WIPO). The views expressed in this paper do not necessarily reflect the views of the Member States of WIPO. Re-Thinking the Role of Intellectual Property 2 Francis Gurry drawings and “Finnian’s book was none the worse for his copying from it.” In dismissing the defence, the king ushered copyright into the world by pronouncing “To every cow her calf; and to every book its copy.” 2 IP creates a policy restriction, in the form of exclusive rights to commercial use, on the otherwise free availability of knowledge and information in order to compensate for the cost of production of the knowledge or information. -
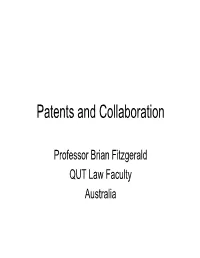
Patents and Collaboration
Patents and Collaboration Professor Brian Fitzgerald QUT Law Faculty Australia Two Levels 1) Between national offices – inter-office 2) Between national offices and the community Patent • Granted by a national (patent)office • There is no such thing as an international patent Mutli-Jurisdiction Patent Filing • Paris Convention 1883 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html • Patent Cooppy()eration Treaty 1970 (PCT) http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm • Regional level filing – e.g. European Patent Office – European Patent Convention (1973) Paris Convention on Industrial Property 1883 – Art 4 - Priority A. (1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed. ... B. Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union C. -

Intellectual Property Forum Issue 123
Issue 123 Intellectual Property Forum Issue 123 Journal of The Intellectual Property Society of Australia and New Zealand Inc. March 2021 Co-Editors Fiona Phillips Fiona Rotstein Editorial • In Conversation with Jo Oliver • Obituary: John Adrian Sterling, 17 April 1927 – 29 November 2020 • Articles • Finding Harmony between “Commonplace” and “Copyright”: a Contents Sound Legal Approach to Borrowing in Popular Music • Parameteritis in Patent Claims – New Diagnosis, Old Cures • Geographical Indications and the Australia-EU FTA Negotiations: an Assessment of the Potential Costs and Benefits to Australia • Store Layouts and the Trade Mark Apple: Will Australia Take a Bite? • Reports • The INTELLECTUAL PROPERTY FORUM Decision of the Full Federal Court of Australia in Sandoz v Lundbeck and its Implications in Pre-Grant and Post-Patent Term Environments • Review of Art Law and the Business of Art • Current Developments • Australia • New Zealand • Asia • Europe • North America • Africa Intellectual Property Forum The Intellectual Property Society of Australia and New Zealand Inc The Journal of The Intellectual Property Society of Australia Subscriptions to the Journal Trans Tasman National Committee of Management and New Zealand Inc ABN 056 252 558 Four issues of the Journal are published annually. President: Shelley Einfeld Co-Editors Membership of the Society entitles you to receive the Journal. Subscriptions to the Journal can be purchased from the Society. Contact the Society for Fiona Phillips Vice Presidents: Clare Cunliffe and Fiona Rotstein -

Encouraging the Ideas Boom in Biosciences Through Collaboration
Encouraging the ideas boom in the biosciences - A white paper from MSD (Australia) Ltd 16 December 2015 Encouraging the ideas boom in biosciences through collaboration Key points • MSD Australia welcomes the Prime Minister’s recent announcement of a National Innovation and Science Agenda. • Australia has a long heritage in making medical breakthroughs but our track record in commercialising biomedical research is poor. • Consistent with the National Innovation and Science Agenda, MSD believes that the following would greatly enhance Australia’s innovative output in the biosciences: 1. Leverage the local presence of business development functions of global bioscience companies, potentially through the Medical Devices & Pharmaceutical Growth Centre 2. Involve more leaders with commercial experience on NH&MRC grant panels 3. Further encourage private companies to participate in NH&MRC and MRFF research 4. Recognise the potency of trials in generating expertise in cutting edge science 5. Streamline the approval and improve the co-ordination of clinical trials 6. Support fair and transparent reimbursement policies 7. Consider the benefits of extending data exclusivity provisions for Australian science 8. Reduce the red-tape associated with registering innovative medicines. 1 Encouraging the ideas boom in the biosciences - A white paper from MSD (Australia) Ltd Introduction Australian scientists have played a leading role in bioscience research for over 80 years, from Florey’s pioneering work in penicillin production, through Don Metcalf’s discovery of the first therapeutic proteins to Ian Frazer’s invention of cancer vaccine technology. While Australia punches above its weight in basic research, its performance in commercialising biomedical discoveries is poor. The 2013 Global Innovation Index ranked Australia 116th out of 142 countries in innovation efficiency. -

Australian Official Journal Of
Vol: 35 , No: 24 17 June 2021 AUSTRALIAN OFFICIAL JOURNAL OF PATENTS The Australian Official Journal of Patents is part of the Official Journal issued by the Commissioner of Patents for the purpose of the Patents Act 1990, the Trade Marks Act 1995 and the Designs Act 2003. (ISSN 0819-1794) AUSTRALIAN OFFICIAL JOURNAL OF PATENTS 17 June 2021 Contents General Information & Notices Amendments Applications for Amendment ...................................................................................... 5060 Amendments Made ...................................................................................................... 5061 Alteration of Name(s) of Applicant(s)/Patentee(s) .................................................... 5063 Applications Accepted Name Index ................................................................................................................... 5154 Numerical Index ............................................................................................................5177 IPC Index .......................................................................................................................5179 Applications with amended filing dates Reg 3.5(A). ................... 5055 Applications Lapsed, Refused or Withdrawn, Patents Ceased or Expired ........................................................... 5056 Applications Open to Public Inspection Name Index ................................................................................................................... 5066 Numerical Index ............................................................................................................5074 -
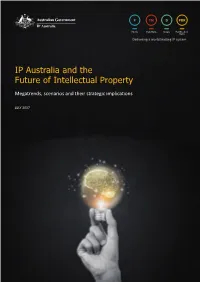
IP Australia and the Future of Intellectual Property
Delivering a world leading IP system IP Australia and the Future of Intellectual Property Megatrends, scenarios and their strategic implications JULY 2017 Citation Attribution IP Australia (2017) IP Australia and the future of intellectual The CC BY licence is a standard form licence agreement that property: Megatrends, scenarios and their strategic implications. allows you to copy and redistribute the material in any medium or Canberra: IP Australia. format, as well as remix, transform, and build upon the material, on the condition that you provide a link to the licence, you indicate if changes were made, and you attribute the material as follows: Copyright Licensed from the Commonwealth of Australia under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. All content in this publication is provided under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. http:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/ with the exception of: Important disclaimer • the Commonwealth Coat of Arms, IP Australia and CSIRO advise that the information contained in • IP Australia’s corporate logo this publication comprises general statements based on scientific • photographs of our staff and premises research. The reader is advised and needs to be aware that such • content provided by third parties – including information may be incomplete or unable to be used in any photographs, logos, drawings and written specific situation. No reliance or actions must therefore be made descriptions of patents and designs on that information without