Dottorato Di Ricerca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Libro Soci GAL Barbagia Aggiornato Al 25/06/2020 SOCI PRIVATI N. Cognome Nome Denominazione Sede Legale Comune 1 Garippa Andrea
Libro soci GAL Barbagia aggiornato al 25/06/2020 SOCI PRIVATI Sede legale n. Cognome Nome Denominazione Comune 1 Garippa Andrea Arte bianca Sas di Garippa Andrea Orgosolo 2 Angioi Stefano Gesuino Orotelli 3 Arbau Efisio Sapores srls Orotelli Managos minicaseificio artigianale di 4 Baragliu Maria Vittoria Baragliu Maria Vittoria Orotelli 5 Bosu Tonino Società Cooperativa Aeddos Orotelli 6 Brau Antonello Azienda agricola Brau Antonello Orotelli Impresa artigianale Pasticceria 7 Cardenia Francesco Cardenia Mamoiada Gian. E Assu.& C. snc di Gianfranco 8 Crissantu Gianfranco Crissantu Orgosolo 9 Golosio Francesco Agronomo Nuoro Società Agricola Eredi Golosio Gonario 10 Golosio Mario s.s. Nuoro 11 Cardenia Francesco Associazione Culturale Atzeni Mamoiada Associazione Culturale Folkloristica 12 Ledda Davide Gruppo Folk Orotelli Orotelli 13 Lunesu Cosima Azienda agricola Lunesu Cosima Orotelli 14 Marteddu Giovannino Fondazione Salvatore Cambosu Orotelli 15 Melis Mariantonietta Mamoiada 16 Morette Emanuele Orotelli GAL BARBAGIA (Gruppo Azione Locale Barbagia) - Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) – CF 93054090910 www.galbarbagia.it email [email protected] 17 Moro Mattia Azienda agricola Moro Mattia Mamoiada 18 Nieddu Giovanni Orotelli 19 Nieddu Cinzia Associazione Culturale Sa Filonzana Ottana 20 Paffi Mario Società Cooperativa Viseras Mamoiada 21 Pira Francesco Cantine di Orgosolo srl Orgosolo 22 Santoni Fabrizio Orotelli 23 Sedda Pasquale Mamoiada 24 Sini Francesco Mamoiada 25 Zoroddu Antonia Orotelli 26 Zoroddu Marialfonsa -

Rankings Municipality of Ollolai
10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Sardegna / Province of Nuoro / Ollolai Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Aritzo Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Jerzu AdminstatArzana logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Lanusei Atzara ITALIA Lei Austis Loceri Bari Sardo Loculi Baunei Lodè Belvì Lodine Birori Lotzorai Bitti Lula Bolotana Macomer Borore Mamoiada Bortigali Meana Sardo Cardedu Noragugume Desulo Nuoro Dorgali Oliena Dualchi Elini Ollolai Fonni Olzai Gadoni Onanì Gairo Onifai Galtellì Oniferi Gavoi Orani Girasole Orgosolo Ilbono Orosei Irgoli Orotelli Ortueri Orune Osidda Osini Ottana Ovodda Perdasdefogu Posada Sarule Silanus Sindia Powered by Page 3 Siniscola L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Sorgono Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Talana CAGLIARIITALIA Tertenia NUORO Teti ORISTANO Tiana SASSARI Tonara SUD SARDEGNA Torpè Tortolì Triei Ulassai Urzulei Ussassai Villagrande Strisaili Regions Abruzzo Liguria Basilicata Lombardia Calabria Marche Campania Molise Città del Piemonte Vaticano Puglia Emilia-Romagna Repubblica di Friuli-Venezia San Marino Giulia Sardegna Lazio Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige/Südtirol Umbria Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Veneto Address Contacts Italia -

Curriculum Vitae Maria Paola Dettori
Curriculum Vitae Maria Paola Dettori Informazioni personali Cognome / Nome Dettori Maria Paola Telefono 0792067407 E-mail [email protected] Cittadinanza Italiana Maria Paola Dettori si laurea in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Cagliari, dove poi prosegue con la Scuola di specializzazione in Storia dell’Arte. Master di II livello “DECApro - Master Interdipartimentale in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale”, Università degli Studi di Sassari Nel 2001 consegue l’idoneità al concorso per Funzionario Storico dell’Arte e Storico dell’Arte Direttore nei ruoli del Ministero dei Beni Culturali – Regione Sardegna. Di ruolo nella PA dal 2000, in servizio presso il MiBACT dall’ottobre 2005. Lavoro o posizione Funzionario Storico dell’arte Responsabile Area funzionale Patrimonio storico artistico ricoperti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro / Incarichi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale/ già Direttore Pinacoteca Nazionale di Sassari Principali attività e Responsabile Area funzionale Patrimonio storico artistico - Direttore Ufficio responsabilità attuali Esportazione opere d’arte contemporanea – Responsabile Ufficio Catalogo – Progettista e direttore Lavori di restauro - Curatrice mostre - Autrice di pubblicazioni scientifiche Incarichi e attività Incarichi e attività per il MiBACT 2019 (in corso) Responsabile di Area per il patrimonio storico artistico Direttore dell’Ufficio Esportazione Opere d’arte contemporanea Responsabile Ufficio Mostre e prestiti opere d’arte Progettista e Direttore lavori restauro opere d’arte di: Benetutti e Bortigali, Retabli Maestro di Ozieri, dipinti sec. XVI; Parrocchia sant’Antioco martire di Atzara (NU), statue lignee secc. XVII-XVIII; Chiesa santa Trinità di Sassari, dipinti secc. -

Sardinia & Corsica (M-ID: 2354)
+49 (0)40 468 992 48 Mo-Fr. 10:00h to 19.00h Sardinia & Corsica (M-ID: 2354) https://www.motourismo.com/en/listings/2354-sardinia-and-corsica from €2,999.00 Dates and duration (days) On request 16 days 04/23/2022 - 05/08/2022 16 days This is the ultimate tour for those who want to see the two most beautiful Mediterranean islands, Sardinia and Corsica, in one tour! Unlike many other operators, we use the night ferries for and Lanusei we return to the base hotel near Arbatax. the crossings from Genoa to Sardinia and back from Corsica to Toulon. They are more expensive, but we gain Day 6: Rest day. two extra days of vacation! Day at leisure ... to, for example, just lie around relaxed on the beach or take a small boat trip across the lagoon lake Program: Stagno di Tortolì. Day 1: Arrival at the intermediate hotel. Departure at 7.00 a.m. at the service area Geismühle West Day 7: To the Gulf of Cagliari. (A57) in southern direction for the common journey to Weil The southeast of Sardinia down to the Gulf of Cagliari is our am Rhein. touring destination today. The way there leads us through a paradise of curves along the coast, back we ride again Individual arrival possible. through the mountains of the Gennargentu range. Day 2: Over the Gotthard Pass to Genoa to the ferry. Day 8: Day trip to Santa Teresa Gallura to the ferry and From our stopover hotel in Weil am Rhein we ride over the crossing to Corsica. -

HISTORICAL PERSPECTIVES on Property and Land Law
HISTORICAL PERSPECTIVES on Property and Land Law EDITED BY Elisabetta Fiocchi Malaspina and Simona Tarozzi Historical Perspectives on Property and Land Law The Figuerola Institute Programme: Legal History The Programme “Legal History” of the Figuerola Institute of Social Science History –a part of the Carlos III University of Madrid– is devoted to improve the overall knowledge on the history of law from different points of view –academically, culturally, socially, and institutionally– covering both ancient and modern eras. A number of experts from several countries have participated in the Programme, bringing in their specialized knowledge and dedication to the subject of their expertise. To give a better visibility of its activities, the Programme has published in its Book Series a number of monographs on the different aspects of its academic discipline. Publisher: Carlos III University of Madrid Book Series: Legal History Editorial Committee: Manuel Ángel Bermejo Castrillo, Universidad Carlos III de Madrid Catherine Fillon, Université Jean Moulin Lyon 3 Manuel Martínez Neira, Universidad Carlos III de Madrid Carlos Petit, Universidad de Huelva Cristina Vano, Università degli studi di Napoli Federico II More information at www.uc3m.es/legal_history Historical Perspectives on Property and Land Law An Interdisciplinary Dialogue on Methods and Research Approaches Edited by Elisabetta Fiocchi Malaspina and Simona Tarozzi Dykinson 2019 Historia del derecho, 78 ISSN: 2255-5137 © Autores Editorial Dykinson c/ Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid Tlf. (+34) 91 544 28 46 E-mail: [email protected] http://www.dykinson.com Preimpresión: TALLERONCE ISBN: 978-84-1324-499-0 Versión electrónica disponible en e-Archivo http://hdl.handle.net/10016/29290 Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España TABLE OF CONTENT 9 Introduction Transfer of Immovable Properties, Publicity and 15 Land Law in the Age of Justinian: the Perspective of the Praetorian Prefect. -

AUTORI Musicisti
i g u a a i r o t b r d z s o o n pagnuolo o a iz a S T n P r y L R o a ta ia o G t r io e i t e s P io g B t d io s r edeo o a iz ia e e e lp r l m n L u M im S u A A e s V a Bernard Guetta Bernard s B a M Sandro Veronesirlo ni M a sicisti bo C ar AUTORI u C M ria le i a se V ro i O Chiara Effe d os nt Ju i sort ala M a Vanni Masal a Gavino Murgi Nilo Pierpaolo Vacca Festival letterario SetteSere SettePiazze SetteLibri Decima edizione: Nel segno di Paolo Fabbri News - Il festival letterario SetteSere SettePiazze SetteLibri si terrà a Perdasdefogu per la sua decima edizione da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto. Ogni incontro inizia alle 21. Sette autori, quindici relatori, lettura di brani, ogni serata con un gruppo musicale diverso. La rassegna è dedicata al semiologo Paolo Fabbri (Rimini 1939- Rimini 2 luglio 2020): avrebbe dovuto aprire la rassegna con una lectio magistralis dal titolo: “Le parole che non usiamo più”. Dal 16 al 19 luglio si terrà il prefestival con appuntamenti a Fonni (libro “La taranta della vita” di Amedeo Spagnuolo il 16), con Massimo Bray, Lella Mazzoli e Antonietta Mazzette a Sassari il 17 col libro di Bray “Alla voce cultura”, il 18 a Escalaplano e il 20 a Santa Maria Navarrese con Matteo Porru e il suo libro “Madre ombra”. -

Field T Rip Guide Book
Volume n° 5 - from P37 to P54 32nd INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS HYDROGEOLOGY OF THE ISLAND OF SARDINIA (ITALY) Leader: G. Barrocu Field Trip Guide Book - P37 Field Trip Associate Leader: A. Vernier Florence - Italy August 20-28, 2004 Post-Congress P37 P37_copertina_R_OK C 26-05-2004, 11:03:05 The scientific content of this guide is under the total responsibility of the Authors Published by: APAT – Italian Agency for the Environmental Protection and Technical Services - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - Italy Series Editors: Luca Guerrieri, Irene Rischia and Leonello Serva (APAT, Roma) English Desk-copy Editors: Paul Mazza (Università di Firenze), Jessica Ann Thonn (Università di Firenze), Nathalie Marléne Adams (Università di Firenze), Miriam Friedman (Università di Firenze), Kate Eadie (Freelance indipendent professional) Field Trip Committee: Leonello Serva (APAT, Roma), Alessandro Michetti (Università dell’Insubria, Como), Giulio Pavia (Università di Torino), Raffaele Pignone (Servizio Geologico Regione Emilia-Romagna, Bologna) and Riccardo Polino (CNR, Torino) Acknowledgments: The 32nd IGC Organizing Committee is grateful to Roberto Pompili and Elisa Brustia (APAT, Roma) for their collaboration in editing. Graphic project: Full snc - Firenze Layout and press: Lito Terrazzi srl - Firenze P37_copertina_R_OK D 26-05-2004, 11:02:12 Volume n° 5 - from P37 to P54 32nd INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS HYDROGEOLOGY OF THE ISLAND OF SARDINIA (ITALY) AUTHORS: G. Barrocu, A. Vernier, F. Ardau (Editor), N. Salis, F. Sanna, M.G. Sciabica, S. Soddu (Università di Cagliari - Italy) Florence - Italy August 20-28, 2004 Post-Congress P37 P37_R_OK A 26-05-2004, 11:05:51 Front Cover: Su Gologone spring P37_R_OK B 26-05-2004, 11:05:53 HYDROGEOLOGY OF THE ISLAND OF SARDINIA (ITALY) P37 Leader: G. -

Nome Graziella Mellino Residenza Nule – SS Telefono +39.3496210273 E-Mail [email protected] Nazionalità Italiana Data Di Nascita 17/1/1967
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Graziella Mellino Residenza Nule – SS Telefono +39.3496210273 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 17/1/1967 ESPERIENZE LAVORATIVE • Date Da settembre 2008 ad oggi • Nome e indirizzo del datore Dasein S.r.l - Sardegna di lavoro Lungo Dora Colletta, 81 – Torino Sede locale: Oristano – Via Liguria, 22 • Tipo di azienda o settore Consulenza – Ricerca – Formazione Enti Locali • Tipo di impiego Lavoro dipendente a tempo indeterminato Principali Mansioni Consulente esperto nella gestione delle risorse umane , in particolare: • Gestione di sistemi di valutazione ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Enti Locali , in particolare riferiti alle posizioni organizzative (valutazione della posizione e del risultato) ed ai sistemi permanenti di valutazione ex art. 6, relativi alle prestazioni e alle progressioni del personale dell'Ente Locale • Attuale componente dei Nuclei di Valutazione nei seguenti comuni: Aritzo, Atzara, Baunei, Belvi, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Cardedu, Comunità Montana Mandrolisai, Consorzio Bimf, Flussio, Irgoli, Gadoni, Gairo, Gavoi, Jerzu, Lei, Lodè, Laconi, Lula, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Ollolai, Olzai, Onani, Orani, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Posada, Perdasdefogu, Sagama, San Teodoro, Sarule, Scano di Montiferro, Sennariolo, Seui, Sorgono, Talana, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Ulassai, Unione dei Comuni del Montalbo, Unione dei Comuni della Barbagia, Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Valutazione, esercizio 2012, ai sensi dell’art. 1 commi 39-40 della L. 190/2012, sulle motivazioni addotte dagli enti a giustificazione delle anomalie riscontrate nell’ambito della rilevazione sulle tipologie di lavoro flessibile di cui all’art. -
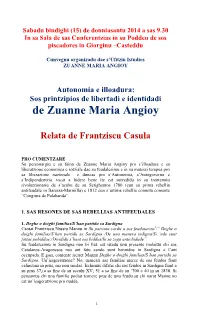
Cunvegnu De Sa CSS Subra Zuanne Maria Angioy.Rtf
Sabadu bindighi (15) de donniasantu 2014 a sas 9.30 In sa Sala de sas Cunferentzias in su Poddeu de sos piscadores in Giorginu –Casteddu Cunvegnu organizadu dae s’Ufitziu Istudios ZUANNE MARIA ANGIOY Autonomia e illoadura: Sos printzipios de libertadi e identidadi de Zuanne Maria Angioy Relata de Frantziscu Casula PRO CUMENTZARE Su personargiu e sa faina de Zuanne Maria Angioy pro s’illoadura e sa liberatzione economica e sotziale dae su feudalesimu e in su matessi tempus pro sa liberazione nazionale e duncas pro s’Autonomia, s’Autogovernu e s’Indipendentzia. tocat a bidere bene ite est sutzedidu in su trentenniu rivolutzionariu de s’acabu de su Setighentos 1780 (cun sa prima rebellia antifeudale in Baressa-Marmilla) e 1812 cun s’urtima rebellia connota comente “Congiura de Palabanda”. 1. SAS RESONES DE SAS REBELLIAS ANTIFEUDALES 1. Deghe o doighi familias/S’han partidu sa Sardigna Cantat Frantziscu Nassiu Mannu in Su patriota sardu a sos feudatarios 1:” Deghe o doighi familias/S’han partidu sa Sardigna /De una manera indigna/Si ‘nde sunt fattas pobiddas;/Divididu s’hant sas biddas/In sa zega antichidade”. Su feudalesimu in Sardigna non bi fiat: est istadu unu presente malaittu chi sos Catalanos-Aragonesos nos ant fatu cando sunt bennidos in Sardigna e l’ant occupada. E gasi, comente iscriet Mannu Deghe o doighi familias/S’han partidu sa Sardigna. Un’isageratzione? No, mancari sas familias meres de sos feudos fiant calincuna in prus, ma non medas. Ischimus difatis chi sos feudos in Sardigna fiant a su prus 37,(a sa fine de su seculu XV; 51 a sa fine de su ‘700 e 40 in su 1838. -

Genetic History from the Middle Neolithic to Present on the Mediterranean Island of Sardinia
ARTICLE https://doi.org/10.1038/s41467-020-14523-6 OPEN Genetic history from the Middle Neolithic to present on the Mediterranean island of Sardinia Joseph H. Marcus et al.# The island of Sardinia has been of particular interest to geneticists for decades. The current model for Sardinia’s genetic history describes the island as harboring a founder population that was established largely from the Neolithic peoples of southern Europe and remained 1234567890():,; isolated from later Bronze Age expansions on the mainland. To evaluate this model, we generate genome-wide ancient DNA data for 70 individuals from 21 Sardinian archaeological sites spanning the Middle Neolithic through the Medieval period. The earliest individuals show a strong affinity to western Mediterranean Neolithic populations, followed by an extended period of genetic continuity on the island through the Nuragic period (second millennium BCE). Beginning with individuals from Phoenician/Punic sites (first millennium BCE), we observe spatially-varying signals of admixture with sources principally from the eastern and northern Mediterranean. Overall, our analysis sheds light on the genetic history of Sardinia, revealing how relationships to mainland populations shifted over time. *A full list of authors and their affiliations appears at the end of the paper. NATURE COMMUNICATIONS | (2020) 11:939 | https://doi.org/10.1038/s41467-020-14523-6 | www.nature.com/naturecommunications 1 ARTICLE NATURE COMMUNICATIONS | https://doi.org/10.1038/s41467-020-14523-6 he whole-genome sequencing in 2012 of “Ötzi”, an indi- studies found evidence that Sardinia is a genetic isolate with vidual who was preserved in ice for over 5000 years near appreciable population substructure29–31. -

Centrale Unica Di Committenza Unione Dei Comuni Valle Del Cedrino C.F
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino C.F. CFAVCP-0000CD8 VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA SEDUTA del 27/03/2018 Verbale n. 1 Oggi, giorno 27-03-2018 ore: 09:12 in Orosei (NU), presso la Centrale Unica di committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino, viene esperita la procedura telematica per la gara: Interventi di manutenzione straordinaria del ponte della Marina di Orosei e della passerella pedonale in località Osalla - Comune di Orosei. Il seggio di gara è composto dai Signori: Presidente: Silvia Esca Si prende atto che la verbalizzazione viene effettuata in automatico dal sistema. Il Presidente fa presente che: a seguito della determinazione 49 del 08/03/2018 è stata indetta la gara Interventi di manutenzione straordinaria del ponte della Marina di Orosei e della passerella pedonale in località Osalla - Comune di Orosei attraverso un sistema di Gara Telematica, procedura aperta a busta chiusa con il criterio del prezzo più basso. Il Presidente fa presente che: entro le ore 09:00 del giorno 27-03-2018 sono state ricevute sulla piattaforma web unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it n. 17 offerte dalle seguenti Ditte: - Ditta: F.LLI CAPEDDU SRL rappresentata da CAPPEDDU GIAMPAOLO con sede legale VIA MARZABOTTO, 14 08025 OLIENA (NUORO) - Ditta: Impresa Edile Guiso Vincenzo rappresentata da Guiso vincenzo con sede legale Via brodolini 08100 Nuoro (Nuoro) - Ditta: Impresa Edile Dessena Giovanni rappresentata da dessena giovanni con sede legale Vico II G.Porru n.10 08028 orosei (Nuoro) - Ditta: Impresa -

Elenco Dei Medici Di Medicina Generale Operanti Nell'azienda
Elenco dei medici di Medicina Generale operanti nell’Azienda sanitaria di Nuoro Aggiornato al 30 aprile 2012 DISTRETTO di NUORO Cognome/Nome Sede Indirizzo Amb. Telefono Arnò Pietro Nuoro Via Gramsci, 81 347 1805327 Bacchiddu Giacobbe Nuoro Via Cagliari, 28 0784 38315/ 333 8508520 Sarule Via Trento Barca Mario Innocenzo 349 7337583 Olzai Via Taloro, 30 Orgosolo Corso Repubblica, 350 Battasi Maria Giovanna 349 6183999 Mamoiada c/o Ambulatorio ASL Boninu Antonio Nuoro Via Einaudi, 17 380 4255084 Cabras Pietro Nuoro Via Gorizia, 12 393 9057157 Caliandro Rosa Maria Nuoro viale Sardegna, 12 0784 30173 Bitti Via Musio, 12 Calzone Francesco 327 0517882 Osidda Piazza Bonapace Canu Gianfranco Nuoro Via Maga, 27/A 347 9462853/0784 230761 Canu Maria Grazia Nuoro Via Galilei, 13 340 8549929 Consoli Pasqua Nuoro Via Corsica, 15 333 7186326 Contena Caterina Orune Via Isonzo 0784 276605 - 333 2747055 Corbe Antonio Oliena viale Italia, 27 0784 288561 Cossu Francesca Nuoro Corso Garibaldi, 127 328 7699155 Cottu Maria Sarule Via Kennedy, 5 0784 76477 / 328 0308164 Cugusi Michela Fonni Via Eleonora, 2 0784 57776 Curreli Caterina Ollolai Via Nuoro, 9 0784 51402 / 338 8383557 Deiana Giuseppina Nuoro Via Milano, 1 0784 200138 Deledda Michelina Lula Via C. Battisti 333 6484160 Deriu Tonina Orani Via Lamarmora, 44 347 9372175 Deserra Antonio Dorgali Via Lamarmora, 50 0784 929110 Devaddis Maria G. Orgosolo Via Municipio 333 9617332 Ena Itria Bitti Via Fiume, 5 333 6050151 Fais Anna Rita Ottana Via Aldo Moro, 2 0784 75335 Fancello Antonio Nuoro Vico Biscollai,