Pubblicazione F.D. N. 32
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

5 JANUARY 12 Desmet.Pub
Holy Ground Exploring Catholic history in the Pacific Northwest PART 5: FATHER DE SMET GOES TO VANCOUVER JANUARY 12, 2020 rom the time of their arrival in Florissant, Missouri. He F in Vancouver at the end of struggled with his calling, and 1838, Father Blanchet and even left the Jesuits for a time to Father Demers had been on their serve as a diocesan priest back in own. They traveled incessantly Belgium. Ultimately De Smet through their vast territory, returned to the Jesuits and to the settling down at most for a few United States. He found his life’s months at a time to preach, work among the Native teach, and set up missions. They Americans. He was also an knew that to establish the extraordinary promoter of the Church in the west would missions, and crisscrossed the require stability—and that Atlantic many times, collecting meant they needed help. money and recruiting personnel Blanchet appealed to Archbishop to help build up the Church in Signay of Quebec, who agreed to the West. send a couple of young priests, With his stocky build, but found no way to get them DeSmet had been nicknamed there—the Hudson’s Bay “Samson” in his younger days. Company was not interested in He was strong, fearless, and providing transportation for any romantic—the perfect Father DeSmet photographed by Matthew Brady. From more Catholic priests, for Wikimedia Commons. combination for a missionary. reasons both practical and He was also a prolific writer, and political. his many books about his experiences in the west were In the summer of 1840, word reached the missionaries widely read. -
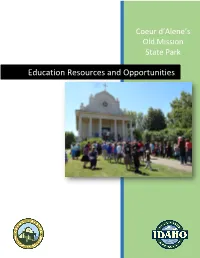
Education Resources and Opportunities
Coeur d’Alene’s Old Mission State Park Education Resources and Opportunities Coeur d’Alene’s Old Mission State Park Coeur d’Alene’s Old Mission State Park is home to Idaho’s oldest standing building, the Mission of the Sacred Heart or Cataldo Mission. The site has a long history associated with various groups, cultures, and religious beliefs. The main story told is the coming together of the Coeur d’Alene Tribe and Jesuit Missionaries. Together they built the Mission and a self-sustaining village with minimal tools and supplies. This story is unique to Idaho and an important part of the history of the Pacific Northwest. The site is sacred to many different people for many different reasons. The permanent exhibit Sacred Encounters: Father De Smet and the Indians of the Rocky Mountain West is housed within the park visitor center. This Smithsonian-quality exhibit includes video, displays, and artifacts from around the world. The history of the site is varied and a continuous story of life and historic events. Throughout its rich history, the mission has served many purposes: as a place of worship for Native people; a hospitality and supply station for settlers, miners and military personnel; a working farm; a disembarkation point for boats heading up the Coeur d’Alene River carrying miners and later railroad and pipeline workers; a Jesuit novitiate; a gathering place to sign treaties and resolve issues; and, the site of a labor dispute between union and non-union miners. Many colorful people, cultures and activities converged at this important spiritual, cultural and historic site. -
En Katastrof…
en katastrof…. Bok nr 1 Bertil Thörn * INDIANKLUBBEN Militärens version Bok nr 1 * Militärens version Bok nr 1 BBIGIG HHOOLEE BBAATTTLTELFEIEFLIEDL D HELIG MEN HEMSÖKT MARK FÖR HELIG MEN HEMSÖKT PLATS FÖR NEZ PERCEEFOLKET NEZ PERCEINDIANERNA HÄR DOG ETT HUNDRATAL INDIANER 1877 MÅNGA VAR KVINNOR OCH BARN KVARLEVORNA AV DE FLESTA FINNS ÄNNU KVAR HÄR 2 http://www.youtube.com/watch?v=PMEVav1Mixw för att se en 20 minuter film om Nez Percefolkets flykt klicka ovan Indianklubben, Helsingborg 2015 [email protected] 3 bok nr 1, militärens version ...en katastrof... Bertil Thörn En E-bok från INDIANKLUBBEN Helsingborg 2015 4 Överste / Brevet Major General John Oliver Gibbon (apr 20 1827 - febr 6 1896) Överste 7:th Infantry Regiment (tillhör Library of Congress) Hin-mah-too-yah-lat-kekht Thunder Traveling to Loftier Heights (Young Chief Joseph) (1840 - 1904) Wellamotkin Band of the Nez Perce Hin-mah-too-yah-lat-kekht (tillhör ”First People”) Thunder Traveling to Loftier Heights (Young Chief Joseph) (1840 - 1904) Wellamotkin Band of the Nez Perce (tillhör ”First People”) (www,firstpeople.us) En E-bok från INDIANKLUBBEN Helsingborg 2010 5 FÖRORD De sahaptian-talande nez perceindianerna, i västra Idaho, hade alltsedan de första gången såg vita människor, i form av upp- täckarna Lewis och Clark, varit vänligt inställda till de vita. Så länge landet var sparsamt befolkat av vita nybyggare gick allting bra. Det var huvudsakligen religiösa missionärer och tidiga päls- handlare som fann området intressant. Men så upptäcktes guld… Genast strömmade allehanda lycksökare till och politiker insåg snart att här kunde en samhällsbyggnad komma till stånd. -

January 2020 Covers.Pub
S. J C The Baptism of the Lord January 12, 2020 ORDER OF CELEBRATION FOR The Baptism of the Lord Celebration of the Sacrament of Baptism (Noon) PRELUDE Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684 Bach Freu dich sehr, o meine Seele Krebs ENTRANCE No. 412 in red Worship hymnal When John baptized by Jordan’s river RENDEZ A DIEU PENITENTIAL ACT St. James Mass for Peace Herbolsheimer WELCOMING OF THE CHILDREN TO BE BAPTIZED (Noon) GLORIA New Mass for Congregations Andrews Cantor or Choir: Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us; you take away the sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. OPENING PRAYER (COLLECT) e Liturgy of the Word FIRST READING Isaiah 42:1-4, 6-7 PSALM RESPONSE Psalm 29 Proulx SECOND READING Acts 10:34-38 ALLELUIA St. James Mass for Peace Herbolsheimer GOSPEL Matthew 3:13-17 HOMILY Father Michael G. Ryan RENEWAL OF BAPTISMAL PROMISES All respond: I do. SPRINKLING WITH BAPTISMAL WATER Alleluia, alleluia! Hurd PRAYER OF THE FAITHFUL Lord, we ask you, hear our prayer. Litany of Saints The Rite of Baptism (Noon) INTERCESSIONS AND LITANY OF SAINTS Lord, we ask you, hear our prayer. BLESSING OF BAPTISMAL WATER PROFESSION OF FAITH All join in the response, I do. ACCLAMATION FOLLOWING EACH BAPTISM Herbolsheimer Please, no applause following the baptisms. SPRINKLING WITH BAPTISMAL WATER Hurd ENTRANCE OF THE NEWLY BAPTIZED Please remain seated EXPLANATORY RITES Anointing with Chrism, White Garment Prayer, Presentation of a Lighted Candle e Liturgy of the Eucharist PREPARATION OF THE ALTAR AND THE GIFTS Offertory (10:00) Jesus autem hodie When Jesus Christ baptised was, the Holy Spirit descended with grace; Hallock The Father’s voice was heard in the place: This is my beloved Son: Hear him. -
Education Resources and Opportunities
Coeur d’Alene’s Old Mission State Park Education Resources and Opportunities Coeur d’Alene’s Old Mission State Park Coeur d’Alene’s Old Mission State Park is home to Idaho’s oldest standing building, the Mission of the Sacred Heart or Cataldo Mission. The site has a long history associated with various groups, cultures, and religious beliefs. The main story told is the coming together of the Coeur d’Alene Tribe and Jesuit Missionaries. Together they built the Mission and a self-sustaining village with minimal tools and supplies. This story is unique to Idaho and an important part of the history of the Pacific Northwest. The site is sacred to many different people for many different reasons. The permanent exhibit Sacred Encounters: Father De Smet and the Indians of the Rocky Mountain West is housed within the park visitor center. This Smithsonian-quality exhibit includes video, displays, and artifacts from around the world. The history of the site is varied and a continuous story of life and historic events. Throughout its rich history, the mission has served many purposes: as a place of worship for Native people; a hospitality and supply station for settlers, miners and military personnel; a working farm; a disembarkation point for boats heading up the Coeur d’Alene River carrying miners and later railroad and pipeline workers; a Jesuit novitiate; a gathering place to sign treaties and resolve issues; and, the site of a labor dispute between union and non-union miners. Many colorful people, cultures and activities converged at this important spiritual, cultural and historic site. -

Sur Les Traces De Deux Frères Baldersheimois Partis Dans Le Far
Sur les traces de deux frères baldersheimois partis dans le Far West Rares sont les Baldersheimois ayant décidé d’immigrer vers l’Amérique pendant la période de Grande Immigration après la Guerre de Sécession (1861-1865). Ils se comptent sur les doigts d’une main. Très récemment, nous avons pu en ajouter deux à cette courte liste. Il s’agit de deux frères nés tous deux à Baldersheim au mitan du XIXe siècle : Aloïse Boltz (1847-1924) et Pierre Boltz (1844-1922). Une tombe qui intrigue C’est en faisant une recherche sur le site internet américain Find a grave que j’ai découvert par hasard une pierre tombale qui a attiré tout de suite mon attention. Elle se trouve au St-Marys Cemetery de Stevensville dans le comté de Ravalli dans l’état du Montana à la frontière canadienne. Le patronyme Boltz très répandu à Baldersheim au XIXe siècle a éveillé ma curiosité. Par ailleurs il m’a paru surprenant que les prénoms Aloïse et Pierre soient orthographiés à la française sur une tombe américaine. Les dates de naissances très rapprochées laissent présager qu’il pourrait s’agir d’une fratrie. Je décide d’en avoir le cœur net et consulte l’état civil de Baldersheim sans grand espoir. Surprise ! Il existe bel et bien deux frères Boltz prénommés Pierre et Aloïse, nés respectivement le 7 septembre 1844 et le 17 juillet 1847, fils de Pierre Boltz journalier et de Catherine Schwob. Or la tombe indique 1848 comme date de naissance pour Aloïse. Ce pourrait-il que les pompes funèbres aient fait une erreur en se basant sur l’âge au décès pour calculer une date de naissance approximative ? Nos deux américains enterrés dans l’ouest américain peuvent-ils correspondre aux deux Baldersheimois ? Je décide de poursuivre l’enquête pour vérifier mon hypothèse. -

Palisades Project History
Palisade Project Wm. Joe Simonds Bureau of Reclamation 1995 Table of Contents The Palisades Project...........................................................2 Project Location.........................................................2 Historic Setting .........................................................3 Pre-History.......................................................3 History..........................................................4 Project Authorization.....................................................8 Construction History .....................................................8 Investigations.....................................................8 Construction......................................................9 Post-Construction History................................................20 Settlement of Project Lands ...............................................21 Uses of Project Water ...................................................21 Conclusion............................................................22 About the Author .............................................................22 Bibliography ................................................................23 Manuscript and Archival Collections .......................................23 Government Documents .................................................23 Articles...............................................................23 Books ................................................................23 Interviews.............................................................23 -

19Th Century Missions and Missionary Writing in The
TH 19 CENTURY MISSIONS AND MISSIONARY WRITING IN THE CANADIAN NORTHWEST GENERAL BIBLIOGRAPHY PRIMARY SOURCES Anderson, David. The Seal of Apostleship an Ordination Sermon Preached at St. Andrew’s Church, Red River, on Sunday, December 22, 1850. London: T. Hatchard, 1851. ------. A Charge Delivered to the Clergy of the Diocese of Rupert’s Land, in St. John’s Church, Red River, at His Triennial Visitation, January 6, 1860. London: Hatchard, 1860. Anderson, David, and John Horden. [A Pastoral Letter in the Moosonee Dialect of Cree. Translated by John Horden. Moose: Printed by J. Horden, 1855. Beaver, Herbert. Edited by Thomas E. Jessett. Reports and Letters of Herbert Beaver, 1836-1838: Chaplain to the Hudson’s Bay Company and Missionary to the Indians at Fort Vancouver. Portland, Ore.: Champoeg Press, 1959. Blake, S. H. The Missionary Society of the Church of England in Canada Memorandum for the Rev. Dr. Tucker. [Canada?: S.n.], 1995. Blanchet, Francis Norbert. Scenes de l’Histoire de l’Eglise Catholique en Oregon, 1838-1850/Fancois-Norbert Blanchet. Suivies de Journal de l’Eveque de Walla Walla, 1847-1851/ Augustin-Magloire Blanchet. Rimouski, Quebec: Association des Familles Blanchet, 1996. Blanchet, Francis Norbert, Modeste Demers, and Oregon Historical Society. Notices & Voyages of the Famed Quebec Mission to the Pacific Northwest Being the Correspondence, Notices, Etc. of Fathers Blanchet and Demers, Together with Those of Fathers Bolduc and Langlois Containing Much Remarkable Information on the Areas and Inhabitants of the Columbia, Walamette, Cowlitz and Fraser Rivers... Portland: Oregon Historical Society, 1956. Blanchet, François Xavier, and Missionnaire canadien. Dix Ans sur la Côte Du Pacifique.