Xx Leghe Sot To
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
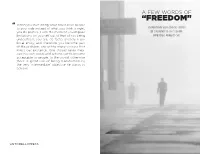
“FREEDOM” “ When You Start Doing What Could Drive People to Your Side Instead of What You Think Is Right, an Interview with Alfredo Cospito You Do Politics
A FEW WORDS OF “FREEDOM” “ When you start doing what could drive people to your side instead of what you think is right, AN INTERVIEW WITH ALFREDO COSPITO you do politics. From the moment you impose BY CONSPIRACY OF CELLS OF FIRE limitations on yourself out of fear of not being IMPRISONED MEMBERS CELL understood, you are, de facto, already a po- litical entity, and therefore you become part of the problem, one of the many cancers that infect our existence. One should never mea- sure his own words and actions just to become acceptable to people, to the crowd, otherwise there is great risk of being transformed by the very ‘intermediate’ objective he wants to achieve. UNTORELLI PRESS A conversation between the Conspiracy of Cells of Fire - Imprisoned Members Cell and anarchist prisoner Alfredo Cospito: from the Greek prisons to AS2 unit of the prison of Ferrara. Originally published on RadioAzione, 2014. Translated for Inter Arma by Nihil Admirari. This edition published April 2017 by Untorelli Press. UNTORELLI PRESS [email protected] UNTORELLIPRESS.NOBLOGS.ORG 20 A FEW WORDS OF “FREEDOM” today the incarnation of this “new anarchy”. efore answering your questions, I’d like to stress that what I’m about to say The time has arrived to acknowledge that we are different, that an abyss di- is my own truth. One of the many points of view, sensitivities and individual vides us from the old anarchism. We have no space for the great illusions: revolution, Bnuances within that crucible of thought and action that goes under the name progress, civilization. -

Willful Disobedience Volume 2, Number 12
Library.Anarhija.Net Willful Disobedience Volume 2, number 12 Various Authors Various Authors Willful Disobedience Volume 2, number 12 2001 Retrieved on September 1, 2009 from www.geocities.com lib.anarhija.net 2001 Contents A Few Words: Developing Relationships of Affinity 4 From Proletarian to Individual: Toward an Anarchist Un- derstanding of Class 8 Against the Logic of Submission: The Subversion of Existence 14 An Open Letter to Those Involved in the Black Bloc 19 Anti-Militarism and Social Insurrection 23 Rebellion in Argentina 26 Of Holy and Democratic Inquisitions 29 What is Seen Through a Keyhole 32 Children’s Thoughts by Massimo Passamani 33 Italian Anarchist Killed in Prison 35 Horst, a Life for Anarchy . 36 September 11: What the Masters Want to Teach Us 38 Shorts 41 Why Democracy ....................... 41 Clashes at the EU Summit . 41 Live Free or Die ....................... 42 2 Killing God .......................... 43 My Perspectives 44 3 dividual acts into “the collective struggle for individual realization”, which I see as the real class struggle. Since this aim of freeing every individual to be able to create her or his life as s/he sees fit requires that everyone have equal access to all that is necessary for this project of self-realization, it is neces- A Few Words: Developing sary to destroy the institutions that prevent this free access. Thus, the destruction of the institutions of property and of commodity ex- Relationships of Affinity change, and consequently of work — that separation of the activity through which one gets the necessities of existence from life itself “Today the spirit drowns in a mass of chance encoun- — is a necessary aim of revolutionary struggle. -

Conspiracy of Cells of Fire
In the chaos of our own existence we are a part of the impon- The vertical line of segregation becomes clear when the state imports its derable element which organizes subversion, plans mutinies, repressive violence into this struggle, every time when the terms or even the that leave even ourselves dazed. The translation of texts, letters, whole of the social contract are disputed. communiqués, etc. so that comrades in other countries around the world can read about the desires and ideas and projectuality This is where (contrary to other fronts of the social war) the existence of this of the comrades in Greece, is one more weapon at our disposal. fundamental community cannot but be proven. What began as a simple desire and a challenge, has brought us into a new field of experiences, acquaintances and responsibili- In the name of consistency of values, words and action but also from the fact ties. Now that we’re here, they will not get rid of us easily. that, whether we like it or not, authority will not forget, investing its We have become another aspect of the asymmetric threat. individual victories to improve its place in the social war. The war to the end, has already begun. The moment a charge (real or fabricated) is pronounced for a political action A fundamental element in this war is solidarity. (whether it is an expression of belief or for armed struggle) a clash begins. To remain a spectator, unfortunately, does not mean that “you are not getting Extract of the text ‘About Solidarity’ by the Assembly involved”. -

Few Words of Freedom
A Few Words of ”Freedom” Interview by CCF – Imprisoned Members Cell with Alfredo Cospito Alfredo Cospito, Conspiracy of Cells of Fire July 2014 INTERVISTA CCF/ALFREDO COSPITO From the Greek prisons to AS2 unit of the prison of Ferrara: a few words of “freedom”. Interview by CCF to myself. Before answering your questions, I’d like to stress that what i’m about to say is my own truth. One of the many points of view, sensitivities and individual nuances within that crucible of thought and action that goes under the name of FAI-FRI. Informal federation that, rejecting any hegemonic temptation, represents a tool, a method of one of the components of anarchism of praxis. Anarchism of praxis that only when it is informal, without being forced into organizational structures (specific, formal, of synthesis) when it doesn’t seek the unbearable consent (therefore rejects politics) it can be recognized in a wider chaotic universe called “black international”. To understand this better, FAI-FRI is a methodology of action that only some of thesisters and brothers of the black international practice, it’ s not an organization nor a simple collective signature, but a tool that aims towards efficiency, whose objective is to reinforce cells andeach comrade of praxis through a pact of mutual support based on three key points: revolutionary solidarity, revolutionary campaigns, communication between groups or individuals: REVOLUTIONARY SOLIDARITY Each group of action in the Anarchist Informal Organization is engaged in showing revolutionary solidarity to comrades who are arrested or are on hiding. This solidarity will show itself mainly through armed action and the attack against men and structures responsible for the imprisonment of comrades. -

Listado De Todos Los Recursos De La Biblioteca
Listado de todos los Recursos de la Biblioteca Biblioteca: LA BIBLIO (Agrupado por: Temas, Ordenado por: Titulo) <<Aplicación sin registrar>> Num_Reg Título Soporte Autor Editorial Signatura Idioma Fecha_Reg * Temas ARTE/CINE/MUSIC 1211 2000 2009 HAMAR URTEZ ERTZ LIBRO VARIOS A VAR 200 CAST 08/01/2013 2062 ALAIN BADIOU PEQUEÑO PANTEON PORTATIL LIBRO VARIOS BRUMARIA A VAR ALA CAST 05/05/2013 1476 ARTE EN LA TIERRA 2006 LIBRO VARIOS GOBIERNO DE LA A VAR ART CAST 1477 ARTE EN LA TIERRA 2007 LIBRO VARIOS GOBIERNO DE LA A VAR ART CAST 1478 ARTE EN LA TIERRA 2011 LIBRO VARIOS GOBIERNO DE LA A VAR ART CAST 1475 ARTE JOVEN LIBRO VARIOS JUNTA DE A VAR ART CAST 2056 ARTE MAQUINAS TRABAJO Y MATERIAL LIBRO VARIOS BRUMARIA A VAR ART CAST 05/05/2013 1237 ARTE PRECOLOMBINO LIBRO GRACIELA DRAGOSKI CENTRO EDITORA VAR ART CAST 10/01/2013 2055 ARTE Y TERRORISMO LIBRO VARIOS BRUMARIA A VAR ART INGL 05/05/2013 2058 ARTE Y TRANSICION LIBRO VARIOS BRUMARIA A VAR ART CAST 05/05/2013 1483 AUN APRENDO LIBRO FELIX REYES MUSEO WURTH A REY AUN CAST 1229 BASURA LIBRO RICARDO QUIÑONES FUNDACION A QUI BAS CAST 10/01/2013 1221 CARLOS CORTEZ EXPOSICION LIBRO VARIOS FUNDACION A VAR CAR CAST 10/01/2013 1220 CARLOS CORTEZ EXPOSICION LIBRO VARIOS FUNDACION A VAR CAR CAST 10/01/2013 1482 CIELO Y TIERRA LIBRO ROSA CASTELLOT CICCA A CAS CIE CAST 1197 CLASICA LIBRO FRANCISCO CAMINO DEBOLSILLO A CAM CLA CAST 08/01/2013 1474 COMO ESTA AFRICA? ARTE Y CENSURA LIBRO VARIOS AULA DE A VAR COM CAST 1838 COMO HACER MEJORES FOTOS LIBRO VARIOS KODAK A VAR COM CAST 21/03/2013 1606 COMO RECONOCER -

Public History, Private Memories: Historical Imagination in the New Italian Cinema 1988-1999
NOTE This online version of the thesis has slightly different page formatting from the print version held in Griffith University Library. The content is otherwise exactly the same. Public History, Private Memories: Historical imagination in the New Italian cinema 1988-1999 Tiziana Ferrero-Regis 2003 Public History, Private Memories: Historical imagination in the New Italian cinema 1988-1999 Tiziana Ferrero-Regis B.A. (Honours) Film, Media and Cultural Studies, Griffith University Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy February, 2003 i Abstract The concern with the following arguments started during a study of national and international cinemas, from the desire to account for a cinema that internationally was doing well, but was undervalued domestically. The aims were to account for the renewal of Italian filmmaking from 1988, the New Italian cinema, and understand the conditions behind this renewal. The thesis identifies in the historical theme and in the recurrence of features from Italian cinema history elements of coherence with previous cinema production. The first consideration that emerges is that a triangulation between a new generation of filmmakers, their audience and recent history shaped the recovery of Italian cinema from 1988. A second consideration is that no discussion of Italian cinema can be separated from a discussion of that which it represents: Italian society and politics. This representation has not only addressed questions of identity for a cohort of spectators, but on occasions has captured the attention of the international audience. Thus the thesis follows a methodologic approach that positions the texts in relation to certain traditions in Italian filmmaking and to the context by taking into consideration also industrial factors and social and historical changes. -
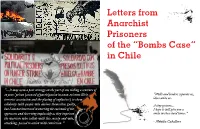
Letters from Anarchist Prisoners Of
Letters from Anarchist N Prisoners of the “Bombs Case” in Chile “...It may seem a poor strategy on the part of one risking a sentence of 20 years’ prison (accused of participation in a non-existent illicit “Walls and borders separate us, terrorist association and the placing of explosives) to show ideas unite us. solidarity with people who declare themselves guilty, A tiny gesture… but I am not interested in entering the rationale of the I hope it will give you a oppressors and observing implacably as they imprison smile in these hard times.” the warriors who collide with this society and who, K - Mónika Caballero attacking,34 passed to action with conviction.” This document is a collection of letters from the Chilean anarchist “Bombs Case” prisoners, in an effort to share and spread their ideas beyond the prison walls. On August 14th, 2010, fourteen anarchists and anti-authoritarians were arrested in a series of raids in Santiago in what became known as the `Bombs Case`. They were accused of a series of bombings against capital and the state that took place around Santiago in the previous years, as well as of “criminal conspiracy” under the Pinochet-era Anti-Terrorist Laws. Since then, fol- lowing a hunger strike by the prisoners, as well as countless solidarity actions from around the world, the charges against nine of the accused have been dropped (one of these people is facing other charges in a separate trial), but charges against five comrades remain. They are: Omar Hermosilla and Carlos Riveros, accused of providing the money to finance the costs of the attacks, as well as Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar, accused of the placement of the explosive devices at different points in Santiago. -

The Marini Trial
Various Authors The Marini Trial 2002 The Anarchist Library Contents Introduction.............................. 3 A Summary of the Marini Trial and Related Events ....... 3 1 Documents Regarding the Arrest and Trial of the Four An- archists Charged with Bank Robbery............... 13 In Respect of the Law ........................ 13 No Act of Revolt is Futile...................... 14 Declaration of the Arrested Anarchists............... 15 To Those Without Judgment .................... 16 2 Documents Relating to the Marini Investigation . 17 Frame-Up............................... 17 Guilty of Solidarity: More police constructions and searches at the expense of anarchists....................... 20 To the Men and Women of Courage ................ 20 Against the New Inquisition..................... 21 Everywhere.............................. 22 Uncontrollables............................ 23 Repentance is for Sale in the Law’s Bazaar ............ 24 A Letter from Guido Mantelli and Roberta Nano......... 24 3 Documents Concerning Related Events.............. 26 Statement about the Attack on the Italian Vice-Consulate in Malaga, Spain............................. 26 Statement of Silvano from Bussoleno................ 27 Soledad is Dead. No Celebrations Please. ............. 28 A Statement ............................. 29 For a World Without Jackals .................... 29 Strategies of Repression ....................... 30 Revolutionary Solidarity: A Challenge............... 32 2 Introduction Those who rebel consciously against the ruling order, -

Listado De Todos Los Recursos De La Biblioteca
Listado de todos los Recursos de la Biblioteca Biblioteca: LA BIBLIO (Agrupado por: Temas, Ordenado por: Signatura) <<Aplicación sin registrar>> Num_Reg Título Soporte Autor Editorial Signatura Idioma Fecha_Reg * Temas ARTE/CINE/MUSIC 1232 GOYA: PINTURAS NEGRAS LIBRO VALERIANO BOZAL ALIANZA A BOZ GOY CAST 10/01/2013 1197 CLASICA LIBRO FRANCISCO CAMINO DEBOLSILLO A CAM CLA CAST 08/01/2013 1482 CIELO Y TIERRA LIBRO ROSA CASTELLOT CICCA A CAS CIE CAST 1206 MICHELANGELO ANTONIONI LIBRO SEYMOUR CHATMAN PAUL DUNCAN A CHA MIC CAST 08/01/2013 1606 COMO RECONOCER EL ARTE BARROCO LIBRO FLAVIO CONTI EDUNSA A CON BAR CAST 06/02/2013 2064 DECONSTRUYENDO LAS INSTALACIONES LIBRO GRAHAM COULTER-SMITH BRUMARIA A COU DEC INGL 05/05/2013 1239 IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI LIBRO GUY DEBORD AL MARGEN A DEB GIR CAST 10/01/2013 1837 TECNICA FOTOGRAFICA LIBRO ANTOINE DESILETS DAIMON A DES TEC CAST 21/03/2013 2648 DALI INTIMO LIBRO FUNDACION CIRCULO DE A FUN DAL CAST 2146 CUBA Y SUS SONES LIBRO NATALIO GALAN PRE-TEXTOS A GAL CUB CAST 16/06/2013 1231 PINTURA CONTEMPORANEA LIBRO JULIAN GALLEGO SALVAT A GAL PIN CAST 10/01/2013 1228 VIAJE INTERIOR (EXPOSICION OLEOS) LIBRO JUAN ANTONIO GASPAR AYT. SORIA A GAS VIA CAST 10/01/2013 1194 EL POP DESPUES DEL FIN DEL POP LIBRO PABLO GIL RDL A GIL POP CAST 08/01/2013 1208 SACAR LA LENGUA LIBRO GUNTER GRASS CIRCULO DE A GRA SAC CAST 08/01/2013 1331 EL POP ART LIBRO LUCY R. LIPPARD DESTINO A LIP POP CAST 15/01/2013 1195 JOHN CARPENTER. -

Willful Disobedience Volume 2, Number 12
Willful Disobedience Volume 2, number 12 Various Authors 2001 Contents A Few Words: Developing Relationships of Affinity 3 From Proletarian to Individual: Toward an Anarchist Understanding of Class 6 Against the Logic of Submission: The Subversion of Existence 10 An Open Letter to Those Involved in the Black Bloc 13 Anti-Militarism and Social Insurrection 16 Rebellion in Argentina 18 Of Holy and Democratic Inquisitions 21 What is Seen Through a Keyhole 23 Children’s Thoughts by Massimo Passamani 24 Italian Anarchist Killed in Prison 26 Horst, a Life for Anarchy .......................... 27 September 11: What the Masters Want to Teach Us 28 Shorts 30 Why Democracy ............................... 30 Clashes at the EU Summit .......................... 30 Live Free or Die ............................... 31 Killing God .................................. 31 My Perspectives 33 2 A Few Words: Developing Relationships of Affinity “Today the spirit drowns in a mass of chance encounters. We are look- ing for those who are still alive enough to support each other beyond this; those fleeing Normal Life.” — Against Sleep and Nightmare We live in a society in which most of our encounters have already been defined in terms of predetermined roles and relationships in which we have no say. A randomness devoid of surprise surrounds the scheduled torment of work with a “free time” lacking in joy, wonder or any real freedom to act on one’s own terms, a “free time” not so very different from the job from which it is supposed tobea respite. Exploitation permeates the whole of existence as each of our interactions is channeled into a form of relating that has already been determined in terms of the needs of the ruling order, in order to guarantee the continued reproduction of a society in which a few control the conditions of everyone’s existence and so own all of our lives. -
Catálogo De Prensa Libertaria Y Anarcosindicalista En España (1976-2005)
CATÁLOGO DE PRENSA LIBERTARIA Y ANARCOSINDICALISTA EN ESPAÑA (1976-2005) AUTOR: CARLES SANZ Título: A AMSTERDAM Subtítulo: Editor: Iniciativa Ciudadana. CGT LugarPub: Madrid AñosPub: 1997 Periodic: 5 (abr 1997) Nº Pag: DescFis: Presenta: Observac: Boletín de marcha europea contra el paro y la exclusión social. Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar. Bibliograf: Catálogo Biblioteca Al Margen (BAAM). Título: A LA CALLE/AL CARRER Subtítulo: Órgano de la.. (desde el nº 4 "Órgan d'expressió de la..."; a partir del nº 6 se añade "Butlletí Anarquista") Editor: Federación Regional Sud-Este F.I.J.L. (desde el nº 4 "Federació SudEst de Joventuts Llibertàries F.I.J.L) LugarPub: Valencia AñosPub: 1997?-2000? Periodic: 1 (s/f 97?) 2 (s/f 97?) 3 (98) 4 (s/f 98?) 5 (s/f 99) 6 (s/f 99?) 7 (s/f 99?) 8 (s/f 00?) 9 (s/f 02?) Idioma: castellano y a partir del nº 4 algunos articulos en catalán Dirección: A.C. 1929 NºPag: 40, 40, 32, 32, 32, 4 y 30 respect DescFís: 14,7 x 21 Presenta: fotocopia con ilustraciones, el nº 6 y el 8 con tapas acartulinadas en color rojo Colabor: Mikcjo, Floreal Castilla, François Degoul, David V., Iñaky Alvero, Raul M. Resumen: El nº 1, pasividad, internet, socialismo libertario, anarquismo, cárceles, reproducción del texto de Malatesta "En el café" de 1897 que se entrega por capitulos en cada número, esperanto (con texto en ese idioma), muerte de un insumiso en Zaragoza. El nº 2, contra las guerras, juventudes libertarias de Venezuela, sobre el termino marxismo, prostitución, temas legales de detención. -
Catalogo Libri Per Autori
Circolo Culturale Anarchico Gogliardo Fiaschi Catalogo libri per Autore Carrara ZIC - ZeroInCondotta AUTORE TITOLO EDITORE 1 A. CARDELLA L. FENECH ANNI SENZA TREGUA ZIC 2 A. J. CAPPELLETTI L'IDEA ANARCHICA ZIC 3 AA.VV RIVOLUZIONE SPERIMENTI 4 AA.VV. LE FORZE ARMATE IN ITALIA LA RIVOLTA 5 ABEL PAZ VIAIE AL PASADO E A 6 ABEL PAZ CHUMBERAS Y ALACRANES E A 7 ABEL PAZ LE 30 ORE DI BARCELLONA LA COOP. TIPOLITOGRAFICA 8 ABEL PAZ VOL. 1 DURRUTI E LA RIVOLUZIONE SPAGNOLA BFS 9 ABEL PAZ VOL. 2 DURRUTI E LA RIVOLUZIONE SPAGNOLA BFS 10 ADELE FACCIO IL REATO DI MASSA SUGARCO EDIZIONI 11 ADRIANA CANORI BRILASTECHI R P E 12 AGENCIA DE NOTICIAS L!ALTRA CAMPAGNA E LA LOTTA DI CLA LA PIRATA 13 ALAIN BIHR DALL'ASSALTO AL CIELO ALL'ALTERN. BFS 14 ALBERTO GIORGETTI DI MAGENTA E DI COREA BFS 15 ALBERTO MESCHI VA LA CONFEDERAZIONE VARI 16 ALBERTO PICCITTO MACNOVICINA ZIC 17 ALESSANDRO MARIANELLI MOVIMENTO OPERAIO BFS 18 ALETE DEL CANTO IL CULTO E LE SACRE RELIQUIE ANTEO 19 ALEXANDRE SKIRDA GLI ANARCHICI RUSSI I SOVIET CP EDITRICE 20 ALFREDO M. BONANNO ASTENSIONISMO ELETTORALE ANARCHICO LA RIVOLTA 21 ALFREDO M. BONANNO SICILIA SICILIA PUNTO L. 22 ALFREDO M. BONANNO LA GIOIA ARMATA ANARCHISMO 23 ALFREDO M. BONANNO DISSONANZE EDIZIONI ANARCHISMO 1/24 Circolo Culturale Anarchico Gogliardo Fiaschi Catalogo libri per Autore Carrara ZIC - ZeroInCondotta AUTORE TITOLO EDITORE 24 ALFREDO M. BONANNO LECCACULI E DELINQUENTI LA FIACCOLA 25 ALIBRANDO GIOVANETTI IL SINDACALISMO RIVOLUZIONARIO ZIC 26 ALLEANZA OP. ANARCHICA ANARCHIA VARI 27 AMEDEO BARTOLO DEMOCRAZIA E OLTRE VOLONTA 28 ANA DELSO TRECENTO UOMINI E IO ZIC 29 ANARCHICI SARDI NUOVA INQUISIZIONE E RIBELLIONE VARI 30 ANARCHICI SICILIANI GLI ANARCHICI E IL REFERENDUM LA RIVOLTA 31 ANDRE BOSIGER SOUVENIRS D'UN RIBELLE VARI 32 ANDREA PAPI PER UN NUOVO UMANESIMO ANARCHICOZIC 33 ANDREA STAID GLI ARDITI DEL POPOLO LA FIACCOLA 34 ANDY ANDERSON UNGHERIA 56 ZIC 35 ANGELO BARACCA I NUCLEODOLLARI C.