Poggiomarino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Long-Term Analysis of Passenger Flows on a Regional Rail Line
C. Caropreso et al., Int. J. Transp. Dev. Integr., Vol. 1, No. 3 (2017) 329–338 A LONG-TERM ANALYSIS OF PASSENGER FLOWS ON A REGIONAL RAIL LINE C. Caropreso, C. DI Salvo, M. Botte & L. D’ACIERNO Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering, Federico II University of Naples, Italy. Abstract Promoting rail systems can represent a useful policy for rebalancing modal choices and reducing pri- vate car use, especially in high-density contexts. Obviously, an increase in passenger numbers is only possible if generalized costs (i.e. a weighted sum of times and monetary costs) associated to public transport are abated. According to the recent literature and current professional practice, most strategies for achieving this objective are based only on infrastructural interventions which may be unfeasible or inadequate in densely populated contexts. Likewise, the adoption of policies based on replacing exist- ing fleets or reducing fare levels entails increases in national or regional subsidies, which would be difficult to achieve in the current economic climate. Hence, our proposal is based on investigating effects on travel demand arising from the replacement or upgrading of existing signalling systems (both in terms of trackside and on-board equipment). In- deed, the recent European Union policy to create a single transnational interoperable rail network im- poses the development of innovative signalling systems. In this context, since cost–benefit analysis has to be implemented to verify the economic and environmental feasibility of the proposed intervention strategy, an appropriate method should be developed to estimate passenger flows according to future configurations. In this article, we propose a method to determine travel demand in current and future contexts by appropriately processing data from Italy’s national census on mobility, population growth forecasts and turnstile counts. -

Movimenti Interprovinciali in Uscita
SMOW5B 01-06-13PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : NAPOLI ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013/14 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI - CLASSI COMUNI 1. AGUECI LUCIA GIOVANNA . 8/ 7/55 (MI) DA : NAAA133002 - ERCOLANO 2 - VIA SEMMOLA - (ERCOLANO) A : REAA83700C - ISTITUTO COMPR. CASTELLARANO (CASTELLARANO) PUNTI 106 2. AMITRANO MARIA GRAZIA . 28/ 2/66 (NA) DA : NAAA8AF00A - NA - I.C. VIRGILIO IV (NAPOLI) A : RMAA867006 - STATALE "PUBLIO VIBIO MARIANO" (ROMA) PUNTI 39 3. ASCIONE IMMA . 27/ 2/75 (BS) DA : NAAA039004 - NA 39 - G. LEOPARDI (NAPOLI) A : SAAA83400A - IST.COMPR. AMALFI (AMALFI) PUNTI 40 4. ASSARDO STEFANIA . 16/ 4/69 (NA) DA : NAAA000VE6 - PROVINCIA DI NAPOLI A : LTAA84300E - I.C. V. ORSOLINI CENCELLI (SABAUDIA) SU CLASSE SPECIALE : AD INDIRIZZO DIDATTICO AGAZZI PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I PUNTI 27 5. BATTISTA ESTERINA . 7/ 4/78 (CE) DA : NAAA8F400Q - S. ANTIMO 3 - D. LORENZO MILANI (SANT'ANTIMO) A : CEAA046009 - D. D. ORTA DI ATELLA (ORTA DI ATELLA) PUNTI 77 6. BIANCHI DORA . 5/ 4/78 (BN) DA : NAAA8BD009 - NA - IC MASSIMO TROISI (NAPOLI) A : BNAA84900P - I.C. PONTE (PONTE) PUNTI 67 7. BIFULCO ANTONIETTA . 10/12/68 (NA) DA : NAAA8F8003 - NA IC RADICE SANZIO AMMATURO (NAPOLI) A : PAAA003006 - ARCULEO ETTORE (PALERMO) PUNTI 63 SMOW5B 01-06-13PAG. -

Società Con Socio Unico Soggetta All’Attività Di Direzione E Coordinamento Di Ferrovie Dello Stato S.P.A
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 20 settembre 2005 ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. U.O. Procedure Autorizzazione ed Espropriative - il Dirigente Dott. M. VECCIA – Via Mantova, 1 - 00198 Roma - Espropriazione per pubblica utilità sul progetto esecutivo per il Completamento delle Opere Civili ex Lotto “B” della Nuova Linea a Monte del Vesuvio, nei Comuni di S. Anastasia, Somma Vesuviana, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Striano in Provincia di Napoli e di S. Valentino Torio in Provincia di Salerno. Avviso ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 e succ. modif. per espropriazione per pubblica utilità , pubblicato dalla Società Italferr S.p.A. in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sul sito della Regione Campania - ed indirizzato ai proprietari, secondo le risultanze catastali, soggetti ad esproprio o ad asservimento ai fini della Proroga della Dichiarazine di Pubblica Utilità, di cui alla Delibera n. 68/2000 di F.S. S.p.A. - sul progetto esecutivo per il Completamento delle Opere Civili ex Lotto “B” della Nuova Linea a Monte del Vesuvio, nei Comuni di S. Anastasia, Somma Vesuviana, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Striano in Provincia di Napoli e di S. Valentino Torio in Provincia di Salerno. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ Oggetto: Nuova Linea a Monte del Vesuvio. Completamento delle Opere Civili ex Lotto “B”. Proroga della Dichiarazione di Pubblica Utilità: Referente di Progetto – Zona Territoriale Tirrenica Sud - Divisione Infrastruttura – Delibera di F.S. -

Delibera N.84 Del 05/04/2013
COMUNE DI PALMA CAMPANIA Provincia di Napoli Piazza Mercato - 1930 PRELIMINARE DI PIANO DOCUMENTO STRATEGICO (Regolamento n.5/2011 di attuazione Lr 16/2004) Firma Progettista - Resp. Servizio Urbanistica Comune Palma Campania dott. arch. Bruno Giaquinto Sindaco Assessore all'urbanistica Vincenzo Carbone Michele Graziano Cartografia: Fotogrammi digitali eseguiti in data agosto 2010 marzo 2013 Preliminare di piano – RELAZIONE Comune di PALMA CAMPANIA PRELIMINARE DI PIANO DOCUMENTO STRATEGICO (Regolamento n.5/2011, art. 2, comma 4). PROIEZIONI URBANISTICO-TERRITORIALI RELAZIONE SOMMARIO 1. PREMESSA 1 2. LE SCELTE STRATEGICHE 3. AZIONI DI TUTELA 4. AZIONI DI SVILUPPO 5. AZIONI DI RISPOSTA AI FABBISOGNI 6. AZIONI PER IL TERRITORIO AGRICOLO 7. AZIONI PER IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ Preliminare di piano – RELAZIONE Comune di PALMA CAMPANIA RELAZIONE 1. PREMESSA Il comune di Palma Campania è dotato di un piano regolatore generale (Prg) approvato nel 1990. L’Ac ha intrapreso un percorso partecipato per la redazione del piano urbanistico comunale (Puc), consistente nella preventiva formazione di un piano strategico comunale (Psc), approvato con delibera di Giunta comunale (Gc) n. 5 del 10.02.2010, cui si rimanda, quale documento fondamentale di riferimento, del quale le presenti Proiezioni urbanistico-territoriali costituiscono sviluppo e conclusione. Più precisamente, l’elaborato che accompagna la presente relazione, traduce e specifica graficamente i contenuti strategici del Psc approvato in giunta, recependo le novità intervenute a valle della -

Mandato Di Pagamento
ELENCO BENEFICIARI BUONO LIBRI 2009/10 COGNOME/NOME COMUNE N. CODICE FISCALE INDIRIZZO COMUNE NASCITA IMPORTO DATA DI NASCITA RICHIEDENTE RESIDENZA 1 BGNMRA58B42G762G ABAGNALE/MARIA VIA TURATI 398 POGGIOMARINO POGGIOMARINO € 70,00 02/02/1958 2 LBRMLS79B58L259J ALBERTINO/MELISA VIA NOCELLETO 6 POGGIOMARINO TORRE DEL GRECO € 111,00 18/02/1979 3 LBRLGU66S30G762A ALIBERTI/LUIGI VIA DI GIACOMO 115 POGGIOMARINO POGGIOMARINO € 230,00 30/11/1966 4 MRNGTN69P16A064R AMARANTE/GAETANO VIA FORNILLO 285 POGGIOMARINO AFRAGOLA € 90,00 16/09/1969 SAN GIUSEPPE 5 MBRNNA69B59H931L AMBRA/ANNA VIA GIUGLIANI 20 TERZIGNO € 235,00 19/02/1969 VESUVIANO SAN GIUSEPPE SAN GENNARO 6 MBRGPP64D27H860Z AMBROSINO/GIUSEPPE VIA BELVEDERE 13 € 100,00 27/04/1964 VESUVIANO VESUVIANO SAN GIUSEPPE 7 MBRNNT60B45H931M AMBROSIO/ANTONIETTA VIA MIRANDA 17 POGGIOMARINO € 150,00 05/02/1960 VESUVIANO SAN GIUSEPPE 8 MBRNTN64B03H931U AMBROSIO/ANTONIO VIA ASCOLESE 84 POGGIOMARINO € 290,00 03/02/1964 VESUVIANO CASTELLAMMARE DI 9 MBRCMN70C57C129Z AMBROSIO/CLEMENTINA VIA TURATI 75 POGGIOMARINO € 235,00 17/03/1970 STABIA CASTELLAMMARE DI 10 MBRCMN70C57C129Z AMBROSIO/CLEMENTINA VIA TURATI 75 POGGIOMARINO € 100,00 17/03/1970 STABIA VIA NAPPI IV TRAVERSA SAN GIUSEPPE SAN GIUSEPPE 11 MBRLVR68B57H931L AMBROSIO/ELVIRA € 150,00 17/02/1968 DESTRA 28 VESUVIANO VESUVIANO 12 MBRFMN65B65G190O AMBROSIO/FILOMENA VIA ACQUACELSA 26 OTTAVIANO OTTAVIANO € 235,00 25/02/1965 13 MBRFMN65B65G190O AMBROSIO/FILOMENA VIA ACQUACELSA 26 OTTAVIANO OTTAVIANO € 150,00 25/02/1965 SAN GIUSEPPE 14 MBRFTN70S19H931L AMBROSIO/FORTUNA -

N.Posiz. Punti Cognome Nome C.A.P. Comune Pr Indirizzo
COGNOME NOME COMUNE PR INDIRIZZO DATA PUNTI C.A.P. N.POSIZ. NASCITA 4003 04,70 ALIBERTI GAETANA 20 10 1962 84014 NOCERA INFERIORE SA PETROSINI 10 4004 04,70 SABIA FRANCESCO 13 11 1963 84047 CAPACCIO SA VIA CAPASSO 48 4005 04,70 CARAGLIA MICHELE 18 04 1966 83031 ARIANO IRPINO AV VIA DENTICE 8 4006 04,70 CIOLI MAURIZIO 15 08 1956 80100 NAPOLI NA LARGO VOLPICELLI 6/D 4007 04,70 CAPPIELLO SERAFINA 25 05 1957 80046 S.GIORGIO A CREMANO NA VIA PESSINA 57 4008 04,70 LUBRANODISCORPANIELL ENNIO 12 08 1965 80100 NAPOLI NA VIA G.IANNELLI 350 4009 04,70 LAURO LUIGI 31 12 1960 84012 ANGRI SA ENRICO SMALDONE 4010 04,70 MUCCIOLO ANTONIO 18 06 1965 84049 CASTEL SAN LORENZO SA VIA ROMA 16 4011 04,70 LEZZOCHE FRANCESCO PAOLO 14 09 1962 80029 S.ANTIMO NA ROSSINI 3 4012 04,70 PALMESE ALFREDO 21 01 1960 81100 CASERTA CE PETRARELLE 1 4013 04,70 TARANTINO ANNUNZIATA 28 12 1960 80034 MARIGLIANO NA DEL SOLE 24 4014 04,70 FORTE DOMENICO 12 06 1965 80100 NAPOLI NA PZZA PRINCIPE UMBERTO 14 4015 04,70 CUTILLO ERASMO 12 06 1962 82030 TORRECUSO BN VIA SAN LIBERO 4016 04,70 RAUCCI RITA 26 04 1958 81055 S.MARIA CAPUA VETERE CE G.NI.PAOLO I COO.FIORENTE 4017 04,70 OFFREDA ERNESTO 19 04 1968 81011 ALIFE CE L. VESSELLA 1 4018 04,70 VESCIO SALVATORE 02 04 1963 80100 NAPOLI NA VIA R.MARINARE 211 4019 04,70 LEPORE ENRICO 29 08 1955 83036 MIRABELLA ECLANO AV NAZIONALE 103 4020 04,70 AVELLA FELICE 29 04 1962 80035 NOLA NA A.LATERIZIO 65 4021 04,70 VITIELLO CIRO 13 11 1960 81030 CASTEL VOLTURNO CE VIALE EUROPA 30 4022 04,70 BOSSONE BENITO 07 05 1960 84032 BUONABITACOLO SA VIA -
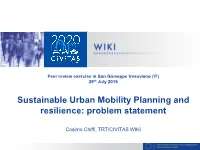
Problem Statement
Peer review exercise in San Giuseppe Vesuviano (IT) 29th July 2015 Sustainable Urban Mobility Planning and resilience: problem statement Cosimo Chiffi, TRT/CIVITAS WIKI The Volcano: Vesuvio The most famous eruption of AD 79 Recent severe eruptions occurred in 1660, 1682, 1694, 1698, 1707, 1737, 1760, 1767, 1779, 1794, 1822, 1834, 1839, 1850, 1855, 1861, 1868, 1872, 1906, 1926, 1929, and 1944 2 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 Cities, towns and road links in the Vesuvian Area 3 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 The Vesuvian Area: a densely populated area 2.140.000 inhabitants in the Greater Neapolitan Area (without city of Naples) 2.670 inh/km2 4 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 National Emergency Plan for the Vesuvian Area • The Red Zone directly involved in case of eruption and the Yellow Zone under the potential influence of Vesuvio eruption 5 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 Hydrogeological risk for the Vesuvian Area • Other Risks maps of the Vesuvian Area: 1. Landslide 2. Hydraulic 6 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 2013 Regional Mobility Plan For this area there are no provisions made to reorganise the mobility 7 PRE in San Giuseppe Vesuviano (IT) - 29th July 2015 Who is working on the idea of resilient SUMP? San Giuseppe Vesuviano, Striano e Terzigno • 53.000 inhabitants •High quality agricolture products •Tertiary industry productions •Vesuvio National Park 2020 Objectives •CO2 emissions reduction beyond 20% (between 26% and 29%) •Increased -

Stazione Di Napoli Porta Nolana Orario Estivo/Summer Timetable in Vigore Dal 1 Luglio Al 31 Agosto
Circumvesuviana s.r.l. Ferrovia, Autolinee e Funivia Stazione di Napoli Porta Nolana Orario Estivo/Summer Timetable in vigore dal 1 luglio al 31 agosto per/to per/to per/to SORRENTO e NOLA - BAIANO POGGIOMARINO - SARNO (Via Ottaviano) POGGIOMARINO (Via Scafati) Treno Ora Categoria Classificazione Destinazione Treno Ora Categoria Classificazione Destinazione Treno Ora Categoria Classificazione Destinazione Train Time Type Classification Destination Train Time Type Classification Destination Train Time Type Classification Destination 905 05:08 A FERIALE ACERRA 605 05:02 A SARNO 405 04:55 A FERIALE POGGIOMARINO 807 05:18 A BAIANO 607 05:32 A SARNO 7 05:09 D FERIALE SORRENTO 503 05:30 AFERIALESan Giorgio Via Poggioreale 611 06:32 A SARNO 407 05:25 A FERIALE POGGIOMARINO 809 05:47 A BAIANO 2615 07:32 A SARNO 9 05:39 D SORRENTO 505 06:00 A San Giorgio Via Poggioreale 617 08:02 A SARNO 409 05:48 A POGGIOMARINO 909 06:08 A * ACERRA 621 09:02 A SARNO 11 06:09 D FERIALE SORRENTO 811 06:17 A FERIALE SCISCIANO 625 10:02 A SARNO 411 06:24 A POGGIOMARINO 507 06:30 A San Giorgio Via Poggioreale 629 11:02 A SARNO 13 06:40 DD* SORRENTO 813 06:45 A BAIANO 633 12:02 A SARNO 353 06:47 A FERIALE TORRE A. OPLONTI 1813 06:57 A FERIALE SCISCIANO 637 13:02 A SARNO 413 06:55 A POGGIOMARINO 509 07:02 A San Giorgio Via Poggioreale 639 13:32 A FERIALE SARNO 331 07:00 A FERIALE TORRE DEL GRECO 815 07:17 A FERIALE BAIANO 2641 14:03 A SARNO 15 07:09 D SORRENTO 511 07:24 A San Giorgio Via Poggioreale 643 14:32 A SARNO 415 07:25 A POGGIOMARINO 215 07:37 A FERIALE POGGIOREALE 1645 15:13 A SARNO 17 07:39 D SORRENTO 817 07:50 A BAIANO 649 16:02 A SARNO 355 07:48 A FERIALE TORRE A. -

POGGIOMARINO Orari in Vigore
ORARI linea NAPOLI - SCAFATI - POGGIOMARINO Orari in vigore D A A A A A A A A A A A A A A A A A 4053 40623 40655 4071 4081 4091 4101 4111 4121 41323 4141 4151 4161 41723 4181 41853 4191 4193 FER NAPOLI PORTA NOLANA 5:55 6:24 6:55 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:24 14:25 15:25 16:25 17:24 18:25 18:54 19:25 19:55 NAPOLI P. GARIBALDI 5:57 6:26 6:57 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:26 14:27 15:27 16:27 17:26 18:27 18:56 19:27 19:57 Via Gianturco | 6:28 6:59 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:28 14:29 15:29 16:29 17:28 18:29 18:58 19:29 19:59 S. GIOVANNI A TEDUCCIO 6:00 6:30 7:01 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:30 14:31 15:31 16:31 17:30 18:31 19:00 19:31 20:01 BARRA 6:02 6:32 7:03 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:32 14:33 15:33 16:33 17:32 18:33 19:02 19:33 20:03 S. Maria del Pozzo | 6:34 7:05 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:34 14:35 15:35 16:35 17:34 18:35 19:04 19:35 20:05 S. -

Ricorso Concorso a Cattedre 2
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA RICORSO dello S.N.A.L.S. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola C.F.: 94200490635 P.Iva: 07540170631 in persona del Segretario Provinciale e legale rappresentante in carica SALVATORE MARGIOTTA nato a Boscoreale (NA) il 20.4.1954 C.F.MRGSVT54D20B076S e dei sig.ri, in qualità di iscritti e personalmente: ASSANTE MARIANO GENNARO nato a Castellammare di Stabia il 21.11.1994 C.F. SSNMNG94S21C129W residente a Castellammare di Stabia in Via Largo Gelso n 9; CARRIERI DOMENICO nato a Torre del Greco il 10.04.1989 C.F. CRRDNC89D10L259E residente a Torre del Greco in Via Santa Maria la Bruna n 169; LONGOBARDI MARIO nato a Castellammare di Stabia il 27.08.1996 C.F. LNGMRA96M27C129L residente a Sant’Antonio Abate in Via Casa Aniello n 128; CORRENTI MARCO nato a Torre del Greco il 12.08.1993 C.F. CRRMRC93M12L259M residente a Boscotrecase in Via Corso Umberto n 168; GARGIULO FERDINANDO nato a Pompei il 06.07.1994 C.F. GRGFDN94L06G813T residente a Boscoreale in Via S.Tenente Ernesto Cirillo n 213; CALABRESE GENNARO nato a Castellammare di Stabia il 16.07.1994 C.F. CLBGNR94L16C129Z residente a Sant’Antonio Abate in Via Casa Varone n 204; CALABRESE CANDIDA nata a Castellammare di Stabia il 16.03.1990 C.F. CLBCDD90C56C129V residente a Sant’Antonio Abate in Via Casa Varone n 204; SERINO VALERIA nata a Napoli il 28.01.1974 C.F. SRNVLR74A68F839E residente a Boscoreale in Via Piazza Vargas n 1; VITIELLO DAVIDE nato a Nocera Inferiore il 19.08.1986 C.F. -

Ambito Territoriale N26 Graduatoria Provvisoria Manifestazione D’Interesse Di Cui Al D
COMUNE DI POGGIOMARINO - c_g762 - 0015050 - Ingresso - 16/06/2020 - 11:48 AMBITO TERRITORIALE N26 GRADUATORIA PROVVISORIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI CUI AL D. REGIONE CAMPANIA N. 232/2020 PER L’EROGAZIONE DI UN BONUS IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ANCHE NON GRAVE, CON PRIORITÀ AI BAMBINI CON DISABILITÀ (ANCHE AUTISTICA) IN ETÀ SCOLARE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA PRIORITA' 9 IV DEL POR CAMPANIA FSE 2014/2020 DOMANDE AMMESSE Comune che ha trasmesso N. N. e data protocollo istanza istanza 1 12579 del 18/05/2020 POGGIOMARINO 2 13223 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 3 14774 del 19.05.2020 TERZIGNO 4 12926 del 21/05/2020 POGGIOMARINO 5 20006 del 14/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 6 12716 del 22/05/2020 OTTAVIANO 7 13030 del 22/05/2020 POGGIOMARINO 8 13295 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 9 14085 del 12.05.2020 TERZIGNO 10 21051 del 25/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 11 14958 del 20.05.2020 TERZIGNO 12 20591 del 20/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 13 12584 del 20/05/2020 OTTAVIANO 14 7525 del 14/05/2020 SAN GENNARO VESUVIANO 15 12718 del 22/05/2020 OTTAVIANO 16 20996 del 25/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 17 13247 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 18 13194 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 19 21017 del 25/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 20 7424 del 12/05/2020 SAN GENNARO VESUVIANO 21 7785 del 20/05/2020 SAN GENNARO VESUVIANO 22 13211 del 25/05/2020 POGGIOMARINO 23 20025del 14/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 24 20904 del 22/05/2020 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 25 12206 del 13/05/2020 POGGIOMARINO 26 12565 del 18/05/2020 POGGIOMARINO 27 7616 del 15/05/2020 SAN -

Scarica Il File in Formato
Num PROFESSIONE ANNOTAZIONI COGNOME_E_NOME INDIRIZZO DATI ANAGR STIMA -VALUTAZIONE VIA NUOVA SAN MARZANO N. 85 - 1688 AGENTE IMMOBILIARE BIANCO ANDREA FRANCESCO POGGIOMARINO 08/04/1955 IMMOBILI POGGIOMARINO VIA MUNICIPIO N. 3 - META DI PIANO DI SORRENTO 1829 AGENTE IMMOBILIARE D'AMATO MARIA ROSARIA SORRENTO 15/05/1960 VIA BARDASCINI N. 72 S.MARIA LECCO 8/9/1983 2704 AGENTE IMMOBILIARE DEL SORBO CIRO NICOLO' LA CARITA' DLSCNC83P08E507C META 28/03/1964 1629 AGENTE IMMOBILIARE PANE ANTONIO VIA CARACCIOLO N. 151 - META PNANTN64C28F162O VIA NOCERA N. 34 - C.MARE DI C.MARE DI STABIA (NA) 2246 AGENTE IMMOBILIARE PORCINI STEFANO STABIA 03/01/1977 1501 AGENTE IMMOBILIARE ROMANO SEBASTIANO VIA PIANO N. 11 PIMONTE C.MARE DI STABIA 07/04/1977 VIA NASTRO VERDE N. 17 - 2142 AGENTE IMMOBILIARE SCALA CARMELA SORRENTO 01/01/1958 SORRENTO VIA SAN VALERIO N. 5 PIANO DI SORRENTO 3303 AGROMONO SORRENTINO VITTORIO SORRENTO 13/10/1992 SRRVTR92R13G568Q VIA COGNULO N. 6 - VICO 1994 AGRONOMO attivata contestazione ARPINO BARTOLOMEO VICO EQUENSE 15/10/1975 EQUENSE VICO EQUENSE 08/1/1975 3288 AGRONOMO ASTARITA ELISABETTA VIA CUPA SALETTA N. 9 LETTERE STRLBT75A48L845G VIA CUPA SCAPPI N.10 - TORRE 936 AGRONOMO ATONNA MARIA AURORA TORRE DEL GRECO 23/07/1968 DEL GRECO VIA AVELLINO N.10 - TORRE DEL 1066 AGRONOMO BORRIELLO MICHELE TORRE DEL GRECO 11/06/1957 GRECO NOCERA INF.RE 13/08/1987 3130 AGRONOMO BOSSO GABRIELE VIA MUNICIPIO N. 3 STRIANO BSSGRL87M13F912J C/MARE DI STABIA 18/06/1980 2648 AGRONOMO CAFIERO MASSIMILIANO VIALE DEI PINI N. 38 S.AGNELLO CFRMSM80H18C129F VIA QUARRAZZANO N. 25 - 2077 AGRONOMO CASA PAOLO SIMONE NAPOLI 22/09/1977 MASSA LUBRENSE PUERTO ORDAZ (VENEZ) 3143 AGRONOMO CHIECHIA ANDREA VIA MADONNINA N.3 PIMONTE 30/8/1979 CHRNDR79M30Z614Z VIA CUPA OSPEDALE N.