CAPITOLO I Il Comune Di Vietri Sul Mare
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
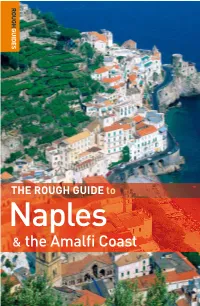
The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast
HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

ORARIO SITA INVERNO 2019-20 A3
PRAIANO, Tourist Information Office Ph 0039.089.874.557 EMail: [email protected] - http://www.praiano.org L’ orario è valido dal 16 Marzo 2020 (FINO A NUOVE DISPOSIZIONI) IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA REGIONALE NR 14 DEL 12/03/2020: RIDUZIONE DELLE LINEE DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA NELLA REGIONE CAMPANIA #EMERGENZA CORONAVI RUS AMALFI – PRAIANO – POSITANO – SORRENTO G F G F H G G F F G F G F H F G Amalfi 6.20 7.15 8.05 9.00 9.30 11.30 12.15 13.30 14.05 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 Conca Dei Marini 6.35 7.30 8.20 9.15 9.45 11.45 12.30 13.45 14.20 14.45 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 P R A I A N O 6.45 7.40 8.30 9.25 9.55 11.55 12.40 13.55 14.30 14.55 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 Positano Sponda 7.00 7.55 8.45 9.40 10.10 12.10 12.55 14.10 14.45 15.10 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 Positano C. Nuova 7.10 8.05 8.55 9.50 10.20 12.20 13.05 14.20 14.55 15.20 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 Colli San Pietro 7.25 8.20 9.10 10.05 10.35 12.35 13.20 14.35 15.10 15.35 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 Meta 7.35 - 9.20 - - - - - - 15.45 - 17.15 17.45 18.15 - - Piano di Sorrento 7.48 - 9.30 - - - - - - 15.58 - 17.28 17.58 18.25 - - Bivio Sant’Agata - 8.35 - 10.20 10.50 12.50 13.35 14.50 15.25 - 16.50 - - - 18.50 - ( S. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus SITA
Orari e mappe della linea bus SITA SITA Amalƒ-Maiori-Vietri-Nocera-Aut-Napoli Visualizza In Una Pagina Web La linea bus SITA (Amalƒ-Maiori-Vietri-Nocera-Aut-Napoli) ha 5 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Amalƒ-Maiori-Vietri-Nocera-Aut-Napoli: 05:45 (2) Amalƒ-Vietri-Cava-(Aut.)-Napoli: 06:20 (3) Nap.- Nocera - Cava Dè Tir.-Vietri.-Maiori: 17:30 (4) Napoli - Pompei - Nocera - Cava - Vietri- Maiori - Amalƒ: 14:00 (5) Napoli-Aut-Nocera-Vietri- Maiori-Amalƒ: 09:00 - 14:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus SITA più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus SITA Direzione: Amalƒ-Maiori-Vietri-Nocera-Aut- Orari della linea bus SITA Napoli Orari di partenza verso Amalƒ-Maiori-Vietri-Nocera- 42 fermate Aut-Napoli: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:45 martedì 05:45 Amalƒ Largo Piccolomini, Amalƒ mercoledì 05:45 Municipio giovedì 05:45 Piazza Municipio, Atrani venerdì 05:45 Hotel Luna sabato 05:45 Via Pantaleone Comite, Amalƒ domenica Non in servizio Atrani Piazza Umberto I, Atrani Bivio Ravello 2 Carusiello, Atrani Informazioni sulla linea bus SITA Direzione: Amalƒ-Maiori-Vietri-Nocera-Aut-Napoli La Rosa Dei Venti Fermate: 42 Durata del tragitto: 120 min S.S. 163, 28 La linea in sintesi: Amalƒ, Municipio, Hotel Luna, Atrani, Bivio Ravello, La Rosa Dei Venti, S.S. 163, 28, Carusiello Carusiello, Marmorata, Marmorata 2, Paradiso, S.S. 163, 93, Via Alfonso Gatto, 53, Minori, San Marmorata Francesco, S. Rita, Maiori Centro, Maiori (Capo D'Orso), Maiori (Erchie), Cetara, Corso Umberto I, Marmorata 2 Cetus, S.S. -

ATINER's Conference Paper Series ARC2013-0867
ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ARC2013-0867 Athens Institute for Education and Research ATINER ATINER's Conference Paper Series ARC2013-0867 Rural Architecture in Sorrento- Amalfitan Coast. Constructive Tradition and Prospect for Preservation Maria Falcone University of Naples “Federico II” Italy Arianna Spinosa Professor University of Naples “Federico II” Italy Luigi Veronese Professor University of Naples “Federico II” Italy Mariarosaria Villani Architect University of Naples “Federico II” Italy 1 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ARC2013-0867 Athens Institute for Education and Research 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece Tel: + 30 210 3634210 Fax: + 30 210 3634209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr URL Conference Papers Series: www.atiner.gr/papers.htm Printed in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. All rights reserved. Reproduction is allowed for non-commercial purposes if the source is fully acknowledged. ISSN 2241-2891 23/1/2014 2 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ARC2013-0867 An Introduction to ATINER's Conference Paper Series ATINER started to publish this conference papers series in 2012. It includes only the papers submitted for publication after they were presented at one of the conferences organized by our Institute every year. The papers published in the series have not been refereed and are published as they were submitted by the author. The series serves two purposes. First, we want to disseminate the information as fast as possible. Second, by doing so, the authors can receive comments useful to revise their papers before they are considered for publication in one of ATINER's books, following our standard procedures of a blind review. -

LIVE the WONDERFUL EXPERIENCE of a TOURISTIC FLIGHT Discover Beautiful Landscapes from a Bird’S Eye View
LIVE THE WONDERFUL EXPERIENCE OF A TOURISTIC FLIGHT Discover beautiful landscapes from a bird’s eye view Live the amazing experience of a touristic flight with one of our aircraft ly over the most stunning places fly are: single-engine with two seats the Campania Region offers and P2002, single-engine with four seats enjoy its breathtaking panoramas. C172 RG or multi-engine with four seats Places like the Gulf of Naples, Ischia, P2006. FProcida, Capri, Mount Vesuvius, the an - In addition, it is also possible to arrange cient ruins of Pompei, the Peninsula of executive flights with our Citation Mu - Sorrento or the Amalfi Coast are just a stang C510 to reach any destination in few examples. Europe. We offer a variety of tours that will allow you to explore from a different perspective, astonishing sceneries. It is possible to adapt the route to your specific request. Our aircraft can accommodate from 1 up to 3 passengers. The type of aircraft we 3 Itinerary nbr. 1 NAPLES and ISCHIA Procida, Pozzuoli, Posillipo, Seafront of Naples Discover the picturesque isle of Procida seen from above which overlooks the gulf of Pozzuoli and its Campi Flegrei. Conti - nue towards the Gulf of Naples, overflying the residential area of Posillipo with its elegant villas among which stands out Villa Rosebery, the elegant mansion pro - perty of the Presidency of the Republic with its private harbor. Heading South- East, the Gulf of Naples will spread out in front of you with its beautiful seafront, the neighborhoods of San Ferdinando and Chiaia, the parks, the marina of Naples and the seafront luxury hotels opposite to which the ancient Castel dell’Ovo seams to raise up from the sea. -

Pompeii & Amalfi
DISCOVER & EXPLORE POMPEII & AMALFI WITH THE GREATER WESTFIELD AREA CHAMBER OF COMMERCE BOOK $2,749 PER PERSON $2,549 PER PERSON &SAVE if deposited by February 15th!* Departing October 11, 2017 For more information, please contact Gene Jannotti at (908) 233-3021 Day 1 - Depart USA altitude, Villa Rufolo is a great tourist destination offering breathtaking views HIGHLIGHTS: Today depart the U.S. on an and beautiful gardens. Continue to • Round trip scheduled airfare international flight to Italy. (in-flight Amalfi and its historic center. You may into Italy meals) want to enjoy Saint Andrea Cathedral, • 6 Nights accommodation at Day 2 - Arrival/Amalfi Coast the Cloister of Paradise and even some first class hotel on the Amalfi Arrive in Italy where you will be met by shopping. (B) Coast your program manager who will assist • Breakfast daily at the hotel Day 4: Pompeii with your transfer to your hotel. The • Transfers and sightseeing After breakfast we will travel to Pompeii, rest of the day is at leisure. Enjoy your one of Italy’s most famous and unique as indicated in the itinerary, time today either with a quick rest or archeological sites. Frozen in time when with assistance, by deluxe begin your exploration of the beautiful it was covered by volcanic ash during motorcoach Amalfi Coast. Later this afternoon, meet the eruption of Mt. Vesuvius in A.D. 79., • Welcome cocktail again with your program manager for a Pompeii is now a World Heritage site • Full day guided excursion to welcome cocktail and orientation. Positano and Ravello/Sorrento which offers a glimpse back in time & Amalfi/Pompeii Day 3 - Amalfi Coast – Amalfi/Ravello to life during the height of the Roman After breakfast, meet your program • 24 Hour Hospitality desk daily Empire. -

Travel's Taste
Travel’s taste YOUR LUXURY TRAVEL PARTNER IN ITALY www.italycreative.it Amalfi Coast Amalfi More about: things to know Coast www.italycreative.it Deemed by Unesco to be an outstanding example of a Mediterranean landscape, the Amalfi Coast is a beguiling combination of great beauty and gripping drama: coastal mountains plunge into the sea in a stunning vertical scene of precipitous crags, picturesque towns and lush forests. Most hotels and villas are open from March/April through October/November. The towns on the water with beaches include Amalfi, Atrani, Cetara, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Positano, and Vietri sul Mare. Towns higher up on the cliffs include Agerola, Ravello, Scala, and Tramonti. Amalfi Coast is crossed by Strada Statale 163 Amalfitana (world-famous known as Amalfi Drive), a 50km (30 miles) stretch of road from north to south. If we take the two entrance points to the Amalfi Coast with Sorrento in the north and Salerno in the south, the road goes through the towns in this order: Positano | Praiano | Amalfi | Atrani | Minori | Maiori | Cetara | Vietri Sul Mare It's important to know the order as that would make exploring the towns a bit easier. The Sorrento to Salerno direction is more preferrable as, by being in the right lane, you are right next to the cliffs with no opposing traffic to block your view. There are no trains serving the Amalfi Coast. HOTELS selection Amalfi à POSITANO Coast www.italycreative.it Spread between four villas, each of the suites offers a unique blend of carefree comfort and careful attention to detail. -

Water Events and Historical Flood Recurrences in the Vietri Sul Mare Coastal Area (Costiera Amalfitana, Southern Italy)
The Basis of Civilization - Water Science? (Proceedings of the UNESCO/1 AI-IS/IWHA symposium held in Rome, December 2003). IAHS Publ. 286, 2004 95 Water events and historical flood recurrences in the Vietri sul Mare coastal area (Costiera Amalfitana, southern Italy) ELIANA ESPOSITO1, SABINA PORFIDO1, CRESCENZO VIOLANTE1, CHI ARA BISCARINI1, FIORENTINO ALAIA2 & GIUSEPPE ESPOSITO3 1 Istituto Ambieule Marino Cosliero, Calala Porta di Massa, intemo porto, 1-80133 Napoli, Italy eliana(5),gms01 .geomare.na.cnr.it 2 Archivio di Stalo di Avellino, Italy 3 Regione Campania, Napoli, Italy Abstract This study addresses problems pertinent to the municipality of Vietri sul Mare located in the southeastern comer of the Amalft coast (southern Italy). The physical landscape, the economic settlements, the social activity and the natural hazards characterizing this area depend particularly on water: meteoric, riverine and marine. Indeed Vietri sul Mare is located on a steep rocky coast deeply dissected by ephemeral water courses (the Stream Bonea basin) with human activities mainly developed on the narrow stream banks located at the base of steep sided valleys, or at the mouth of Stream Bonea. This exposes them to a high hydrogeological risk triggered by water events associated with heavy rain. Several historical sources report at least 22 flooding events for the Vietri area during the last three centuries, which caused severe damage. In this paper historical sources are combined with geological data in order to improve the mitigation of flood phenomena through the reconstruction of historical floods and the estimation of the associated risks. Key words flood; historical source; hydrological risk; rocky coast; Sorrento peninsula; southern Italy INTRODUCTION The study area is located on the southern flank of the Sorrento peninsula (Costiera Amalfitana), west of Salerno (southern Italy). -

Back-Roads| Europe
ENCHANTING SOUTHERN ITALY Blue-Roads | Europe Southern Italy beguiles every sense. On this enchanting journey we’ll step back in time to the days of the Roman Empire in the historic Bay of Naples, explore the pastel-hued cliffside villages of the Amalfi Coast, tour cascading Victorian-inspired gardens and revel in the opulence of the Italian Baroque period. All the while savouring exquisite regional delicacies and gaining a unique insight into local cultures and centuries-old traditions of the Mezzogiorno. TOUR CODE: BEHSINN-1 Thank You for Choosing Blue-Roads Thank you for choosing to travel with Back-Roads Touring. We can’t wait for you to join us on the mini-coach! About Your Tour Notes THE BLUE-ROADS DIFFERENCE Visit the exquisite 18th-century Royal Palace of Caserta These tour notes contain everything you need to know Visit a lemon grove near sleepy before your tour departs – including where to meet, Minori and indulge in a zesty tasting what to bring with you and what you can expect to do spread on each day of your itinerary. You can also print this Spend a day exploring the breath- document out, use it as a checklist and bring it with you taking and idyllic island of Capri on tour. TOUR CURRENCIES Please Note: We recommend that you refresh this document one week before your tour + Italy - EUR departs to ensure you have the most up-to-date accommodation list and itinerary information available. Your Itinerary DAY 1 | NAPLES A hub of intoxicating culture and historic masterpieces – we’ll meet the group in the electric city of Naples. -

Ambito SA-24 Elenco Scuole Infanzia Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente
Anno Scolastico 2018-19 CAMPANIA AMBITO 0024 - DR Campania - Ambito SA-24 Elenco Scuole Infanzia Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto SAIC8AF001 IST. COMPR. MAIORI SAAA8AF00R IST. COMPR. MAIORI NORMALE VIA CAPITOLO N. 2 MAIORI SAAA8AF01T MINORI CAP. VIA LAMA 35 MINORI SAAA8AF02V MAIORI CAPOLUOGO VIA DE IUSOLA 2 MAIORI SAIC83400E IST.COMPR. AMALFI SAAA83400A IST.COMPR. AMALFI NORMALE PIAZZA SPIRITO SANTO, 9 AMALFI SAAA83401B AMALFI CAP. P.ZZA DELLO SPIRITO AMALFI SANTO N.9 SAAA83402C POGEROLA VIA CASTELLO AMALFI SAAA83406L CONCA DEI MARINI VIA ROMA CONCA DEI CAPOLUOGO MARINI SAAA83407N FURORE CAPOLUOGO SALITA S.MICHELE FURORE SAIC81100T IST.COMPR. TRAMONTI SAAA81100N IST.COMPR. TRAMONTI NORMALE VIA ORSINI - POLVICA TRAMONTI SAAA81102Q TRAMONTI GETE TRAMONTI SAAA81104T TRAMONTI-PIETRE VIA S. FELICE TRAMONTI SAIC823004 IST.COMPR. RAVELLO SAAA82300X IST.COMPR. RAVELLO NORMALE VIA ROMA, 80 RAVELLO SAAA823011 RAVELLO - VIA ROMA VIA ROMA RAVELLO SAAA823022 SCALA PIAZZA MUINICIPIO SCALA SAIC8BY007 IC VIETRI SUL MARE SAAA8BY003 IC VIETRI SUL MARE NORMALE ND VIETRI SUL SAAA8BY014 MOLINA VIA D'AMICO VIETRI SUL MARE MARE SAAA8BY025 VIETRI SUL MARE CORSO UMBERTO I VIETRI SUL CAP."PUNZI" MARE SAAA8BY036 RAITO/ALBORI VIA NUOVA RAITO VIETRI SUL MARE SAAA8BY047 VIETRI SUL VIA BOTTAIO VIETRI SUL MARE - BENINCASA MARE SAAA8BY058 CETARA CAP. PIAZZA MARTIRI CETARA UNGHERESI SAIC8BA00C IST.COMPR."EDUARDO SAAA8BA008 IST.COMPR."EDUARDO NORMALE VIA G.LEOPARDI,1 SANT'EGIDIO SAAA8BA019 S.EGIDIO M.A.- CAP. -

“Costiera Amalfitana” Va Da Vietri Sul Mare a Positano E Comprende 17 Comuni, Tutti Della Provincia Di Salerno
CAPITOLO 2 - LA STRUTTURA DEL COMPRENSORIO 2. LA STRUTTURA DEL COMPRENSORIO 2.1 L’ARMATURA TERRITORIALE Il comprensorio che oggi viene identificato come “Costiera Amalfitana” va da Vietri sul mare a Positano e comprende 17 comuni, tutti della Provincia di Salerno. In effetti, nel versante amalfitano della penisola sorrentina ricadono anche una parte del territorio di Massalubrense e l’intero territorio di Agerola. L’uno e l’altro comune sono inclusi nella provincia di Napoli. Al di là dell’appartenenza amministrativa, tuttavia, va rilevato che solo Agerola può considerarsi parte del comprensorio amalfitano. Il territorio di Massalubrense ha sempre gravitato, invece, su Sorrento. Il territorio della Costiera impegna quasi per intero il versante meridionale della catena dei Lattari. L’orografia è caratterizzata da vette che superano di poco i 1.000 metri (Monte Cerreto, 1.315; Monte Pertuso, 1.139). Dal crinale dei Monti Lattari si dipartono numerose incisioni, alcune delle quali sono solcate dai corsi d’acqua che hanno reso possibile lo sviluppo (il Canneto, Il Dragone, il Reginna Major, il Bonea). Nonostante la presenza di numerosi centri urbani l’asperità del territorio non ha consentito che si sviluppasse una forte rete di relazioni territoriali, né interne né di collegamento con i comprensori vicini. Fino ad un secolo fa Positano e Vietri erano raggiungibili da Amalfi solo via mare. Le uniche linee di forza del comprensorio amalfitano erano costituite da una strada Costiera che collegava Amalfi a Maiori e da una trasversale che, attraverso il valico di Chiunzi, collegava Maiori con la piana vesuviana. In pratica, un territorio sostanzialmente chiuso, senza linee di forza interne, accessibile agevolmente solo via mare. -

The Unknown Amalfi Coast Ind. 2019
Independent 'Self Guided' walking tour The unknown Amalfi Coast Between the charming fishing villages and impressive monasteries of the world’s most beautiful coastline TRIP NOTES 2021 © Genius Loci Travel. All rights reserved [email protected] | www.genius-loci.it ***GENIUS LOCI TRAVEL - The Real Spirit Of Italy*** Independent 'Self Guided' walking tour 2 INTRODUCTION This is an exclusive tour along the eastern part of the well-known Amalfi Coast, one which only Genius Loci Travel, the Amalfi Coast specialists, can offer you. This tour lets you discover some of the real highlights that are still ignored by foreign tourism, despite the fact that (too) many tour operators worldwide now offer walking holidays along this coast. You start from Salerno, the provincial capital and a beautiful city by itself, and then walk along Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, the ‘Madonna dell’Avvocata’, Cetara and Maiori to Minori (with an optional extension to Ravello& Amalfi). You will enjoy some spectacular coastal scenery, some of the most picturesque hamlets on the Amalfi Coast, just above the well-known Vietri sul Mare, the charming fishing village of Cetara and the great abbey of Cava dei Tirreni, once one of the most powerful abbeys in southern Italy. You’ll walk across a variety of landscapes in real mountainous scenery, through chestnut forests, mountain meadows and bare rocky wilderness, terraced lemon groves and broad sandy beaches. The tour starts from Salerno, a beautiful little city at the entrance to the Amalfi Coast. It was once a powerful city, as demonstrated by the fact that it boasted Europe’s first medical university.