Le Razze Ovine Venete
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Local Adaptations of Mediterranean Sheep and Goats Through an Integrative Approach
Supplemental Information for: Local adaptations of Mediterranean sheep and goats through an integrative approach Bruno Serranito 1,2# , Marco Cavalazzi 3# , Pablo Vidal 4, Dominique Taurisson-Mouret 5, Elena Ciani 6, Marie Bal 3, Eric Rouvellac 3, Bertrand Servin 7, Carole Moreno-Romieux 7, Gwenola Tosser-Klopp 7, Stephen J. G. Hall 8, Johannes A. Lenstra 9, François Pompanon 10 , Badr Benjelloun 10,11 , Anne Da Silva 1* #: Serranito B. and Cavalazzi M. should be considered joint first author * Correspondence: [email protected] Table of Contents: Supplementary Table 1. Initial list breeds for the constitution of the datasets. Page 1 Supplementary Figure 1. Synthetic schema of the main steps for the Page 2 proposed approach. Supplementary Figure 2. Goat and sheep cradles description as a function of Pages 3-4 environmental variables: Synthetic descriptions of cradles and some characteristic breed phenotypic traits. Supplementary Table 2. Description of the breeds included in the sheep and Pages 5 -16 goat datasets. Number of individuals considered, country of origin, information on the breed history, geographical definition of the cradle, description of the breed, use and status. Supplementary Figure 3. LD analyses for sheep and goats. Page 17 Supplementary Text 1. Genetic structure assessment: admixture analyses, Pages 18 -20 sNMF cross-entropies and Mantel tests. Supplementary Figure 4 . Mapping display for sheep and goats, of the Pages 21 -22 geographical cradles and the GPS coordinates of the sampled points; statistical comparisons for the variables Annual Mean Temperature, Annual Mean Precipitation and Altitude between the distributions obtained by the cradle method and the GPS area method, display of the results via boxplots. -

STRUTTURE ZOOTECNICHE I. Organismi Autorizzati O Riconosciuti
Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Ufficio COSVIR X - Produzioni Animali - Dirigente: Claudio Lorenzini Tel. 06 46655098-46655096 - 06 484459 Fax. 06 46655132 e-mail: [email protected] STRUTTURE ZOOTECNICHE (Dec. 2009/712/CE - Allegato 2 - Capitolo 2) I. Organismi autorizzati o riconosciuti ai fini della tenuta o dell’istituzione dei registri o dei libri genealogici a) Specie bovina e bufalina Versione Stato membro Elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 77/504/CEE Ufficialmente abilitati a redigere o a conservare i registri genealogici Marzo 2012 ITALIA (List of bodies as referred to in Article 1(d) of Directive 77/504/EEC officially approved for maintaining registers) Data del Nome Indirizzi utili Nome della razza Osservazioni riconoscimento Località Ferlina, 204 37012 Bussolengo (VERONA) Associazione Nazionale Allevatori +39 045 6760111 Bovini della Razza Bruna Italiana 18/02/1981 BRUNA (ANARB) +39 045 7156655 (D.P.R. n. 598 del 27/4/1960) @ [email protected] www www.anarb.it Fraz. Favret, 5 11020 Gressan Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana +39 0165250984 PEZZATA ROSSA (ANABORAVA) 18/11/1982 PEZZATA NERA DUPLICE (D.P.R. n. 22/6/1987) CASTANA +39 0165251009 @ [email protected] www www.anaborava.it Data del Nome Indirizzi utili Nome della razza Osservazioni riconoscimento Via Masaccio,11 42124 Mancasale (REGGIO EMILIA) Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana +39 0522 271396 16/05/1962 REGGIANA (ANARARE) +39 0522 271396 (D.P.R. n. 997 del 16/11/1962) @ [email protected] www www.razzareggiana.it Strada del Vio Viscioloso, 21 06132 San Martino In Colle (PERUGIA) MARCHIGIANA Associazione Nazionale Allevatori CHIANINA Bovini Italiani da Carne +39 075 6070011 18/10/1969 ROMAGNOLA (ANABIC) +39 075 607598 MAREMMANA (D.P.R. -

Enti Selezionatori Che Tengono Libri Genealogici Per Gli Animali Riproduttori Di Razza Pura
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/1. DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale DISR - Direzione generale dello sviluppo rurale DISR VII - Produzioni animali Dirigente: dott. Francesco BONGIOVANNI Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma Piano 3, Stanza 96 Telefono: +39 06 4665 5096 E-Mail: [email protected] PEC: [email protected] WWW: https://www.politicheagricole.it/ ____________________________________________________________________ Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura Enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori 1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/1. I. Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura a) Animali riproduttori di razza -

SHEEP AL.L. CHAIN Miglioramento Della Competitività Degli Allevamenti
SHEEP AL.L. CHAIN Miglioramento della competitività degli allevamenti 1/4 delle razze ovine autoctone a limitata diffusione: pecora di razza Alpagota e pecora di razza Lamon. (Bando Leader) https://www.innovarurale.it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/sheep-all-chain-miglioramento-della-competitivita-degli SHEEP AL.L. CHAIN Miglioramento della competitività degli allevamenti delle razze ovine autoctone a limitata diffusione: pecora di razza Alpagota e pecora di razza Lamon. (Bando Leader) Riferimenti Acronimo SHEEP AL.L. CHAIN Tematica Gestione aziendale Focus Area 2a) Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli Informazioni Periodo 2018 - 2020 Durata 24 mesi Partner (n.) 10 Obiettivi Regione Il Progetto attraverso la realizzazione di un software (+app) intende: Veneto supportare gli allevatori nella gestione riproduttiva delle razze ovine a Comparto limitata diffusione al fine di consentire la conservazione e l'utilizzo Zootecnia - ovi-caprini sostenibile della loro variabilità genetica; Localizzazione caratterizzare su base geografica gli allevamenti delle razze ovine ITH33 - Belluno autoctone, individuando indicatori di valore aggiunto socio-culturale ed ambientale per una valorizzazione economica delle produzioni collegate Costo totale soprattutto in termini di tracciabilità delle produzioni; €195.982,51 valorizzare tali dati nei processi di conversione al regime biologico; Fonte di finanziamento principale sviluppare efficaci strategie di comunicazione e marketing. Programma di sviluppo -

Selection Signatures Scan in Several Italian Sheep Breeds Identifies Genes Influencing Micronutrient Metabolism S
Selection signatures scan in several Italian sheep breeds identifies genes influencing micronutrient metabolism S. Sorbolini1, C. Dimauro1, M. Cellesi1, F. Pilla2, N.P.P. Macciotta1 and the BIOVITA Consortium. 1Università di Sassari, Dipartimento di Agraria, Viale Italia 39, 07100 Sassari, Italy. 1Università del Studi del Molise, Dipartimento Agricoltura Ambiente Alimenti, Via F. de Sanctis s.n.c. 86100 Campobasso, Italy. [email protected] (Corresponding author) Summary Animal physiological functions involve enzymes and cofactors. Many of these substances can not be synthesized by the body, but derive from the diet. An example are micronutrients, that strongly affect production performance, whose requirements are often met by the farmers by adding supplements to the diet. The aim of this study was to investigate the genetic variability of Italian sheep breeds searching for possible selective sweeps that harbor genes involved in the metabolism of micronutrients in. SNP A sample of 496 sheep belonging to 20 breeds farmed in Italy were genotyped with the Illumina Ovine 50K beadchip. Data were analysed by canonical discriminant analysis (CDA). Forty SNP located in regions of the genome containing loci involved in the metabolism of vitamins and minerals were detected. in particular, genes linked to the metabolism of vitamins and minerals such as Selenocysteine Lyase (SCLY), calcium sensing receptor (CASR), Solute Carrier Family 23 Member 1 (SLC23A1) and Thiamine Triphosphatase (THTPA) were highlighted. Keywords: selection signatures, micronutrients, sheep, Canonical Discriminant Analysis Introduction Nutritional status is of particular importance for productive performances in livestock. Growth, milk production, reproduction depend on a wide range of essential nutrients such as amino acids, fatty acids, vitamins and minerals. -
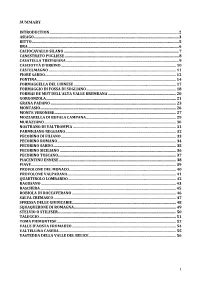
1 Summary Introduction
SUMMARY INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 2 ASIAGO ............................................................................................................................................................ 3 BITTO .............................................................................................................................................................. 5 BRA .................................................................................................................................................................. 6 CACIOCAVALLO SILANO ............................................................................................................................ 7 CANESTRATO PUGLIESE ........................................................................................................................... 8 CASATELLA TREVIGIANA ......................................................................................................................... 9 CASCIOTTA D’URBINO ............................................................................................................................ 10 CASTELMAGNO ......................................................................................................................................... 11 FIORE SARDO ............................................................................................................................................. 12 FONTINA..................................................................................................................................................... -
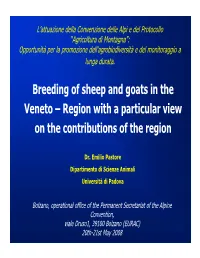
Breeding of Sheep and Goats in the Veneto
L’attuazione della Convenzione delle Alpi e del Protocollo “Agricoltura di Montagna”: Opportunità per la promozione dell’agrobiodiversità e del monitoraggio a lunga durata. Breeding of sheep and goats in the Veneto – Region with a particular view on the contributions of the region Dr. Emilio Pastore Dipartimento di Scienze Animali Università di Padova Bolzano, operational office of the Permanent Secretariat of the Alpine Convention, viale Druso1, 39100 Bolzano (EURAC) 20th-21st May 2008 C.N.R. PROGETTO FINALIZZATO: DIFESA RISORSE GENETICHE ANIMALI (1979) RAZZE OVINE SEGNALATE DALL’ASSONAPA (*) Istriana 250 Friuli Friulana estinta Friuli Cadorina non trovata Friuli Lamon 10000 Belluno - TV - Bolzano - Friuli Alpagota 3500 Belluno Vicentina 100 Vicenza Padovana non trovata Padova Tiroler Bergshaf 24000 Bolzano Val d'Ultimo 700 Bolzano * Dati ASSONAPA 1970 C.N.R. PROGETTO FINALIZZATO: DIFESA RISORSE GENETICHE ANIMALI (1979) RAZZE OVINE INDIVIDUATE (*) Bellunese 100 Treviso Brogne 50 Verona Brentegana 3000 Verona Pusterese 50 Bolzano - Belluno Val Badia 20 Val Badia * Razze trovate durante il progetto FINANZIAMENTO DI RICERCHE E STUDI dal 1980….. ..ad oggi ….CHE HANNO PERMESSO L’INDIVIDUAZIONE DELLE RAZZE OVINE VENETE Cadorina Lamon Agordina Vicentina Alpagota Brentegana Padovana Brogna TRENTINOTRENTINO ALTOALTO--ADIGEADIGE Della Roccia Val d’Ultimo Dal Badia Fiemmese Lamon Brentegana FRIULIFRIULI VENEZIAVENEZIA GIULIAGIULIA Plezzana Alpagota Lamon (incroci) Friulana Carsolina RAZZERAZZE INDIVIDUATEINDIVIDUATE AZIONI INTRAPRESE DALLA REGIONE VENETO: ANNO 2000-2003 Attraverso le risorse assegnate dal MIPAF con DM n. 8740 del 15 maggio 2000, la Regione Veneto ha sviluppato un proprio programma operativo denominato "Intervento regionale per la salvaguardia delle biodiversità", che è stato realizzato dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura nel biennio 2002−2003 e che comprendeva il sottoprogetto costituzione di un Centro regionale per le razze ovine venete in pericolo di estinzione, presso l'Azienda Pilota e Sperimentale per la Montagna "Villiago". -

Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animali in Italia
▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ Rapporto sullo Stato delle Risorse Genetiche Animali in Italia Luglio 2005 ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ Introduzione L’autorizzazione per la stesura di questo Primo Rapporto Sullo Stato Delle Risorse Genetiche Animale del Paese è stata concessa nel marzo 2001 a seguito di una comunicazione pervenuta dal Direttore Generale dell’Organizzazione Nazionale per l’Alimentazione e Agricoltura – FAO - invitando l’Italia a partecipare alla stesura di un rapporto che dovrà chiarificare lo stato delle risorse genetiche del Paese. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha assegnato il compito della stesura del 1º Rapporto al ConSDABI, nella persona del prof. Donato Matassino. Questo 1. Rapporto del Paese, sinteticamente, descrive l’attuale situazione delle risorse genetiche animali per l’alimentazione e per l’agricoltura e identifica i bisogni per consentirne la tutela, la conservazione e l’utilizzazione; inoltre, riferisce sullo stato delle risorse genetiche animali, sullo stato e sull’andamento delle risorse, nonché sul loro potenziale contributo all’agricoltura, all’alimentazione e allo sviluppo della ruralità multifunzionale sostenibile; in piú, analizza l’attuale capacità del paese per la gestione di queste risorse ed evidenzia le priorità che potrebbero risultare utili per la cooperazione internazionale. 3 ▪▪▪cbfmdn{vs~qruxop|z ▪▪▪ CAPITOLO 1 RESOCONTO DELLO STATO DELLA BIODIVERSITÀ NEL SETTORE DEGLI ANIMALI IN ITALIA. 1.1. Punto di vista dell’agricoltura italiana sistemi di produzione animale e relativa biodiversità. 1.1.1. Il Paese L’Italia confina a ovest con la Francia, a nord con la Svizzera e l’Austria, a est con la Slovenia, e nel suo interno si trovano lo Stato Vaticano e quello di San Marino. -

ASPA 20Th Congress
ASPA2013_cover_Layout 1 11/06/13 09.49 Pagina 1 Book of Abstracts j Official Journal of the Animal Science and Production Association (ASPA) ISSN 1594-4077 eISSN 1828-051X www.aspajournal.it Congress, Bologna, June 11-13, 2013 11-13, June Bologna, Congress, th Italian Journal ASPA ASPA 20 of Animal Science j 2013; volume 12 supplement 1 ASPA 20th Congress Bologna, June 11-13, 2013 Book of Abstracts Guest Editors: Andrea Piva, Paolo Bosi (Coordinators) Alessio Bonaldo, Federico Sirri, Anna Badiani, Giacomo Biagi, Roberta Davoli, Giovanna Martelli, Adele Meluzzi, Paolo Trevisi [email protected] supplement 1 Italian Journal of Animal 12, volume Science 2013; www.pagepress.org ASPA2013_book_Hrev_master 11/06/13 09.44 Pagina a Italian Journal of Animal Science Official Journal of the Animal Science and Production Association ISSN 1594-4077 eISSN 1828-051X Editorial Staff Editor-in-Chief Nadia Moscato, Managing Editor Rosanna Scipioni, Università di Modena e Reggio Emilia, Cristiana Poggi, Production Editor (Italy) Anne Freckleton, Copy Editor Filippo Lossani, Technical Support Section Editors Luca M. Battaglini, Università di Torino (Italy) Umberto Bernabucci, Università della Tuscia, Viterbo (Italy) Cesare Castellini, Università di Perugia (Italy) Beniamino T. Cenci Goga, Università di Perugia (Italy) Publisher Giulio Cozzi, Università di Padova (Italy) PAGEPress Publications Juan Vicente Delgado Bermejo, Universidad de Córdoba (Spain) via Giuseppe Belli 7 Luca Fontanesi, Università di Bologna (Italy) 27100 Pavia, Italy Oreste Franci, Università -

Country Report Italy 2011
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) 21 st April 2011 ERFP Country report 2010 – 2011 COUNTRY: ITALY reported by: Giovanni Bittante Strategic Priority Area 1: Characterization, Inventory and Monitoring of Trends and Associated Risks The inventory of Italian animal genetic resources and the monitoring of trends and associated risks has been undertaken and summarized il the paper "Italian animal genetic resources in the Domestic Animal Diversity Information Systm of FAO" (Giovanni Bittante, 2011, Italian Journal of Animal Science,vol 10:e29, Annex 2). Several research activities on this topic have been carried out by Universities and Research Institutions. Among them see the important activity of ConSDABI (Annex 3). Strategic Priority Area 2: Sustainable Use and Development Beyond the systematic control of animals of Italian populations (herd books, pedigree registries, milk recording, type evaluation, etc.) made by the different associations of breeders, as outlined in Annex 2, several projects dealing with sustainable use, products valorisation and development has been carried out by national and local governments, agencies, breeders associations and consortia. Strategic Priority Area 3: Conservation (please give details for the most relevant institutions for national genebanks / cryopreservation in the table in Annex 1) In situ conservation activities are going on for almost all the Italian AnGR, while the project of a national virtual cryo-bank is not yet fully established, despite the intense work of the -

On the Origin of European Sheep As Revealed By
On the origin of European sheep as revealed by the diversity of the Balkan breeds and by optimizing population-genetic analysis tools Elena Ciani, Salvatore Mastrangelo, Anne da Silva, Fabio Marroni, Maja Ferenčaković, Paolo Ajmone-Marsan, Hayley Baird, Mario Barbato, Licia Colli, Chiara Delvento, et al. To cite this version: Elena Ciani, Salvatore Mastrangelo, Anne da Silva, Fabio Marroni, Maja Ferenčaković, et al.. On the origin of European sheep as revealed by the diversity of the Balkan breeds and by optimizing population-genetic analysis tools. Genetics Selection Evolution, BioMed Central, 2020, 52 (1), pp.25. 10.1186/s12711-020-00545-7. hal-02610772 HAL Id: hal-02610772 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02610772 Submitted on 18 May 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Ciani et al. Genet Sel Evol (2020) 52:25 https://doi.org/10.1186/s12711-020-00545-7 Genetics Selection Evolution RESEARCH ARTICLE Open Access On the origin of European sheep as revealed by the diversity of the Balkan breeds and by optimizing population-genetic analysis tools Elena Ciani1, Salvatore Mastrangelo2, Anne Da Silva3, Fabio Marroni4, Maja Ferenčaković5, Paolo Ajmone‑Marsan6, Hayley Baird7, Mario Barbato6, Licia Colli6, Chiara Delvento1, Toni Dovenski8, Gregor Gorjanc9, Stephen J. -

La Salvaguardia Della Biodiversità Animale
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE LA SALVAGUARDIA DELLA LA SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ ANIMALE Iniziative generali ed azioni intraprese in Italia a tutela delle razze minacciate A cura di Francesco Panella ISBN 978-88-904416-8-4 FONDAZIONE INIZIATIVE FONDAZIONE - BRESCIA E ZOOTECNICHE ZOOPROFILATTICHE EDITO A CURA DELLA FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE - BRESCIA 84 9 788890 441684 84 LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITà ZOOTECNICA BIODIVERSITY CONSERVATION Nella stessa collana sono stati pubblicati i seguenti volumi: l - 1979 Infezioni respiratorie del bovino 2 - 1980 L’oggi e il domani della sulfamidoterapia veterinaria 3 - 1980 Ormoni della riproduzione e Medicina Veterinaria 4 - 1980 Gli antibiotici nella pratica veterinaria 5 - 1981 La leucosi bovina enzootica 6 - 1981 La «Scuola per la Ricerca Scientifica» di Brescia 7 - 1982 Gli indicatori di Sanità Veterinaria nel Servizio Sanitario Nazionale 8 - 1982 Le elmintiasi nell’allevamento intensivo del bovino 9 - 1983 Zoonosi ed animali da compagnia 10 - 1983 Le infezioni da Escherichia coli degli animali 11 - 1983 Immunogenetica animale e immunopatologia veterinaria 12 - 1984 5° Congresso Nazionale Associazione Scientifica di Produzione Animale 13 - 1984 Il controllo delle affezioni respiratorie del cavallo 14 - 1984 1° Simposio Internazionale di Medicina veterinaria sul cavallo da competizione 15 - 1985 La malattia di Aujeszky. Attualità e prospettive di profilassi nell’allevamento suino 16 - 1986