Giorgio La Pira N
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
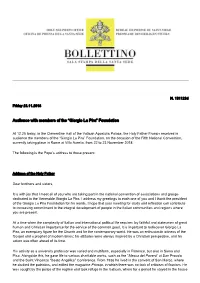
Audience with Members of the “Giorgio La Pira” Foundation
N. 181123d Friday 23.11.2018 Audience with members of the “Giorgio La Pira” Foundation At 12.25 today, in the Clementine Hall of the Vatican Apostolic Palace, the Holy Father Francis received in audience the members of the “Giorgio La Pira” Foundation, on the occasion of the Fifth National Convention, currently taking place in Rome at Villa Aurelia, from 22 to 23 November 2018. The following is the Pope’s address to those present: Address of the Holy Father Dear brothers and sisters, It is with joy that I meet all of you who are taking part in the national convention of associations and groups dedicated to the Venerable Giorgio La Pira. I address my greetings to each one of you and I thank the president of the Giorgio La Pira Foundation for his words. I hope that your meeting for study and reflection can contribute to increasing commitment to the integral development of people in the Italian communities and regions where you are present. At a time when the complexity of Italian and international political life requires lay faithful and statesmen of great human and Christian importance for the service of the common good, it is important to rediscover Giorgio La Pira, an exemplary figure for the Church and for the contemporary world. He was an enthusiastic witness of the Gospel and a prophet of modern times; his attitudes were always inspired by a Christian perspective, and his action was often ahead of its time. His activity as a university professor was varied and multiform, especially in Florence, but also in Siena and Pisa. -

Una Fraterna Amicizia Giorgio La Pira E Il Marocco.Pdf
Una "fraterna amicizia". Giorgio La Pira e il Marocco BRUNA BAGNATO Università di Firenze La "fraterna amicizia"1 che legò Giorgio La Pira alla corte di Rabat, un'amicizia basata su affinità di progetti politici e coltivata con conti nuità di incontri e frequenza di relazioni epistolari, rappresentò, nelle sue premesse e nei suoi sviluppi, l'intersezione di una serie di processi che si andavano sviluppando su piani diversi. L'avvicinamento di La Pira a Rabat e l'approfondirsi dei suoi rapporti sia con Maometto V sia ./ con il principe ereditario e poi successore Hassan rierltraVa&.iO irJatti in una dinamica più complessiva che, dalla seconda metà degli anni Cinquanta, vide ambienti politici, culturali e economici della peniso la particolarmente attenti alle potenzialità di un incremento dei rap porti con i paesi del Mediterraneo. E quindi anche con il regno maroc chino, giunto all'indipendenza nel marzo 1956 al termine di un pro cesso òi riòefinizione dei rapporti con la Francia che aveva conosciu to momenti di grande asprezza2 e che era stato seguito con simpatia 1 Così la definì Giorgio Giovannoni in Giorgio La Pira, TESTL"-IONIANZE, a. XXI, apriìe luglio 1978, nn. 4-5-6-7, p. 399. 2 Sul processo di indipendenza del Marocco esisre una vasta bibliografia. Per limitarsi alle opere maggiori cfr. Ch.-R. Ageron, Politiques coloniales en Maghreb, Paris, PUP, 1973; S. Bernard, Le conflic fraru:o-marocain 1943-1956, Bruxelles, Editions de l'[nstitut de socio logie de l'Univetsité libre dè Bruxelles, 1963, volume ormai datato ma che resta fonda mentale; Ch-A. -

The Vietnam War, the Church, the Christian Democratic Party and the Italian Left Catholics
social sciences $€ £ ¥ Article The Vietnam War, the Church, the Christian Democratic Party and the Italian Left Catholics Daniela Saresella Department of Historical Studies, University of Milan, 20122 Milan, Italy; [email protected] Received: 6 March 2018; Accepted: 28 March 2018; Published: 3 April 2018 Abstract: Over the years of the Cold War, the conflict in Vietnam assumed the significance of a clash between two civilizations, the West and communism. Italian Catholics thus found themselves not only invoking the end of the conflict, but also expressing their evaluations on the choices made in international politics by the two superpowers. The positions assumed by the ecclesiastic Institution, the Christian Democrats and the Catholic world in Italy towards the war in Indochina were not identical: in fact, if—with a few exceptions—the ecclesiastic hierarchy was distinguished by its extreme caution, in the Catholic party different positions became manifest. It was mainly in Catholic associations, and in general amongst believers closer to the experience of the Vatican Council, that a radical sense of aversion to U.S. foreign policy developed. Keywords: Vietnam War; Italian Catholics; Cold War; Italian Church; Christian Democratic Party 1. The Italian Church The sixties saw a period of profound change, not only in the West but in other continents, too: the civil rights movement in the United States, the battles against oppressive regimes in Latin America, the cultural revolution in China, the upheavals in Eastern European countries and the leading role played by young people all enlivened the decade. The Catholic Church was also marked by radical innovations with the pontificate of John XXIII and from 1962 with the start of the Second Vatican Council. -

Guerra Impossível, Segundo O Pensamento Jurídico De Giorgio La Pira
Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l’America Latina Guerra impossível, segundo o pensamento jurídico de Giorgio La Pira Pierangelo Catalano* Índice Introdução. Giorgio La Pira romanista e homem de governo; I. Guerra justa; II Império romano e Nações unidas; III Brasil, América Latina, Europa e a Paz Palabras clave Conflito, diálogo, paz, lei, La Pira Introdução. Giorgio La Pira romanista e homem de governo Muito bem escreveu1 sobre Giorgio La Pira Giuseppe Grosso, diretor da Faculda- de de direito da Universidade de Turim: «Giorgio La Pira, studioso, romanista, uomo di governo, pubblico amministratore locale, forma una personalità monolitica, che ha il suo fulcro in una profonda carica mistico-religiosa... La Pira sindaco non rientra nei normali schemi amministrativi; egli stesso dichiara che la legge in virtù della quale amministra è quella del Vangelo e del diritto romano»2. Os escritos de Giorgio La Pira são, em geral, fundamentados no Evangelho e no Direito romano3. I. Guerra justa 1. 1939. Cícero e a doutrina católica diante da guerra Em maio de 1939 Giorgio La Pira escrevia que ao “grande princípio de justiça” nemini aliquid detrahere, que fundamenta a sociedade humana (Cícero, De off., 3, 6, 26 * Sapienza Università di Roma, Secretário geral da Assla (Associazione di studi sociali latinoamericani). 1 Tradução de Myriam Benarrós, da Sezione di Roma ‘Giorgio La Pira’ do Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (Ittig) do Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). 2 G. Grosso, La Pira Giorgio, in Novissimo digesto italiano, IX, Torino, 1963. 3 Em qualidade de “censore teologo” no Processo de beatificação e canonização do servo de Deus professor Giorgio La Pira, pude dispor dos 19 volumes com os escritos “menores” de 1919 a 1977: G. -

Tilburg University Vatican Diplomacy After the Cuban Missile Crisis
Tilburg University Vatican Diplomacy After the Cuban Missile Crisis Schelkens, K. Published in: The Catholic Historical Review DOI: 10.1353/cat.2011.0153 Publication date: 2011 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in Tilburg University Research Portal Citation for published version (APA): Schelkens, K. (2011). Vatican Diplomacy After the Cuban Missile Crisis: New Light on the Release of Josyf Slipyj. The Catholic Historical Review, 98(4), 680-713. https://doi.org/10.1353/cat.2011.0153 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. sep. 2021 VATICAN DIPLOMACY AFTER THE CUBAN MISSILE CRISIS: NEW LIGHT ON THE RELEASE OF JOSYF SLIPYJ BY KARIM SCHELKENS* The author, drawing on original documentation from several archives, examines the February 1963 release of Josyf Slipyj, the Ukrainian Greek Catholic archbishop, by the Soviet government. -

Power and Poverty: Notes on State Action and the Duty of Purlic Servants
Revista de la Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos POWER AND POVERTY: NOTES ON STATE ACTION AND THE DUTY OF PURLIC SERVANTS E n r iq u e San M ig u e l Pé r e z * Universidad Rey Juan Carlos Abstract: Converting poverty ¡n style is an option in lite that represents the prelude in the fight to eradicate material poverty. And it is an indispensable condition in leaders conceivíng politics and governance who understood that democracy and rule of law could not be rebuilt without integration by the people of Europe. Contemplating life and the testimony of figures such as Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Giuseppe Dossetti or Giorgio La Pira entails an approach to extreme austerity but also as a political argument for the fullness of the democratic experience. Keywords: Poverty. Democracy. Politics. Europe. * [email protected] Volumen 21, p p . 219-224 ; ISSN: 1131-5571 //2 1 9 Enrique San Miguel Pérez “I am poor..."'. A young lawyer from a humble Italian family on the outskirts of the Austro-Hungarian Empire, a member of parliament in Vienna and afterwards in Rome, imprisoned in the fascist dungeons of Regina Coeli prison where he developed a lung infection weighing on his health, wrote to his fiancée, Francesca, in these terms, with whom he would be married after leaving prison in 1929. He was Alcide de Gasperi, and in 1945 he became Prime Minister of the Council of Ministers in an Italy materially ruined by the war and morally by the havoc of Mussolini’s regime. -

Giorgio La Pira
SCRITTI VINCENZIANI Cesare Guasco Una generosa donazione, proveniente dall’eredità di Mons. Agostino Ferrari Toniolo, ha permesso alla Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli di promuovere la pubblicazione di due raccolte di scritti di Giorgio La Pira. La prima è relativa agli “Scritti vincenziani”, la seconda alle “Lettere ai Monasteri femminili di vita contemplativa”[1]. Il primo volume è nato dalla constatazione della scarsa rilevanza data all’appartenenza vincenziana di Giorgio La Pira in occasione delle celebrazioni tenute da varie parti per il primo centenario della sua nascita (2004). Una prima parziale raccolta ciclostilata, a cura della stessa Fondazione, era stata presentata al Convegno tenuto a Viterbo nel 2004 sul tema: “Giorgio La Pira, un vincenziano nel coro della storia”[2]. L’attuale più completo volume raccoglie gli scritti apparsi su “Il Samaritano” (oggi “La San Vincenzo in Italia”) organo ufficiale della Società di San Vincenzo De Paoli italiana e che vanno dal 1950 (anno in cui egli assume la presidenza del Consiglio Superiore Toscano della S. Vincenzo) al 1977, anno della sua scomparsa. Gli scritti, complessivamente 33, sono ordinati secondo quattro aree tematiche: - La Pira, profeta e maestro: scritti spirituali, - La Pira, Ozanam e la Società di San Vincenzo: scritti istituzionali, - La Pira e i giovani: scritti formativi ed operativi, - Miscellanea: altri scritti significativi. Di particolare importanza quelli del secondo gruppo, tra cui i messaggi e le circolari inviate ai soci vincenziani con la convinzione della perenne vitalità della San Vincenzo e tuttavia della necessità della scoperta del nuovo e la comprensione dell’attualità di Ozanam che per la Pira fu un autentico modello di vita spirituale e culturale. -

Thomas Merton and Giorgio La Pira: a Friendship for Peace
Thomas Merton and Giorgio La Pira - Maurizio Renzini Thomas Merton and Giorgio La Pira: Middle East today is the core around which the poli tical history of a Friendship for Peace the world moves: peace or discord in Jerusalem are and will always be the symptoms that reveal peace and discord in nations.'' La Pira was mayor of Florence from 1951 to 1958 and then again between 1961 and 1966, and made the city a symbol of peace, Maurizio Renzini promoting the 'Mediterranean meetings', four important conferences involving the Mediterranean countries and the mayors of the major capitals of the world, with the aim of 'unifying the cities in o rder to The holy ma yor unify the nations'. He was in touch with the most important figures 'Hoping against hope, he believed that he would become in politics and culture of the day, and travelled widely on his mission "the father of many nations'', according to what was of peace, convinced of the prophetic vision of Isaiah: 'T hey shall said, "So numerous shall your descendants be."' beat their swords into ploughshares, and their spears into pruning Romans 4.18 hooks.' (Isaiah 2.4). Thanks to this, and also to the work he did for the poor of Florence animated by deep Christian piety, prayer and This phrase from St Paul's letter to the Romans concerning the role a contemplative spirit, Florentines called him 'the holy mayor'. He and character of Abraham in history can be taken to represent the is honoured as a Servant of God by the Catholic Church and the guiding principle for the human, spiritual and social action of Giorgio process of his beatification has begun. -

On Pilgrimage - October 1963
On Pilgrimage - October 1963 Dorothy Day The Catholic Worker, October 1963, 3, 6, 8. Summary: On a vacation and speaking trip in Italy, she admires the enthusiasm of young students and seminarians. Remarks on the life and conversion of Bill Congdon who acted as an interpreter for one of her talks. Visits Milan, Florence, Assisi, and takes a side trip to see Padre Pio. (DDLW #808). When I was in Milan last May I spoke to the university students and Bill Congdon translated my talk. The meeting was held after a Sunday morning Mass at the Church of St. Anthony, Abbot, when the transepts, and the body of the church were packed with students who began their worship with Prime. it was thrilling to hear the old Latin hymns. The Mass was in the Ambrosian rite and the students sang the Gelineau psalms. A meeting later was held in the Cardinal Shuster School in the paved and roofed-over cloister. It had been made into a large meeting hall, and the imposing rostrum was presided over by a plaque of Ozanam who also started his apostolate as a student and continued it as a teacher and married man. Our own Bishop Wright of Pittsburgh spoke about Ozanam as a model for young men in a talk he gave before the Newman Clubs of the United States. Talk To Milan Students It was easy for me to speak, thanks to that plaque, because it kept me in mind of the spiritual and corporal works of mercy, which all Catholic students understand and which are all-embracing in the intellectual or manual labors which are before them. -

Letter to the Dominican Family in View of the European Elections, May 2019
Letter to the Dominican Family in view of the European elections, May 2019 At a recent meeting of European Friars Promoters of Justice, Peace and Integrity of Creation, we discussed together the importance of the forthcoming elections to the European Parliament, as did other Justice and Peace Commissions of Europe. We decided to share our concern with all the JPIC Promoters of our region. For this, we have written a text that has been sent to all Promotors to collect opinions. The final result is this letter that brings together the challenges outlined for most of us. Circumstances remind us of our Order’s responsibility to read the signs of times in order to give our contribution to the common good. We wish to suggest some fundamental topics that may serve as a starting point for reflection in our communities and apostolate. We will list them briefly, following this methodology: to see, to judge, to act, suggesting, in the end, a reference to some witnesses in the Dominican Family. Migration, xenophobia and racism Migration is a complex epochal phenomenon. It invites us first of all to become aware of its causes: injustice, violence, and economic exploitation in countries of origin. Voluntary, safe, regular and well-managed migration contributes to development and cultural enrichment. Migration is a call to accept the Gospel message of hospitality, of responsibility towards the most vulnerable and of openness to encounter. To be faithful to the Gospel requires a change of mentality and lifestyle as well as the rejection of xenophobia, hostility and those forms of racism that see migrants as scapegoats for the problems of our European societies. -

Matteo Renzi
Matteo Renzi Matteo Renzi nasce a Firenze nel gennaio 1975 e cresce a Rignano sull’Arno. Fin da giovanissimo vive l’esperienza scout, di cui si porterà dietro la voglia di giocare e di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato” (Baden Powell). Questo impegno segna fortemente anche gli anni del liceo, il “Dante” di Firenze, dove Matteo diventa rappresentante di istituto. Da studente universitario della Facoltà di Giurisprudenza contribuisce alla nascita dei “Comitati per Prodi”: è il suo primo impegno in politica. Lavora come dirigente nell’azienda di famiglia che si occupa di servizi di marketing, mentre prosegue l’impegno scout, come capo della branca R/S e come caporedattore della rivista “Camminiamo insieme”. Nel settembre del 1999 sposa Agnese, studentessa di lettere, oggi insegnante nei licei fiorentini, e si laurea in giurisprudenza con la tesi “Firenze 1951-1956: la prima esperienza di Giorgio La Pira Sindaco di Firenze”. E’ autore con altri del libro “Mode – Guide agli stili di strada e in movimento” e di “Ma le giubbe rosse non uccisero Aldo Moro”, insieme a Lapo Pistelli. Nel frattempo è segretario provinciale del Ppi e coordinatore de La Margherita fiorentina. Nel 2004 viene eletto Presidente della Provincia di Firenze: durante il suo mandato riduce le tasse in Provincia, taglia i costi dell’Ente e aumenta gli investimenti in cultura e ambiente. Nel 2008 decide di mettersi di nuovo in gioco: rifiuta la proposta del centrosinistra di candidarsi per un secondo mandato da Presidente della Provincia e il 29 settembre annuncia la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per la corsa a Sindaco di Firenze, con lo slogan “O cambio Firenze o cambio mestiere e torno a lavorare”. -

Foreign Policy Doctrine of the Holy See in the Cold War Europe: Ostpolitik of the Holy See
The Turkish Yearbook of International Relations, Volume 49 (2018), p. 117-141. DOI : 10.1501/Intrel_0000000319 Foreign Policy Doctrine of the Holy See in the Cold War Europe: Ostpolitik of the Holy See Boris Vukicevic Abstract This article deals with the foreign policy of the Holy See during the pontificates of Pope John XXIII and Paul VI which is known as the Ostpolitik of the Holy See. The Ostpolitik signifies the policy of opening the dialog with the communist governments of the Eastern and Central Europe during the Cold War. The article analyzes the factors that influenced it, its main actors and developments, as well as relations of the Holy See with particular countries. It argues that, despite its shortcomings, the Ostpolitik did rise the Holy See’s profile on the international scene and helped preservation of the Catholic Church in the communist Eastern and Central Europe. Keywords The Holy See, Ostpolitik, the Cold War, foreign policy, Eastern Europe Associate Prof. Dr., University of Montenegro, Faculty of Political Science. [email protected] (orcid.org/0000-0002-7946-462X) Makale geliş tarihi : 15.12.2017 Makale kabul tarihi : 06.11.2018 118 The Turkish Yearbook of International Relations, Volume 49 (2018) Introduction The Cold War, unlike any other period in history of international relations, made all the subjects of international relations from all over the world involved into world affairs. One of the more specific actors of this period, dealing more in the background, but still remaining influential, and, arguably, in certain periods, instrumental, was the Holy See. The Holy See, the governing body of the Roman Catholic Church, as a subject of international law and international relations -thus specific among religious organizations- had its own evolution during the Cold War years, as the whole system evolved from confrontation and crises toward détente and coexistence, and then again toward final cooling of relations before the end of this era.