Ii Un'oasi La Sua Culla
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Northern Puglia & the Gargano Promontory
© Lonely Planet Publications 84 www.lonelyplanet.com 85 Northern Puglia & the Gargano Promontory Crowning Italy’s boot, the northern province of Foggia (the capitanata) is an attractive NORTHERN PUGLIA & THE NORTHERN PUGLIA & THE land of contrasting geographical bands, from the mountainous rocky spur of the Gargano GARGANO PROMONTORY Promontory to the vast flat tablelands of the Tavoliere and the gentle rolling hills of the Daunia Pre-Apennines. The Tavoliere is the wheatbowl of southern Italy, covering half of the capitanata in a 3000-sq-km geometric chequerboard of golden fields. Tracks across the plains bear witness to the centuries-old transhumance routes, the ancient droving trails or tratturi along which sheep and cattle were moved from Abruzzo to Puglia. The wheatfields surrounding the provincial capital of Foggia gently give way to the wetlands and salt works of Margherita di Savoia on the southeast coast, a region famous for its prolific birdlife. To the west, the Tavoliere merges into the undulating foothills, shallow valleys and wooded slopes of the beautiful Daunia mountains. Here, castles and towers of the medieval hilltop towns watch over Foggia’s Pre-Apennine border. Puglia’s only mountainous zone is the stunning Gargano Promontory, a blunt spur of limestone cliffs and dense forest jutting into the blue Adriatic Sea. Its landscape, flora and fauna are a geographical anomaly in Puglia’s Mediterranean mezzogiorno, more Croatian than southern Italian. Millions of years ago the Gargano was separated from the mainland by a thin strip of ocean. Now its unique beauty and summer seaside resorts are a favourite with Italian and German tourists. -

Vulture-Santa Croce-Bosco Grande E Laghi Di Monticchio
VULTURE-SANTA CROCE-BOSCO GRANDE E LAGHI DI MONTICCHIO ’ a rea del Vu l t u re e nuti, con D.P.G.R. n. ma di faglie con direzione dei laghi di Montic- 1183 del 1984, riserva N W-SE e NE-SW, la ri- di Maria Carbone Lchio per le sue pecu- naturale regionale per una salita e l’espansione di Liliana Santoro liarità è da lungo tempo estensione di circa 187 magmi attraverso il sub- oggetto di norme di tutela Ha. strato. nazionali e regionali. Infine, nell’ambito della Qu e s t’ultimo è costitui- È, infatti, oggetto di tu- L.R n. 28 del 1994, all’ art. to da rocce sedimentarie e tela ai sensi del R.D. n. 10, è individuata l’ a re a cristalline pre m i o c e n i c h e , 30.12.23 n. 3267 che sta- naturale protetta Vul t u r e - da sedimenti arenacei e bilisce il vincolo idro g e o- S. Croce - Bosco Grande e marnosi del miocene che, l o g i c o. Con De c reto Mi- l’a r ea Lago Grande e Lago si mostrano deformati da nisteriale 18 aprile 1985 Piccolo di Mon t i c c h i o . pieghe e faglie, ed infine fu emanata la dichiarazio- Il Vu l t u re appare un da terreni più re c e n t i ne di notevole intere s s e gigante solitario, isolato (plio-pleistocenici) argillo- pubblico, di cui al decreto come è al centro di una si, sabbiosi e conglomera- ministeriale 4 maggio zona subpianeggiante bor- tici che, hanno subito 1966, riguardante la zo n a data da rilievi a luoghi movimenti verticali. -

Ok Piano Di Controllo Pesca Lago Piccolo Di Monticchio
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale Viale V. Verrastro n. 5 – 85100 POTENZA PIANO DI CONTROLLO DELLE SPECIE ITTICHE ALIENE NELLA RISERVA REGIONALE LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO COD. EUAP 0253 DPGR 1183 IN AGRO DEL COMUNE DI ATELLA E LAGO GRANDE IN COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ) Redatto da: LAGUARDIA Marco; LOGIURATO Antonella; GILIO Carlo; CAFFARO Sandrino. DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale Viale V. Verrastro n. 5 – 85100 POTENZA PREMESSA La conservazione degli ecosistemi naturali attraverso una gestione integrata rappresenta l’approccio teoricamente più corretto per preservare la biodiversità di un determinato territorio; è infatti proteggendo gli ambienti naturali e controllando le popolazioni selvatiche che si garantisce la conservazione delle comunità viventi, prevenendo l’estinzione delle diverse specie. D’altra parte, in alcuni casi le misure di tutela ambientale non appaiono sufficienti per garantire la sopravvivenza di specie minacciate, che presentano popolazioni talmente ridotte o isolate tra loro da non essere più in grado di una ripresa naturale senza l’intervento dell’uomo. In questi casi è necessario seguire un approccio specie specifico, intervenendo direttamente sui taxa fortemente minacciati di estinzione, che richiedono misure urgenti di conservazione. Nonostante la parzialità di questo tipo di approccio, che si focalizza sulla conservazione di una sola specie, le ricadute che ne derivano spesso comportano effetti positivi su altre componenti delle biocenosi, o più in generale su interi ecosistemi. Ed è proprio su una di queste specie ed in particolare sull’alborella del Vulture ( Alburnus vulturius), che ha seguito di una segnalazione in Ufficio Parchi da parte di alcuni componenti l’associazione pesca sportiva A.S.D. -

Bando Monticchio 21-05-2018
COMUNE DI ATELLA (Provincia di Potenza) Prot. 4789/2018 SERVIZIO URBANISTICA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N° 8 LOCALI COMMERCIALI IN LOCALITA’ MONTICHIO LAGHI. Il Responsabile del Servizio In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale. n 75 del 9 maggio 2018 RENDE NOTO CHE E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in regime di locazione di n. 8 locali commerciali ubicati in Monticchio Laghi ARTICOLO 1 Il Comune di Atella nell’ambito del PO-FESR Basilicata 2007/2013 – Asse IV – Linea di Intervento IV .1.1° - PIOT Area Nord ha candidato unitamente ai Comuni di Rionero in V.re e Melfi il “ Completamento degli interventi infrastrutturali riqualificazione Monticchio Laghi “ consistenti nella realizzazione di opere infrastrutturali illuminotecniche e delocalizzazione dei manufatti precari ubicati lungo l’asse viario dell’istmo , ricadenti nell’ Ambito Unitario di Progettazione n° 1 ( AUP 1) da localizzarsi nell’AUP 3 così come previsto dal Piano Particolareggiato di Monticchio - pag. 21 relazione tecnica e N.T.A. ) approvato con D.P.G.R. n° 75 del 26/04/2006. Ottenuto il finanziamento sono stati costruiti 4 manufatti in legno, ciascuno delle dimensioni lorde 7,46 x 14,96 pari ad una superficie di mq. 111,60 oltre ad un manufatto delle dimensioni di mt. 7,46 x 7,60 della superficie di mq. 56,70, realizzando in tal modo 9 unità immobiliari idonee ad ospitare altrettante attività Commerciali. L’edificazione è regolarmente avvenuta e, nelle more della realizzazione, la Regione Basilicata con delibera di Giunta Regionale n° 1409 del 23/10/2012, ha concesso al Comune di Atella l’area di sedime dei manufatti della superficie di mq. -

Caratterizzazione Idrogeochimica E Rapporti Isotopici 87Sr/86Sr Nelle Acque Del Distretto Vulcanico Del Monte Vulture (Basilicata): Implicazioni Idrogeologiche
Giornale di Geologia Applicata 2 (2005) 459–466, doi: 10.1474/GGA.2005–02.0–67.0093 Caratterizzazione idrogeochimica e rapporti isotopici 87Sr/86Sr nelle acque del distretto vulcanico del Monte Vulture (Basilicata): implicazioni idrogeologiche. Maurizio Barbieri1, Gianpietro Summa2 1 Autore corrispondente. Dipartimento Scienze della Terra, Università "La Sapienza", Box n. 11, P.le A. Moro, 5 – 00185 Roma, Tel/Fax + 39 06 49914593 [email protected] 2Dottore di Ricerca in Geologia Applicata ed Ambientale – libero professionista, [email protected] Hydrogeochemistry and 87Sr/86Sr isotope ratios of waters from Monte Vulture (Basilicata): hydrogeological implications ABSTRACT: The paper describes the results of a study that was conducted to determine the relationship between hydrogeochemical composition and hydrogeological knowledge of the Mt. Vulture spring waters. Mount Vulture is a Pleistocene stratovolcano, located in the northeastern sector of the Basilicata region, along the external edge of the Apennine Chain, close to the Bradano river Miocene foredeep. Mount Vulture’s volcanic structure developed during the period 730 and 130 kyr BP, with a maximum activity period in the period of 800 kyr and 580 kys BP. Two hydrogeologically independent groundwater basins have been found: Monticchio-Atella and Melfi-Barile. In the Monticchio-Atella groundwater basin the representative hydrogeochemical type is sodium-bicarbonate, associated with high grade mineralization of groundwater. The latter is characterised by CO2 relative abundance (with values up to about 4000 mg/l), by electrical conductivity ranging between 200 and 19.000 µS/cm and by a temperature ranging between 10°C and about 20°C. The highest CO2 values have been detected in the Monticchio area, where the last eruption of Monte Vulture occurred. -

Europaea (Lepidoptera: Brahmaeidae)
Fragmenta entomologica, 46 (1-2): 1-9 (2014) ISSN: 0429-288X Review article An overview on the most outstanding Italian endemic moth, Brahmaea (Acanthobrahmaea) europaea (Lepidoptera: Brahmaeidae) Fabio MOSCONI 1,2,*, Alberto ZILLI 3, Renato SPICCIARELLI 4, Emanuela MAURIZI 1,5, Augusto VIGNA TAGLIANTI 6, Paolo AUDISIO 2,6 1 Council for Agricultural Research and Economics, Research Centre for Agrobiology and Pedology (C.R.A.-A.B.P) - Via Lanciola 12/A, I-50125 Cascine del Riccio (Florence), Italy - [email protected] 2 Department of Biology and Biotechnologies “Charles Darwin”, Sapienza University of Rome - Via Alfonso Borelli 50, I-00161 Rome, Italy - [email protected] 3 The Natural History Museum, Life Sciences, Insect Division - DC2-2N, Cromwell Road, London SW7 5BD, UK - [email protected] 4 School of Agricultural, Forest, Food and Environmental Sciences (SAFE), University of Basilicata - Viale dell’Ateneo Lucano 10, I-85100 Potenza, Italy - [email protected] 5 Department of Sciences, Roma Tre University - Viale Guglielmo Marconi 446, I-00146 Rome, Italy - [email protected] 6 Museum Centre, Zoological Museum, Department of Biology and Biotechnologies “Charles Darwin”, Sapienza University of Rome - Piazzale Valerio Massimo 6, I-00162 Rome, Italy - [email protected] * Corresponding author Abstract The state of knowledge about the European Bramea, Brahmaea (Acanthobrahmaea) europaea Hartig, 1963, is briefly summarized in re- lation to growing concern about the conservation status of the most outstanding Italian endemic moth species. Key words: Brahmaea (Acanthobrahmaea) europaea, Brahmaeidae, Lepidoptera, endemic species, host-plants, conservation, Italy. Introduction Taxonomy and Systematics Brahmaea (Acanthobrahmaea) europaea Hartig, 1963 Brahmaea (Acanthobrahmaea) europaea Hartig, 1963 (Fig. -

CARMINE CROCCO Come Divenni Brigante
CARMINE CROCCO Come divenni brigante Autobiografia - a cura di Mario Proto INTRODUZIONE 1) MELFI E LE METAMORFOSI DELLA CONDIZIONE MERIDIONALE Rileggere l'Autobiografia di Carmine Crocco, capo leggendario del brigantaggio lucano post-unitario, a più di trent'anni dalla celebrazione per l'Unità d'Italia, consumatasi in un clima euforico e retorico, non significa solo ricollocarla in una luce diversa e più attuale, ma anche riproporla come documento contraddittorio e tipico di una condizione meridionale, ancor oggi sospesa tra un rivendicazionismo, sia pur dotto, ed un secessionismo di bassa lega. Ripubblicata nel 1964 dall'Editore Lacaita, nella collana “Briganti e Galantuomini”, a cura di T. Pedio, l'autobiografia di C. Crocco si presentava ai lettori quale testimonianza di una lotta sociale perduta contro padroni vecchi e nuovi, pronti a riciclarsi come dirigenti della futura classe politica nazionale. L'iniziativa editoriale marcava una decisa intenzione di rivelare gli aspetti poco noti di un processo unitario, che registrava l'emarginazione, anch'essa violenta, di una parte cospicua della popolazione meridionale dai benefici di uno Stato unificato e nazionale. Il paesaggio naturale che ha fatto da sfondo all'intera vicenda, e cioè la zona di Melfi, territorio strategico per i movimenti militari della banda di C. Crocco e per l'offensiva dell'esercito sabaudo, può, alla luce di quanto è accaduto prima e dopo, costituire un'espressione emblematica della metamorfosi subita da alcune realtà meridionali dal Medioevo ad oggi. Alla vigilia delle celebrazioni fridericiane, per ricordare la nascita del grande sovrano di casa sveva, non è di poco conto immaginare un'ipotesi di confronto tra il passato e il presente di Melfi e dei suo circondano. -

Methods and Applications of Tephrochronology in Sedimentary Archives
STR14/01 Sabine Wulf Methods and applications of tephrochronology in sedimentary archives Scientific Technical Report STR14/01 ISSN 1610-0956 and applications of tephrochronologyin sedimentary archives Methods Wulf, S. www.gfz-potsdam.de Recommended citation: Wulf, S. (2012), Methods and applications of tephrochronology in sedimentary archives. Scientific Technical Report 14/01, GFZ German Research Centre for Geosciences. Citation example for individual chapters: Wulf, S. (2012) Tephra correlation and databases. In: Wulf, S. (2012), Methods and applications of tephrochronology in sedimentary archives (pp.23-24). Scientific Technical Report 14/01, GFZ S. Wulf German Research Centre for Geosciences. Methods and applications of tephrochronology in sedimentary archives Habilitation zur Erlangung des akademischen Grades „doctor rerum naturalium habilitatus“ (Dr. rer. nat. habil.) in der Wissenschaftsdisziplin Geologie eingereicht in Form einer kumulativen Arbeit an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam Imprint Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences Telegrafenberg D-14473 Potsdam Published in Potsdam, Germany Dezember 2012 ISSN 2190-7110 DOI: 10.2312/GFZ.b103-14010 URN: urn:nbn:de:kobv:b103-14010 Scientific Technical Report STR14/01 This work is published in the GFZ series Scientific Technical Report (STR) and electronically available at GFZ website www.gfz-potsdam.de Recommended citation: Wulf, S. (2014), Methods and applications of tephrochronology in sedimentary archives. Scientific Technical Report 14/01, GFZ German Research Centre for Geosciences. Citation example for individual chapters: Wulf, S. (2014) Tephra correlation and databases. In: Wulf, S. (2014), Methods and applications of tephrochronology in sedimentary archives (pp.23-24). Scientific Technical Report 14/01, GFZ Sabine Wulf German Research Centre for Geosciences. -

Basilicata, Italy: a Tiny Treasure of Passion and Peppers Published/Revised September 17, 2014 by Guest Contributor — 1 Comment Share
! " # $ HOME ABOUT US WRITERS GETTING IN TOUCH TOP CITIES WESTERN EUROPE SOUTHERN EUROPE NORTHERN EUROPE EASTERN EUROPE TRAVEL TIPS Basilicata, Italy: a Tiny Treasure of Passion and Peppers Published/Revised September 17, 2014 By Guest Contributor — 1 Comment Share The Basilicata, located at the instep of Italy’s geographic “boot”, is one of the country’s smaller regions, one of its least-densely populated, most mountainous, and most often overlooked. But within its 3,869 square miles (slightly under 10,000 square km) are: a UNESCO World Heritage site (Matera) Italy’s largest national park (Parco Nazionale del Pollino) the longest escalator-and-pedestrian mobility system in Europe (in Potenza) two of Italy’s unique 40 alberghi diffusi (multi-structure hotels, one in Potenza province, the other in Matera province) a world-class wine (Aglianico del Vulture) Roman artefacts Medieval art Renaissance architecture and modern accoutrements dear to the most demanding visitor. A BASILICATA LANDSCAPE All of which are enhanced by the warmth and cordiality of the Lucanesi (the Italian name for residents of Basilicata, because it was known as Lucania in Roman times). The name Basilicata may derive from basilikos – the Byzantine official in charge of administrating the region during Greek rule. Or the name may refer to the Basilica of Acerenza, which held judicial power in the Middle Ages. Whatever their name, the locals embody the best of southern Italian sentiment with an economic performance more associated with the north (the region’s employment rate and GDP are both higher than the average for the south). BIRDS EYE VIEW OF MATERA A tour of Basilicata might begin with a rental car at the airport of Bari, which is actually in the capital of neighboring Puglia. -
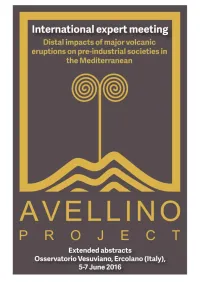
Here the Substantial Early Bronze Age Population of Campania Could Have Flown To, and What Impacts It Would Have Had There
Participant Affiliation Contact Albore Livadie, Claude French national centre for scientific research & [email protected] Archeologia-Lettere, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli Alessandri, Luca Institute of Archaeology, University of Groningen [email protected] Attema, Peter Institute of Archaeology, University of Groningen [email protected] Arienzo, Ilenia Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, [email protected] Sect Osservatorio Vesuviano, Naples Bakels, Corrie Faculty of Archaeology, Leiden University [email protected] Blong, Russell Aon Benfield Group, Sydney, Australia [email protected] Bruins, Hendrik Bona Terra Department of Man in the Desert, [email protected] Ben-Gurion University of the Negev (Israel) Di Rita, Federico Department of Environmental Biology, Sapienza [email protected] University of Rome de Vita, Sandro Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, [email protected] Sect Osservatorio Vesuviano, Naples Di Vito, Mauro National institute of Geophysics and Volcanology, [email protected] Rome Doorenbosch, Marieke Faculty of Archaeology, Leiden University [email protected] Driessen, Jan Faculté de philosophie, arts et lettres, Université [email protected] catholique de Louvain Field, Michael Faculty of Archaeology, Leiden University [email protected] Grattan, John Institute of Geography and Earth Sciences, [email protected] University of Wales, Aberystwyth (UK) Pacciarelli, Marco University of Naples (Italy) [email protected] -

Natural History Museum of Vulture (Adopted with Directive Determination No
Services Charter Natural History Museum of Vulture (adopted with Directive Determination no. 3829 del 27 december 2016) Telephone exchange/fax: 0972-731028 Website address: www.provincia.potenza.it e-mail: [email protected] INTRODUCTION The Services Charter is a communication and information tool that allows users of the Natural History Museum of Vulture to know the services offered, to check that commitments are respected, and to express their feedback through complaints. The adoption of the Services Charter promotes a broader appreciation of historical and cultural heritage kept in the Natural History Museum of Vulture, to adapt the organization of activities to users’ expectations. PRESENTATION OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM OF VULTURE The Natural History Museum of Vulture is located in the beautiful Monticchio Abbey. This Abbey is suspended on a rock ridge that is reflected on the smallest volcanic lakes of Mount Vulture. After the earthquakes of 1456, the Museum became the refuge of Benedictine monks of the Sant’Ippolito Abbey. They occupied pre-existent caves populated by Basilian monks. In the Abbey there are beautiful byzantine frescoes recently restored. Present building was built by Capuchin monks, who settled there around 1600. The Museum occupies three of the four levels of the building and tells the long history of 750.000 years of Vulture, a volcano that became extinct 130.000 years ago. The Province of Potenza has realized the Museum that comes from an idea of the Professor Renato Spicciarelli. Each level of the Museum correspond s to each research and study section, dedicated to the activities connected to the anthropization process of the territory, to flora and fauna and to educational workshop. -
SIC “MONTE VULTURE E LAGHI DI MONTICCHIO” Itinerario a Cura Di E
ESCURSIONE AL SIC “MONTE VULTURE E LAGHI DI MONTICCHIO” Itinerario a cura di E. Fulco e M. Campochiaro Introduzione Il SIC/ZPS “Monte Vulture” si estende per poco meno di 2000 ha nei territori comunali di Atella, Melfi, Rionero in Vulture, nella estremità Nord-Est della Basilicata, in un„area che vedrà la prossima istituzione di un parco regionale. Inoltre l‟area del Lago Piccolo di Monticchio fa parte una Riserva Regionale di 179 ha. E‟ un sito unico nel suo genere per l‟Appennino meridionale: un cono vulcanico di origine pliopleistocenica, ormai spento, presenta le vecchie caldere occupate da due pittoreschi laghi. La fertilità del suolo vulcanico e la presenza di particolarissime condizioni microclimatiche fanno sì che le pendici del vecchio vulcano siano ammantate da boschi rigogliosi di querce, castagni e faggi. In questi boschi a tratti impenetrabili e ricchi di anfratti naturali si sono svolti importanti episodi di storia del brigantaggio nel post unità d‟Italia: qui si nascondeva il brigante Carmine Crocco, noto per aver dato una vera e propria organizzazione militare alla resistenza contro i Savoia. Nella zona dei laghi vi è la presenza di habitat significativi dal punto di vista conservazionistico quali comunità di idrofite natanti o radicanti sul fondo come Potamogeton sp. e la rara Nynphea alba, che copre il lago grande con le sue evidenti fioriture primaverili. Sulle sponde dei laghi si insediano comunità di ambiente ripariale caratterizzate da Ontano nero, Pioppi e significativi nuclei di Frassino meridionale che ospitano una farfalla notturna endemica, la Achantobramea europaea. L‟area del Vulture è sottoposta a forti pressioni antropiche: meta frequentatissima dai turisti, è famosa per la ricchezza di acque minerali qui imbottigliate ed esportate in tutta Italia, ed è zona strategica per l‟enogastronomia lucana, per la produzione del Marroncino di Melfi, prodotto D.O.P., e dell'Aglianico del Vulture, annoverato tra i più grandi vini rossi d'Italia.