FOSS4G ITALIA 2019 - Abstracts
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Spatial Data Science for Addressing Environmental Challenges in the 21St Century
Spatial Data Science for addressing environmental challenges in the 21st century By Jenny Lizbeth Palomino A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Environmental Science, Policy, and Management In the Graduate Division Of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Maggi Kelly, Chair Professor Matthew Potts Professor Iryna Dronova Spring 2018 Spatial Data Science for addressing environmental challenges in the 21st century Copyright © 2018 By Jenny Lizbeth Palomino Abstract Spatial Data Science for addressing environmental challenges in the 21st century By Jenny Lizbeth Palomino Doctor of Philosophy in Environmental Science, Policy, and Management University of California, Berkeley Professor Maggi Kelly, Chair The year 2005 sparked a geographic revolution through the release of Google Maps, arguably the first geographic tool to capture public interest and act as a catalyst for neogeography (i.e. the community of non-geographers who built tools and technologies without formal training in geography). A few years later, in 2008, the scientific community witnessed another major turning point through open access to the Landsat satellite archive, which had been collecting earth observation data since 1972. These moments were critical starting points of an explosion in geographic tools and data that today remains on a rapid upward trajectory. In more recent years, new additions in data and tools have come from the Free and Open Source Software (FOSS), open and volunteered data movements, new data collection methods (such as unmanned aerial vehicles, micro-satellites, real-time sensors), and advances in computational technologies such as cloud and high performance computing (HPC). -

Navegação Turn-By-Turn Em Android Relatório De Estágio Para A
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA Navegação Turn-by-Turn em Android Relatório de estágio para a obtenção do grau de Mestre em Informática e Sistemas Autor Luís Miguel dos Santos Henriques Orientação Professor Doutor João Durães Professor Doutor Bruno Cabral Mestrado em Engenharia Informática e Sistemas Navegação Turn-by-Turn em Android Relatório de estágio apresentado para a obtenção do grau de Mestre em Informática e Sistemas Especialização em Desenvolvimento de Software Autor Luís Miguel dos Santos Henriques Orientador Professor Doutor João António Pereira Almeida Durães Professor do Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas Instituto Superior de Engenharia de Coimbra Supervisor Professor Doutor Bruno Miguel Brás Cabral Sentilant Coimbra, Fevereiro, 2019 Agradecimentos Aos meus pais por todo o apoio que me deram, Ao meu irmão pela inspiração, À minha namorada por todo o amor e paciência, Ao meu primo, por me fazer acreditar que nunca é tarde, Aos meus professores por me darem esta segunda oportunidade, A todos vocês devo o novo rumo da minha vida. Obrigado. i ii Abstract This report describes the work done during the internship of the Master's degree in Computer Science and Systems, Specialization in Software Development, from the Polytechnic of Coimbra - ISEC. This internship, which began in October 17 of 2017 and ended in July 18 of 2018, took place in the company Sentilant, and had as its main goal the development of a turn-by- turn navigation module for a logistics management application named Drivian Tasks. During the internship activities, a turn-by-turn navigation module was developed from scratch, while matching the specifications indicated by the project managers in the host entity. -

OSM Datenformate Für (Consumer-)Anwendungen
OSM Datenformate für (Consumer-)Anwendungen Der Weg zu verlustfreien Vektor-Tiles FOSSGIS 2017 – Passau – 23.3.2017 - Dr. Arndt Brenschede - Was für Anwendungen? ● Rendering Karten-Darstellung ● Routing Weg-Berechnung ● Guiding Weg-Führung ● Geocoding Adress-Suche ● reverse Geocoding Adress-Bestimmung ● POI-Search Orte von Interesse … Travelling salesman, Erreichbarkeits-Analyse, Geo-Caching, Map-Matching, Transit-Routing, Indoor-Routing, Verkehrs-Simulation, maxspeed-warning, hazard-warning, Standort-Suche für Pokemons/Windkraft-Anlagen/Drohnen- Notlandeplätze/E-Auto-Ladesäulen... Was für (Consumer-) Software ? s d l e h Mapnik d Basecamp n <Garmin> a OSRM H - S QMapShack P Valhalla G Oruxmaps c:geo Route Converter Nominatim Locus Map s Cruiser (Overpass) p OsmAnd p A Maps.me ( Mapsforge- - e Cruiser Tileserver ) n MapFactor o h Navit (BRouter/Local) p t r Maps 3D Pro a Magic Earth m Naviki Desktop S Komoot Anwendungen Backend / Server Was für (Consumer-) Software ? s d l e h Mapnik d Garmin Basecamp n <Garmin> a OSRM H “.IMG“ - S QMapShack P Valhalla Mkgmap G Oruxmaps c:geo Route Converter Nominatim Locus Map s Cruiser (Overpass) p OsmAnd p A Maps.me ( Mapsforge- - e Cruiser Tileserver ) n MapFactor o h Navit (BRouter/Local) p t r Maps 3D Pro a Magic Earth m Naviki Desktop S Komoot Anwendungen Backend / Server Was für (Consumer-) Software ? s d l e h Mapnik d Basecamp n <Garmin> a OSRM H - S QMapShack P Valhalla G Oruxmaps Route Converter Nominatim c:geo Maps- Locus Map s Forge Cruiser (Overpass) p Cruiser p A OsmAnd „.MAP“ ( Mapsforge- -
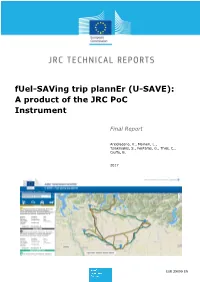
U-SAVE): a Product of the JRC Poc Instrument
fUel-SAVing trip plannEr (U-SAVE): A product of the JRC PoC Instrument Final Report Arcidiacono, V., Maineri, L., Tsiakmakis, S., Fontaras, G., Thiel, C., Ciuffo, B. 2017 EUR 29099 EN This publication is a Technical report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policymaking process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of this publication. Contact information Name: Biagio Ciuffo Address: European Commission, Joint Research Centre, Via E. Fermi 2749, I-21027, Ispra (VA) - Italy Email: [email protected] Tel.: +39 0332 789732 JRC Science Hub https://ec.europa.eu/jrc JRC110130 EUR 29099 PDF ISBN 978-92-79-79359-2 ISSN 1834-9424 doi:10.2760/57939 Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 © European Union, 2017 Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). For any use or reproduction of photos or other material that is not under the EU copyright, permission must be sought directly from the copyright holders. How to cite this report: Arcidiacono, V., Maineri, L., Tsiakmakis, S., Fontaras, G., Thiel, C. and Ciuffo, B., fUel- SAVing trip plannEr (U-SAVE): A product of the JRC PoC Instrument - Final report, EUR 29099 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-79359-2, doi:10.2760/57939, JRC110130. -
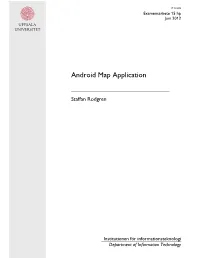
Android Map Application
IT 12 032 Examensarbete 15 hp Juni 2012 Android Map Application Staffan Rodgren Institutionen för informationsteknologi Department of Information Technology Abstract Android Map Application Staffan Rodgren Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Nowadays people use maps everyday in many situations. Maps are available and free. What was expensive and required the user to get a paper copy in a shop is now Besöksadress: available on any Smartphone. Not only maps but location-related information visible Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 on the maps is an obvious feature. This work is an application of opportunistic Hus 4, Plan 0 networking for the spreading of maps and location-related data in an ad-hoc, distributed fashion. The system can also add user-created information to the map in Postadress: form of points of interest. The result is a best effort service for spreading of maps and Box 536 751 21 Uppsala points of interest. The exchange of local maps and location-related user data is done on the basis of the user position. In particular, each user receives the portion of the Telefon: map containing his/her surroundings along with other information in form of points of 018 – 471 30 03 interest. Telefax: 018 – 471 30 00 Hemsida: http://www.teknat.uu.se/student Handledare: Liam McNamara Ämnesgranskare: Christian Rohner Examinator: Olle Gällmo IT 12 032 Tryckt av: Reprocentralen ITC Contents 1 Introduction 7 1.1 The problem . .7 1.2 The aim of this work . .8 1.3 Possible solutions . .9 1.4 Approach . .9 2 Related Work 11 2.1 Maps . 11 2.2 Network and location . -

Geo-Information Fusion for Time-Critical Geo-Applications
Geo-Information Fusion for Time-Critical Geo-Applications Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) des Fachbereichs Mathematik/Informatik der Universität Osnabrück Vorgelegt von Florian Hillen Betreuer: Prof. Dr. Norbert de Lange Institut für Geoinformatik und Fernerkundung Universität Osnabrück November, 2015 Abstract This thesis is addressing the fusion of geo-information from different data sources for time-critical geo-applications. Such geo-information is extracted from sensors that record earth observation (EO) data. In recent years the amount of sensors that provide geo-information experienced a major growth not least because of the rising market for small sensors that are nowadays integrated in smartphones or recently even in fitness wristbands that are carried at the body. The resulting flood of geo-information builds the basis for new, time-critical geo-applications that would have been inconceivable a decade ago. The real-time characteristics of geo-information, which is also getting more important for traditional sensors (e.g. remote sensors), require new methodologies and scientific investigations regarding aggregation and analysis that can be summarised under the term geo-information fusion. Thus, the main goal of this thesis is the investigation of fusing geo-information for time-critical geo-applications with the focus on the benefits as well as challenges and obstacles that appear. Three different use cases dealing with capturing, modelling and analysis of spatial information are studied. In that process, the main emphasis is on the added value and the benefits of geo-information fusion. One can speak of an “added value” if the informational content can only be derived by the combination of information from different sources, meaning that it cannot be derived from one source individually. -

Reference Info for Locus Pro Mapping System (April 2016) QAP Robert B
Reference Info for Locus Pro Mapping System (April 2016) QAP Robert B. Denny Maricopa County Sheriff's Office Air Support Division [email protected] 480-396-9700 (o) 480-707-8128 (c) Required Apps (Google Store) - Install These First: Locus Map Pro - Outdoor GPS (https://play.google.com/store/apps/details?id=menion.android.locus.pro) File Manager HD (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhmsoft.fm.hd) To get started (it's best if you are on a fast WiFi!): 1. Go to http://solo.dc3.com/avtablet and work through the steps on the page reachable via Click Here for New Tablet Setup (link at the bottom of the page). This will get the tablet into a good starting condition including zillions of Maricopa County waypoints and enable some useful maps for online access. Now download the offline maps you want from the main page. This will take considerable time even with a fast internet connection if you want them all! 2. Watch the various videos that you can reach from the above web page. These display nice on your tablet full screen and HD. 3. Plan to explore this app. There is a ton of capability here. I've provided you with a jump start including an initial settings configuration (there are a million settings), over 600 waypoints in Maricopa County, A variety of offline map imagery for Maricopa county, and a support website that at least somewhat makes it easy for non- technical; people to load up and use this fabulous tool. -

Maps.Me Pro Apk Download
Maps.me pro apk download CLICK TO DOWNLOAD renuzap.podarokideal.ru app offers worldwide navigation service with its offline maps. You get driving directions and travel guides to new areas and locations that you might be exploring. This maps and navigation app also shows popular locations with proper integrated Wikipedia descriptions right on the map. With the ability to book a hotel straight from theRead Morerenuzap.podarokideal.ru renuzap.podarokideal.ru - maps of all countries of the world. Needed at home and in travel. Work offline. Download. Download; For business; Partners; Help; Routes; Locals; Book a Hotel; Contacts; Maps; Blog; Destinations; Games; Mail; English. Back; Free offline world maps. Find your way anywhere in the world! Download APK. renuzap.podarokideal.ru features. Free, detailed renuzap.podarokideal.ru Download renuzap.podarokideal.ru APK - renuzap.podarokideal.ru is a free turn-by-turn navigation app that’s free and which work completely renuzap.podarokideal.ru://renuzap.podarokideal.ru · Fast, detailed and entirely offline maps with turn-by-turn navigation – trusted by over million travelers worldwide. OFFLINE MAPS Save mobile data, no internet is required. NAVIGATION Use driving, walking and cycle navigation anywhere in the world. TRAVEL GUIDES Save you time planning the trip and never miss an interesting place with our ready-made travel renuzap.podarokideal.ru://renuzap.podarokideal.ru?id=renuzap.podarokideal.ru renuzap.podarokideal.ru — not just an app but a friend in all your adventures Download a map, choose your route, and get ready for a great journey million downloads. around the world. 12 million users. choose renuzap.podarokideal.ru for their journeys. -

Disseny I Desenvolupament D'una Eina De Suport a La Presa De Decisió a La Realització De Rescats De Muntanya
DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'UNA EINA DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIÓ A LA REALITZACIÓ DE RESCATS DE MUNTANYA Treball final de Màster FIB, MEI Director: Jaume Figueras Ponent: Jordi Montero Autor: Francesc de Paula de Puig Guixé I Agraïments M’agradaria agrair a l’InLab FIB, i en concret al seu director Josep Casanovas, l’oportunitat d’haver desenvolupat aquest projecte i l’experiència i coneixements adquirits durant la meva estada que de bon segur em suposaran un gran impuls en el mon laboral També m’agradaria agrair al meu director Jaume Figueras pel suport i seguiment al llarg del projecte i per introduir-me en el mon de les tecnologies GIS. A en Jordi Montero professor ponent d’aquest projecte, agrair també el seu seguiment, suport i els seus coneixements. M’ha donat uns grans consells sobre com realitzar aquesta memòria. Agrair a la Loreto Vaquero el seu suport durant la realització d’aquest projecte i sobretot en les ultimes hores de la redacció de la memòria M’agradaria agrair el suport de tota la família, sobretot en aquest últim mes on no he passat per casa. Però també durant tota la durada del màster. Ajudant-me en tasques que són de la meva responsabilitat fent-me possible cursar aquest màster i realitzar el meu projecte No puc acomiadar-me sense agrair el suport i dedicar aquest projecte al meu tiet, amic i company d’excursions Josep de Puig Viladrich que ens va deixar durant la realització d’aquest projecte. Sense vosaltres aquest projecte no hauria estat possible. -

Qt1z9045sx.Pdf
UC Berkeley UC Berkeley Previously Published Works Title A review of the emergent ecosystem of collaborative geospatial tools for addressing environmental challenges Permalink https://escholarship.org/uc/item/1z9045sx Authors Palomino, J Muellerklein, OC Kelly, M Publication Date 2017-09-01 DOI 10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.003 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Computers, Environment and Urban Systems 65 (2017) 79–92 Contents lists available at ScienceDirect Computers, Environment and Urban Systems journal homepage: www.elsevier.com/locate/ceus Review A review of the emergent ecosystem of collaborative geospatial tools for addressing environmental challenges Jenny Palomino a,b, Oliver C. Muellerklein a, Maggi Kelly a,b,c,⁎ a Department of Environmental Sciences, Policy and Management, University of California, Berkeley, Berkeley, CA 94720-3114, United States b Geospatial Innovation Facility, University of California, Berkeley, United States c University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, United States article info abstract Article history: To solve current environmental challenges such as biodiversity loss, climate change, and rapid conversion of nat- Received 30 December 2016 ural areas due to urbanization and agricultural expansion, researchers are increasingly leveraging large, multi- Received in revised form 17 April 2017 scale, multi-temporal, and multi-dimensional geospatial data. In response, a rapidly expanding array of collabo- Accepted 17 May 2017 rative geospatial tools is being developed to help collaborators share data, code, and results. Successful navigation Available online xxxx of these tools requires users to understand their strengths, synergies, and weaknesses. In this paper, we identify the key components of a collaborative Spatial Data Science workflow to develop a framework for evaluating the Keywords: Spatial Data Science various functional aspects of collaborative geospatial tools. -

Free Live Maps
Free live maps click here to download Live maps guide is designed to help you understand and navigate live map data. For years countries and businesses have been putting satellites into space. Live maps Satellite view opens up new methods of staying in touch, sharing information, locating addresses and now, it allows you to view specific addresses. Zoom into new NASA satellite and aerial images of the Earth, updated every day. Live maps Satellite view opens up new methods of staying in touch, sharing information, locating addresses and now, it allows you to view. Map multiple locations, get transit/walking/driving directions, view live traffic conditions, plan trips, view satellite, aerial and street side imagery. Do more with. Large map . Watch the spacecraft departure live at www.doorway.ru Dragon has been loaded with more than 3, pounds of cargo and research to be. Check out the best selection of live satellite map images aropund the globe on our aerial maps live portal for FREE. Waze is a free social mobile app that enables drivers to build and use live maps, real-time traffic updates and turn-by-turn navigation for an optimal commute. EarthCam is the leading network of live webcams and offers the most comprehensive search engine of internet cameras from around the world. EarthCam also. Every now and then I go looking for a free aerial view of my home. What is really cool about these satellite views is that they're live. The main difference between Google Maps and Google Earth is that you have to. -
Univerzita Palackého V Olomouci Přírodovědecká Fakulta Katedra Geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky HODNOCENÍ PŘESNOSTI SPORTOVNÍCH GPS POMŮCEK Bakalářská práce David ŠULC Vedoucí práce: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. Olomouc 2016 Geoinformatika a geografie ANOTACE Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení polohových a délkových přesností sportovních GPS pomůcek. Do souboru vybraných pomůcek jsou zahrnuty takzvané sportovní tracker (záznamové) aplikace, GPS hodinky a turistické GPS. Cílem práce je otestování přesnosti výstupů, které sportovní pomůcky poskytují v jednotlivých provozních režimech (chůze, běh, jízda na kole) a v různém prostředí (trasy s dobrými a špatnými observačními podmínkami) s přihlédnutím k vnějším vlivům, kterými je myšleno zejména počet družic a Kp-index. Výstupem práce je slovní i statistický popis přesnosti v závislosti na různých faktorech a v programovacím jazyce python vytvořený skript pro výpočet polohových odchylek. Analýzy naměřených dat porovnávají zaznamenané vzdálenosti z hlediska zjištění přesnosti jednotlivých pomůcek, chování přístrojů, vlivu vybrané sportovní činnosti i lokality a Kp-indexu. Ke srovnání naměřených délek a poloh jsou použity přesně zjištěné referenční hodnoty s přesností kolem deseti centimetrů. KLÍČOVÁ SLOVA GPS, délková přesnost, polohová přesnost, aplikace, Garmin Počet stran práce: 59 Počet příloh: 5 (z toho 2 volné a 1 elektronická) ANOTATION The bachelor thesis is concentrating on assessment of position and length accuracy of sport GPS equipments. The set of chosen equipments contains sport trackers applications, GPS watches and tourist GPS. The aim of the thesis is testing of accuracy of outputs which are provided with sport equipments in individual regimes (walking, running, cycling) and in various surroundings (routes with good and bad observational conditions) in consideration of external influences, especially the number of satellites and Kp-index.