Sesso, Androidi E Carne Vegana Avventure Ai Limiti Di Cibo, Eros E Morte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Report of Interstate and Overseas Travel Undertaken by Members of Parliament Funded by the Imprest System
REPORT OF INTERSTATE AND OVERSEAS TRAVEL UNDERTAKEN BY MEMBERS OF PARLIAMENT FUNDED BY THE IMPREST SYSTEM FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 This report contains a summary of all interstate and overseas travel undertaken by Members of Parliament on official business funded by the Imprest system. REPORT OF INTERSTATE AND OVERSEAS TRAVEL UNDERTAKEN BY MEMBERS OF PARLIAMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 FUNDED BY THE IMPREST SYSTEM MEMBERS OF PARLIAMENT PARLIAMENT TRAVEL - IMPREST SYSTEM INTERSTATE TRAVEL I BRITZA MLA (M) 08-Apr-11 11-Apr-11 HOBART INVITED TO SPEAK TO KAREN $3,037 PEOPLE AND MEETINGS WITH REPRESENTATIVES OF STATESIDE CONSTRUCTIONS J QUIGLEY MLA (M) 17-Apr-11 20-Apr-11 SYDNEY VARIOUS MEETINGS FOR $1,630 TOURISM AND TRAINING PROJECT P TINLEY MLA (M) 19-Apr-11 26-Apr-11 CANBERRA, SERIES OF MEETINGS $4,080 SYDNEY RELATED TO WESTERN AUSTRALIA HON T STEPHENS MLA (M) 25-Apr-11 01-May-11 CANBERRA, MEETINGS WITH MINISTERIAL $4,227 SYDNEY OFFICE STAFF IN CANBERRA AND MEETING IN REFERENCE TO SPONSORSHIP OF AN INDIGENOUS PROJECT J WOOLLARD MLA (M) 02-May-11 06-May-11 MELBOURNE VARIOUS MEETINGS $4,678 REGARDING EARLY CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION T SIMPSON MLA (M) 13-May-11 15-May-11 HOBART DEAF AUSTRALIA INC. $1,884 NATIONAL CONFERENCE AND 25TH ANNIVERSARY CELEBRATION L BAKER MLA (M) 13-May-11 15-May-11 BRISBANE NATIONAL LABOR WOMENS $1,974 CONFERENCE C MARTIN MLA (M) 13-May-11 16-May-11 BRISBANE NATIONAL LABOR WOMENS $4,577 CONFERENCE J FREEMAN MLA (M) 14-May-11 15-May-11 BRISBANE NATIONAL LABOR WOMENS $4,502 CONFERENCE -
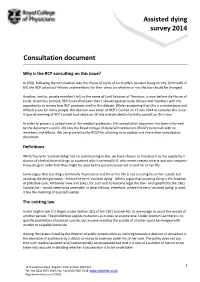
Dr Andrew Hilson FRCP
Assisted dying survey 2014 Consultation document Why is the RCP consulting on this issue? In 2006, following the introduction into the House of Lords of Lord Joffe's Assisted Dying for the Terminally Ill Bill, the RCP asked our fellows and members for their views on whether or not the law should be changed. Another, similar, private member's bill, in the name of Lord Falconer of Thoroton, is now before the House of Lords. Given this context, RCP Council believes that it should again provide fellows and members with the opportunity to review how RCP positions itself in this debate. While recognising that this is a contentious and difficult issue for many people, the decision was taken at RCP’s Council on 15 July 2014 to consider this issue. A special meeting of RCP Council took place on 30 July and decided to formally consult on this issue. In order to present a united view of the medical profession, this consultation document has been informed by the document used in 2013 by the Royal College of General Practitioners (RCGP) to consult with its members and fellows. We are grateful to the RCGP for allowing us to update and share their consultation document. Definitions While the term 'assisted dying' has no real meaning in law, we have chosen to interpret it as the supply by a doctor of a lethal dose of drugs to a patient who is terminally ill, who meets certain criteria and who requests those drugs in order that they might be used by the person concerned to end his or her life. -
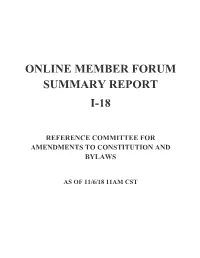
Online Member Forum Summary Report I-18
ONLINE MEMBER FORUM SUMMARY REPORT I-18 REFERENCE COMMITTEE FOR AMENDMENTS TO CONSTITUTION AND BYLAWS AS OF 11/6/18 11AM CST Fri, 09/14/2018 - 10:39 BOT 14 - Protection of Physician Freedom of Speech The Board of Trustees recommends that the following be adopted in lieu of Resolution 5-I-17 and the remainder of this report be filed: 1. That our American Medical Association strongly oppose litigation challenging the exercise of a physician’s First Amendment right to express opinions regarding medical issues. (New HOD Policy); and 2. That AMA Policy H-460.895, “Free Speech Applies to Scientific Knowledge,” be reaffirmed (Reaffirm HOD Policy). Tue, 10/30/2018 - 21:10 (new) Paul Wertsch RE: BOT 14 - Protection of Physician Freedom of Speech Excellent. Opinion Type: My post is my personal opinion Sat, 11/03/2018 - 15:07 (new) Robert Block RE: BOT 14 - Protection of Physician Freedom of Speech It is sad that we need to restate the the American principle of free speech, but with organizations trying to squelch that right, we must stand up Opinion Type: My post is my personal opinion Thu, 10/18/2018 - 10:54 Council on Ethical and Judicial Affairs Report 1 - Competence, Self-Assessment and Self- Awareness The Council on Ethical and Judicial Affairs recommends that the following be adopted and the remainder of this report be filed: The expectation that physicians will provide competent care is central to medicine. It undergirds professional autonomy and the privilege of self-regulation granted by society. To this end, medical schools, residency and fellowship programs, specialty boards, and other health care organizations regularly assess physicians’ technical knowledge and skills. -

A Journal of Culture, Theory, Politics, Available Online at 90/Euthanasia-Levinas It Is Not the Copy of Record
This is an accepted manuscript of an article published by Lawrence and Wishart in New Formations: A Journal of Culture, Theory, Politics, available online at http://www.lwbooks.co.uk/new-formations/89- 90/euthanasia-levinas It is not the copy of record. Copyright © 2017, Lawrence and Wishart. The Face of the Good Death: Euthanasia and Levinas Timothy Secret Abstract At various strata of the debate, the sense that arguments surrounding euthanasia are no longer making significant advances has provoked a variety of attempts to find alternative ethical approaches that might break with standard deadlocks. In this essay, we will trail one such move by giving a new account of what the ethical stance of Emmanuel Levinas might contribute towards the twin questions of the ethical justification and legalisation of euthanasia. Interpreting our fundamental relationship with the other in terms of the Biblical injunction ‘Thou shalt not kill’ and refusing to draw any distinction between murder and other forms of killing, Levinas is commonly taken to have offered an ethical stance that is strongly opposed to euthanasia. Without disagreeing with this interpretation, we will offer an account of a further twist on this perspective that renders euthanasia ambiguously the exemplary ethical failure and the supreme culmination of ethics, simultaneously separating this ethical question entirely from legality. Keywords Euthanasia, Levinas, Death, Sacrifice, Ethics SOMETHING IS AMISS The philosopher and medical ethicist Margaret P. Battin has published, adopting -

Collective Rights Vs Individual Rights? Examining the “Right to Die.”
William L. Saunders Collective Rights vs Individual Rights? Examining the “Right to Die.” Introduction Properly understood, there is no conflict between “collective rights” and “individual rights.” Part of the reason a conflict is assumed to exist is that a sound understanding of what constitutes a “right” has been lost. This is because often, and falsely, mere “wishes” are conflated with “rights.” Harvard Professor Mary Ann Glendon helpfully analyzed this in her book Rights Talk.1 True “collective rights” and true “individual rights” buttress each other and are better understood as aspects of “human rights.” Since human persons live in community, an aspect of human rights concerns communities (or societies or cultures) in which human beings live. However, those communities are not obligated to indulge every individual’s whim or purported “right.” Wishes and desires, even if deeply felt, do not constitute “rights.” Rather, rights properly understood are reflections of what is good for the human person. Society has an obligation to respect and promote the good of the human person, not an individual’s subjective desires. Recognizing and respecting legitimate individual human rights promotes the common good, and vice versa. Thus, a proper understanding of human rights reconciles alleged conflicts between “collective” and “individual” rights. However, false “rights” threaten the good of both the in- dividual and society. A purported new “right,” the “right to die,” illustrates these points. The first section of this paper will define what is meant by the “right to die.” The second section will show there is no foun- dation in the law for a “right to die.” The third section will explain why creating a new “right to die” is detrimental to society, particularly the medical profession, the elderly, the depressed, and the disabled. -

Rob Marris Mp's Assisted Dying Bill
ROB MARRIS MP’S ASSISTED DYING BILL Rob Marris’s ‘Assisted Dying (No. 2) Bill’ seeks to legalise assisted suicide (but not euthanasia) for Official Summary of the mentally competent adults (18+) with less than Assisted Dying (No. 2) Bill six months to live subject to ‘safeguards’ under 2015-16 a two doctors’ signature model similar to the Abortion Act 1967, and with High Court approval. A Bill to enable competent adults who are terminally ill to choose to be provided with Death takes place after 14 days by self-administering medically supervised assistance to end their ‘medicine’ in the presence of an ‘assisting health own life; and for connected purposes. 1 professional’. A person qualifying under the Bill must: have a ‘voluntary, clear, settled and informed Rob Marris MP was drawn first in the House of wish’ to end his or her life Commons ballot for Private Members’ Bills at the be aged 18 or over and resident in England beginning of the 2015-16 session of Parliament. and/or Wales for one year The Bill’s first reading took place on 24 June and have been diagnosed with a terminal illness second reading is expected on 11 September. (‘inevitably progressive’) and be ‘reasonably expected’ to die within six months Care Not Killing is opposed to this bill both in have made and signed a witnessed declaration principle and in detail on the grounds that it is countersigned by two doctors and approved by uncontrollable, unethical and unnecessary, and order of the High Court (Family Division). The we are urging MPs to reject it at second reading. -

Bibliography and Further Reading
Herring: Medical Law and Ethics, 7th edition Bibliography and Further Reading Aasi, G.-H. (2003) ‘Islamic legal and ethical views on organ transplantation and donation’ Zygon 38: 725. Abdallah, H., Shenfield, F., and Latarche, E. (1998) ‘Statutory information for the children born of oocyte donation in the UK’ Human Reproduction 13: 1106. Abdallah, S., Daar, S., and Khitamy, A. (2001) ‘Islamic Bioethics’ Canadian Medical Association Journal 9: 164. Abortion Law Reform Association (1997) A Report on NHS Abortion Services (ALRA). Abortion Rights (2004) Eroding Women’s Rights to Abortion (Abortion Rights). Abortion Rights (2007) Campaign for a Modern Abortion Law Launched as Poll Confirms Overwhelming Public Support (Abortion Rights). Academy of Medical Sciences (2011) Animals Containing Human Material (Academy of Medical Sciences). ACC (2004) Annual Report (ACC). Ackernman, J. (1998) ‘Assisted suicide, terminal illness, severe disability, and the double standard’ in M. Battin, R. Rhodes, and A. Silvers (eds) Physician Assisted Suicide (Routledge). Action for ME (2005) The Times Reports on Biological Research (Action for ME).Adenitire, J. (2016) ‘A conscience-based human right to be ‘doctor death’’ Public Law 613. Ad Hoc Advisory Group on the Operation of NHS Research Ethics Committees (2005) Report (DoH). Adams, T., Budden, M., Hoare, C. et al (2004) ‘Lessons from the central Hampshire electronic health record pilot project: issues of data protection and consent’ British Medical Journal 328: 871. Admiral, P. (1996) ‘Voluntary euthanasia’ in S. McLean (ed.) Death Dying and the Law (Dartmouth). Adshead, G. (2003) ‘Commentary on Szasz’ Journal of Medical Ethics 29: 230. Advisory Group on the Ethics of Xenotransplantation (1996) Report (DoH). -
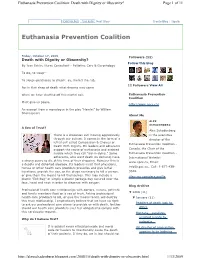
Euthanasia Prevention Coalition: Death with Dignity Or Obscenity? Page 1 of 11
Euthanasia Prevention Coalition: Death with Dignity or Obscenity? Page 1 of 11 SEARCH BLOG FLAG BLOG Next Blog» Create Blog | Sign In Euthanasia Prevention Coalition Friday, October 17, 2008 Followers (12) Death with Dignity or Obscenity? Follow this blog By Jean Echlin, Nurse Consultant - Palliative Care & Gerontology To die, to sleep-- To sleep--perchance to dream: ay, there’s the rub, 12 Followers View All For in that sleep of death what dreams may come When we have shuffled off this mortal coil, Euthanasia Prevention Coalition Must give us pause. http://www.epcc.ca/ An excerpt from a monologue in the play "Hamlet" by William Shakespeare About Me ALEX SCHADENBERG A Sea of Trust? Alex Schadenberg There is a draconian evil moving aggressively is the executive through our culture. It comes in the form of a director of the lethal cult called Compassion & Choices or Euthanasia Prevention Coalition - Death With Dignity. Its leaders and adherents support the cause of euthanasia and assisted Canada, the Chair of the suicide which they call "aid-in-dying." Some Euthanasia Prevention Coalition - adherents, who want death on demand, have International Website: a strong desire to die at the time of their choosing. However this is www.epcc.ca, Email: a deadly and distorted ideology. Its leaders insist that physicians, nurses or other health care providers prescribe and give lethal [email protected],. Call: 1-877-439- injections, provide the gas, or the drugs necessary to kill a person, 3348. or give them the means to kill themselves. This may include a View my complete profile plastic "Exit Bag" or simply a plastic garbage bag secured over the face, head and neck in order to dispense with oxygen. -

Euthanasia and Assisted Suicide:� Speaking from the Evidence Disclosure
5/26/15 Euthanasia and Assisted Suicide:! Speaking from the Evidence Disclosure: Margaret Cottle, MD I have no personal relationship Vancouver, BC, Canada with any commercial interest. “In the tender compassion of our God The dawn from on high shall break upon us, significance of photos… To shine on those who dwell in darkness and the shadow of death And to guide our feet into the way of peace.” Song of Zachariah Luke 1 Anne of Green Gables Disclaimer: “Smorgasbord” Disclaimer: “…and although I say far too much, Lots of text: yet if you only knew for reference later & language help how many things I want to say and don’t, you’d give me some credit for it.” Resources annotated and another list at end Anne to Marilla Note what is most compelling for you in Anne of Green Gables By L. M. Montgomery Think about your own stories & experiences 1 5/26/15 Thank you for inviting me my views are based on 26+ years of caring for I don’t mind dying...I just don’t want to be there when it happens. seriously ill patients and their loved ones Woody Allen Know their vulnerability and that complete autonomy is a myth— We’re all connected...and that’s a good thing! Acknowledge diverse opinions & backgrounds Everyone makes decisions based on a set of philosophical principles. Vast majority who favour these options do so on grounds of compassion Respectful, civil discourse is hard to find Complex issue--not simplistic While religious and philosophical ideas should —need nuanced, civil discourse be perfectly acceptable as part of public discussions in a democracy, Many good reasons to oppose these practices: this is seldom the case at present. -

John Findlay & Margaret Mccarthy
John Findlay & Margaret McCarthy ~ Lawyers May 1, 2016 By Fax To 613- 947- 3089 By E-mail: [email protected] To: The Standing Committee on Justice and Human Rights, House of Commons Ottawa ON K1A 0A6 Re: Bill C-14: Legalizing “medical” assistance in dying – The perfect cover for murder! Rather than being a “harm reduction model”, this Bill is a “harm facilitation model” for Canadians. As lawyers, we express some of our grave concerns with many parts of this imprecise and vague legislation: 1.Bill C-14 allows “a person” to assist in a suicide (even though it is so politely called “medically assisted dying”): In Section 241(5)(b) there is an exemption from the prosecution of any “person” aiding in the suicide of another person. This would cover suicides at home. This is shockingly remiss. Anyone with absolutely no expertise in health care can “aid” in an assisted death, not necessarily in the presence of a nurse or doctor, but “aiding” them in providing “MAID”. Did the Supreme Court not contemplate legislation where DOCTORS ONLY would administer assisted death? The Bill will allow many opportunities for abuse by lay people, from family members, unrelated care givers, or self-interested persons who wanted to take advantage of the patient. The provision for nurse practitioners or “any person” administering lethal injections, or “any person” being exempted from prosecution for administering lethal injections is dangerous, and should be removed. 2. Under Bill C- 14, there is no restriction in storing lethal medications at home, since “anyone’” can assist in a suicide under section 241(5)(b): Is this not like having a loaded gun available to all family members in the home? Suicide is often a rash act. -

Assisted Death STUDENT OFFICER
COMMITTEE: UTOPIA (Special Committee) ISSUE: Assisted Death STUDENT OFFICER: Elif KURTAY POSITION: Co-chair I- Introduction Assisted death has been a controversial debate topic for a very long time. However, a consensus hasn’t been reached for years. The end of life is a very crucial and critical topic to make a decision on. There are many conditions that affect whether a life can be taken away from a person with their request. The patients’ condition, the physician, whether the disease can be cured or not in the future, mental illness, religion, laws, etc. Euthanasia was a softer, maybe more rightful way to die than suicide. And recently assisted death (physician assisted suicide) become a more justifiable way to end one’s own life than euthanasia. However, some people have neither accepted nor agreed any of the aforementioned forms of suicide due to some understandable and important reasons. By both sides, for and against, having their reasons that cannot get disregarded, a decision seems impossible to be made. Besides having different point of views, it is always possible to reach a joint resolution regarding any topic and in order to succeed this goal, all sides, discussions and factors of should be studied and well understood. Therefore, hoping that this report will help with the comprehension of the issue, it is expected that assisted death will be granted great concern and attention to conclude this ever ending debate. II- Overview 2.1) Definition of Key Terms Suicide: is the act of causing one's own death commonly because of a mental illness like depression, bipolar disorder, schizophrenia, personality disorders, alcoholism, or drug abuse. -

R (Conway) V Secretary of State for Justice Judgment Lord Justice Sales
Neutral Citation Number: [2017] EWHC 2447 (Admin) Case No: CO/6421/2016 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION ADMINISTRATIVE COURT DIVISIONAL COURT Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL Date: 05/10/2017 Before: LORD JUSTICE SALES MRS JUSTICE WHIPPLE MR JUSTICE GARNHAM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Between: The Queen on the application of: Noel Douglas Conway Claimant - and - The Secretary of State for Justice Defendant (1) Humanists UK Intervenors (2) Care Not Killing (3) ND Yet UK (1) The Crown Prosecution Service Interested (2) Attorney General Parties Richard Gordon QC, Alexander Ruck Keene and Annabel Lee (instructed by Irwin Mitchell) for the Claimant James Strachan QC and Benjamin Tankel (instructed by Government Legal Department) for the Defendant Caoilfhionn Gallagher QC and Graeme L. Hall (instructed by Hodge Jones & Allen) for the 1st Intervenor David Lawson (instructed by Barlow Robbins) for the 2nd Intervenor Catherine Casserley (instructed by Fry Law) for the 3rd Intervenor Hearing dates: 17, 18, 19 and 20 July 2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Approved Judgment Lord Justice Sales: Introduction 1. This is the judgment of the court, to which all its members have contributed. 2. This case concerns the issue of provision of assistance to a person with a serious wasting disease who wishes to commit suicide, so as to be able to exercise control over the time of his death as the disease reaches its final stages. It follows a line of cases which have addressed that or similar issues, in particular R (Pretty) v Director of Public Prosecutions [2001] UKHL 61; [2002] 1 AC 800 (“Pretty”), R (Purdy) v Director of Public Prosecutions [2009] UKHL 54; [2010] 1 AC 345 (“Purdy”) and R (Nicklinson) v Ministry of Justice [2014] UKSC 38; [2015] AC 657 (“Nicklinson”).