La Ca' D'oro E Il Problema Della Conservazione Nella Venezia Del Secondo Ottocento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cicoselrusboi Granada Conf
Vincenzo Fontana (Università Ca’ Foscari Venezia) Cicognara, Selvatico, Ruskin e Boito: dall’Alhambra ai monasteri siriani. La tesi orientalista delle origini dell’architettura di Venezia è esposta da Leopoldo Cicognara in senso positivo ed elogiativo; Giannantonio Moschini (1773-1840) la accetta, e nel caso dell’abside del duomo di Murano scrive: “ contemporanea al tempio dee giudicarsi questa curiosa fabbrica di gusto saraceno, che nel suo genere è assai singolare e di gradevole effetto”1. Nelle Fabbriche più cospicue di Venezia…del 1815-1820 Leopoldo Cicognara (1767-Venezia), Antonio Diedo (1772-1847), Gian Antonio Selva (1753-1819) definiscono San Marco come la sintesi straordinaria fra oriente e occidente. <<[…] I marmi che dall’Oriente venivano trasportati, ed in ispecie da’ luoghi ov’erano immediate le relazioni de’ Veneziani, attestano come col commercio e col cambio d’ogni altra ricchezza succedesse anche un miscuglio ed una specie di comunanza nel gusto delle arti. Per capire questa sintesi bisogna conoscere Cordova, Siviglia e Granada, gli edifici saraceni della Sicilia e soprattutto Costantinopoli. […] Non trattasi quindi di decadenza o di corruzione nel gusto, ma vuolsi qui riconoscere uno stile a parte, determinato e unico in tutta l’Italia, che non ha origine da alcun’altra causa; e quantunque possa da noi opinarsi che lo stile, volgarmente chiamato Gotico, sia derivato esso pure dall’Araba architettura, giova in tal caso fare la seguente distinzione[…] Stile gotico: origine araba Æ Spagna Æ Normandia Æ Francia Æ Inghilterra Æ Germania Æ Milano[…]. In definitiva un Alessandrino era meno straniero a Venezia di un Lombardo.>> Così gli elementi stilistici del gotico veneziano del Palazzo Ducale <<[…] Ci rammentarono piuttosto i modi arabi e bisantini che i normanni e i germanici, giacché era molto meno straniero a Venezia un Saraceno od un Turco che un Francese, un Tedesco, e persino un Lombardo. -

Bibliografia Dell'arte Veneta
Arte Veneta 74/2017. Bibliografa dell’arte veneta (2016) a cura di Paolo Delorenzi e Meri Sclosa Arte Veneta 74 Bibliografa dell’arte veneta (2016) Appendice della rivista omonima, la Bibliografa dell’arte veneta, a cura di Paolo Delorenzi (monografe) e Meri Sclosa (periodici), costituisce un repertorio di pubblicazioni, edite nell’arco di un anno (2016), dedicate ad argomenti di interesse storico-artistico veneto al quale gli studiosi possono fare riferimento come strumento di aggiornamento e orientamento. Un modo per facilitare l’accesso a un ausilio fondamentale per gli studi. OPERE DI CARATTERE GENERALE L. Aldovini - D. Landau - S. Urbini, Le matrici lignee della collezione Malaspina e l’Atlante delle xilografe italiane del Rinascimento, “Studi di Memofonte”, 2016, 17, pp. 3-24, illustrato (www.memofonte.it). C. Balletti, Gli strumenti informatici al servizio della ricerca storica: il caso della cartografa veneziana del XV secolo, in Venezia e la nuova oikoumene. Cartografa del Quattrocento, atti del convegno (Venezia, 8-9 ottobre 2013), a cura di I. Baumgärtner - P. Falchetta, Roma, Viella Libreria Editrice, 2016, pp. 157-171, illustrato. A. Banchieri - A. Pra, Dal castello medioevale alla cultura della villa veneta, in Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia, atti del convegno (Altivole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padova-Luvigliano, 16-18 settembre 2013), a cura di M. Lenart - M. Wrana, Padova-Opole, Archiwum Państwowe, 2016, pp. 57-65, illustrato. A.B. Banta - L. Schneider, In the Shadow of La Serenissima, in The Enduring Legacy of Venetian Renaissance Art, a cura di A.B. Banta, London- New York, Routledge, 2016, pp. -
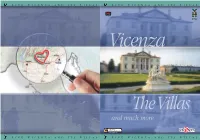
And Much More
L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS ENGLISH PROVINCIA DI VICENZA Vicenza TheVillas and much more L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS L IVE V ICENZA AND ITS V ILLAS Vicenza... The Villas and much more This small structured guide to routes aims to be an instrument of easy consultation for those wishing to discover the Vicentine villas, combining their visit with the other offers of the rich territory: from museums to wine roads, from castles to typical productions. Here below you will not merely fi nd a list of villas since those which most represent the defi nition of tourist interest have been carefully selected. Every route is subdivided into two sections: “the villas” and “much more”, in order to indicate that besides the villas there are other attractions for the visitor. The villas in the fi rst section are generally usable, from the point of view of opening and accessibility to the visitor. 1 itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino itinerary_1 Pedemontana Vicentina and High Vicentino Romano d'Ezzelino Pove del Grappa Mussolente 12 BASSANO The Villas DEL GRAPPA Santorso Lonedo MAROSTICA Zugliano 11 7 2 - VillaRosà Ghellini, Villaverla Description 6 10 Nove SCHIO BREGANZE CartiglianoBegun in 1664 designed by Pizzocaro, the works were in- 1 CALDOGNO - VILLA CALDOGNO Sarcedo 14 terrupted in 1679, date engraved in two places of the main 2 VILLAVERLA - VILLA GHELLINI THIENE 13 3 VILLAVERLA - VILLA VERLATO PUTIN 8 9 façade, and never restarted because of the death of the archi- 4 MOLINA DI MALO - VILLA PORTO THIENE 4 15 Longa tect. -

TROVATORE-IL.Pdf
5 La Fenice prima dell’Opera 2011 5 2011 Fondazione Stagione 2011 Teatro La Fenice di Venezia Lirica e Balletto Giuseppe Verdi ilTrovatore l trovatore I erdi V iuseppe iuseppe G FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA foto © Michele Crosera Visite a Teatro Eventi Gestione Bookshop e merchandising Teatro La Fenice Gestione marchio Teatro La Fenice® Caffetteria Pubblicità Sponsorizzazioni Fund raising Per informazioni: Fest srl, Fenice Servizi Teatrali San Marco 4387, 30124 Venezia Tel: +39 041 786672 - Fax: +39 041 786677 [email protected] - www.festfenice.com I.P. Il 4 dicembre 2008 il Comitato Portuale di Venezia ha deliberato il rilascio alla società APV Investimenti S.p.A., di proprietà dell’Autorità Portuale di Venezia, di una concessione demaniale (per una durata fino a trenta anni) dell’area denominata «Ex Locomotive». Nell’area, situata a Venezia, compresa tra la Marittima ed il Tronchetto, sorgeranno un garage multipiano, un centro direzionale, un’area commerciale e una struttura alberghiero-ricettiva. Vincitore del Concorso Internazionale di Progettazione è il raggruppamento con capogruppo il Prof. Arch. Mauro Galantino. APV Investimenti sta dando attuazione alla progettazione definitiva. Società dell’Autorità Portuale di Venezia - A Venice Port Authority Company Gestione e sviluppo dei progetti portuali Harbour projects management and developing www.apvinvest.it Società dell’Autorità Portuale di Venezia A Venice Port Authority Company Santa Marta, fabb. 16 – 30123 Venezia Tel. +39 0415334159, Fax +39 0415334180 FONDAZIONE AMICI -

Così Fan Tutte
1 La Fenice prima dell’Opera 2012 1 2012 Fondazione Stagione 2012 Teatro La Fenice di Venezia Lirica e Balletto Wolfgang Amadeus Mozart CosìFan osì fan tutte osì fan C Tutte ozart M madeus A olfgang olfgang W FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA TEATRO LA FENICE - pagina ufficiale seguici su facebook e twitter follow us on facebook and twitter Incontro con l’opera FONDAZIONE lunedì 16 gennaio 2012 ore 18.00 AMICI DELLA FENICE SANDRO CAPPELLETTO, MARIO MESSINIS, DINO VILLATICO STAGIONE 2012 Lou Salomé sabato 4 febbraio 2012 ore 18.00 MICHELE DALL’ONGARO L’inganno felice mercoledì 8 febbraio 2012 ore 18.00 LUCA MOSCA Così fan tutte martedì 6 marzo 2012 ore 18.00 LUCA DE FUSCO, GIANNI GARRERA L’opera da tre soldi martedì 17 aprile 2012 ore 18.00 LORENZO ARRUGA La sonnambula lunedì 23 aprile 2012 ore 18.00 PIER LUIGI PIZZI, PHILIP WALSH Powder Her Face giovedì 10 maggio 2012 ore 18.00 RICCARDO RISALITI La bohème lunedì 18 giugno 2012 ore 18.00 GUIDO ZACCAGNINI Carmen giovedì 5 luglio 2012 ore 18.00 MICHELE SUOZZO L’elisir d’amore giovedì 13 settembre 2012 ore 18.00 MASSIMO CONTIERO Clavicembalo francese a due manuali copia dello Rigoletto strumento di Goermans-Taskin, costruito attorno sabato 6 ottobre 2012 ore 18.00 alla metà del XVIII secolo (originale presso la Russell PHILIP GOSSETT Collection di Edimburgo). L’occasione fa il ladro Opera del M° cembalaro Luca Vismara di Seregno (MI); ultimato nel gennaio 1998. lunedì 5 novembre 2012 ore 18.00 Le decorazioni, la laccatura a tampone e le SERGIO COFFERATI chinoiseries – che sono espressione di gusto Otello tipicamente settecentesco per l’esotismo mercoledì 14 novembre 2012 ore 18.00 orientaleggiante, in auge soprattutto in ambito GIORGIO PESTELLI francese – sono state eseguite dal laboratorio dei fratelli Guido e Dario Tonoli di Meda (MI). -

The Barber of Seville Opera Without Words The
The Pearl Fishers The Barber of Seville Opera Without Words It gives me great pleasure to presents welcome you to Dubai Opera. Iconic in design and exceptional in its creative outlook, Dubai Opera is a truly unique venue, Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Trieste offering the ultimate flexibility of a proscenium arch theatre, an acoustic concert hall and a 2000m2 flat floor event space. Highlighting the spirit of creativity and imagination, Dubai The Pearl Fishers Opera is also a tribute to the rich heritage, values and traditions of the UAE. (Les pêcheurs de perles) We have created a world-class, multi-format venue that will showcase outstanding productions and programmes that will The Barber of Seville enrich the quality of life of both residents and visitors to the region. We have three guiding (Il Barbiere di Siviglia) principles: quality, variety and community, and will endeavor to bring ground-breaking events and the world’s most sought-after productions, reflecting the cosmopolitan and Opera Without Words progressive outlook of Dubai. As the Opera District develops within Downtown Dubai, visitors can expect to 1 - 5 September 2016 see not only the iconic Dubai Opera as the centerpiece but also, in time, new galleries, performance spaces and specially These performances by the Teatro Verdi Trieste are dedicated in honour of the commissioned sculptures and art victims and families of the earthquake that struck Italy on 24 August 2016. works for the public realm. I wish you a wonderful evening. Jasper Hope Dubai Opera – Chief Executive Synopsis The Pearl The Pearl Fishers (Les pêcheurs de perles) is an opera in three acts by French composer Georges Bizet, to a libretto by Eugène Cormon and Michel Carré. -

I Concorsi Di Architettura All'accademia Di Belle Arti Di Venezia
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA DELLE ARTI E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI I concorsi di architettura all'Accademia di Belle Arti di Venezia Relatrice: prof.ssa Elisabetta Molteni Correlatrice: dott.ssa Piera Evelina Zanon Laureanda: Enrica Annamaria Ceccon Matricola: 828521 Sessione di laurea estiva ANNO ACCADEMICO 2011 – 2012 Indice Introduzione ............................................................................................................. p. 2 1. Dalla corporazione dei Pittori all’Accademia di Belle Arti di Venezia .............. p. 5 1.1 L’architettura in Accademia ......................................................................... p. 16 1.2 La sede al Fonteghetto delle Farine di San Marco ........................................ p. 22 2. I primi concorsi 2.1 I concorsi di disegno del nudo ...................................................................... p. 26 2.2 I concorsi di pittura e scultura ....................................................................... p. 30 3. I concorsi di architettura ...................................................................................... p. 33 4. L’architettura nelle altre Accademie ................................................................... p. 40 Conclusione ............................................................................................................. p. 66 Schede dei disegni .................................................................................................. -

Travel in Italy
Travel in Italy This was prepared in 1994 per studenti, and only partially updated. The cultural richness of Europe, and particularly Italy is so great and so concentrated, that most tourists return to Australia overwhelmed and with only a very general impression, perhaps remembering specific details only because of personal incidents associated with them. The more preparation by reading that the traveller is able to undertake beforehand, the more potentially perceptive will be their experience of travel. Try to identify your specific interests, before leaving Melbourne. So much of our cultural life is derived from Italy: painting, sculpture, architecture, music (particularly opera), soccer, food, family, social behaviour, contemporary design and crafts. Here, we generally can only concentrate on architecture and art. Food Do not be surprised if good inexpensive meals are more difficult to find than in Melbourne. This is one of the benefits of living in a cosmopolitan city without tourists, as we do. One of the disadvantages of living in the World's Most Livable City, is that everywhere else is less livable. It is always cheaper to eat or drink standing up, inside. Sitting down, especially outdoors, costs much more. Hours Most Italian businesses close between 1 and 3pm, or longer. But they generally open until at least 7pm. Banks do not re-open. Once you leave Melbourne, the 24 hour clock operates, so 7pm is 1900 hours, for instance. State Museums now appear to be open 9-7 every day except on two Mondays in each month, when all are closed. But many museums are not state owned and have other opening hours.