Centro Militare Di Studi Strategici Ricerca 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
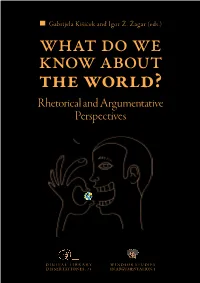
Rhetorical and Argumentative Perspectives, Digi
Gabrijela Kišiček and Igor Ž. Žagar (eds.) what do we know about the world? Rhetorical and Argumentative Perspectives digital library windsor studies dissertationes, 25 in argumentation, 1 WHAT DO WE KNOW ABOUT THE WORLD? Gabrijela Kišiček and Igor Ž. Žagar (eds.) what do we know about the world? Rhetorical and Argumentative Perspectives DIGITAL LIBRARY / DISSERTATIONES / 25 WINDSOR STUDIES IN ARGUMENTATION / 1 Gabrijela Kišiček and Igor Ž. Žagar (eds.), What Do We Know about the World? Rhetorical and argumentative perspectives Znanstvena monografija/Scientific Monograph This book is a joint publication of Educational Research Institute's Digital Library and Windsor Studies in Argumentation. Zbirka/Series: Digitalna knjižnica/Digital Library Uredniški odbor/Editorial Board: Igor Ž. Žagar (Educational Research Institute & University of Primorska), Jonatan Vinkler (University of Primorska), Janja Žmavc (Educational Research Institute & University of Primorska), Alenka Gril (Educational Research Institute) Podzbirka/Subseries: Dissertationes (znanstvene monografije/Scientific Monographs), 25 Urednik podzbirke in izdaje/editor in chief: Igor Ž. Žagar Zbirka/Series: Windsor Studies in Argumentation, 1 Uredniški odbor/Editorial Board: Leo Groarke (editor in chief; University of Windsor), Christopher Tindale (editor in chief; University of Windsor), Mark Battersby (Capilano University), Camille Cameron (University of Windsor), Emmanuelle Danblon (Université libre de Bruxelles), Ian Dove (University of Nevada Las Vegas), Bart Garssen (University -

Download/Print the Study in PDF Format
GENERAL ELECTIONS IN CROATIA 4th December 2011 European Elections monitor The Social Democratic Opposition running favourite in the general elections on 4th December in Croatia. From Corinne Deloy Translated by Helen Levy On 31st October last the President of the Republic of Croatia, Ivo Josipovic dissolved the Hrvatski Sabor, the only chamber of parliament, and confirmed that general elections ANALYSIS would take place on 4th December next. All polls forecast that the Democratic Union 1 month before (HDZ), led by Prime Minister Jadranka Kosor, the party in office since 1991 (except for a the poll gap in 2002-2003) will lose. The Croatian electoral law and the constituencies have been redesigned. Opposition lea- der Zoran Milanovic (Social Democratic Party, SDP) criticised this change to the electoral map that took place less than a year before the general elections, qualifying it as illegal. Branko Bacic, the HDZ Secretary General said that this showed that the opposition forces were afraid of losing the election. The Croatian Political System Jadranka Kosor has 66 seats; – the Social Democratic Party (SDP), the main op- The Croatian Parliament has been unicameral position party created in 1990 and led since May since 2001 when the Chamber of Comitats was 2007 by Zoran Milanovic has 56 MPs; abolished. Its only chamber, the Hrvatski Sabor, – the Farmers’ Party (HSS), led by Josip Frisic and comprises around 150 MPs. According to the member of the outgoing government coalition has Constitution their number may vary depending on 8 seats; the legislature; there can be no less than 100 nor – the People’s-Liberal Democratic Party (HNS), more than 160. -

Transitional Justice in Post-Yugoslav Countries Report for 2010 - 2011
Transitional Justice in Post-Yugoslav Countries Report for 2010 - 2011 1 Fond za humanitarno pravo 2 Fond za humanitarno pravo I. Summary War Crimes Trials Trials for war crimes committed in the armed conflicts in the period from January 1991 until June 1999 are conducted in all successor countries of the former Yugoslavia except in Macedonia. What is typical of all of these trials is that they last a long time and victims are not informed about the progress made in the proceedings. The uncoordinated judicial practice in the application of the laws for the prosecution of war crimes in Bosnia and Herzegovina seriously jeopardizes the equality of the suspects, defendants and convicts before the law. The Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia is applied in war crimes trials at the entity level and in Brčko District, while the BiH Court applies the Criminal Code of BiH. The Supreme Court of BiH has not yet been instituted because of the resistance of the Republic of Srpska, which invokes the Dayton Agreement, and the appeals procedure is thus under the jurisdiction of the BiH Court, which also handles cases in the first instance. The transfer of jurisdiction for war crimes trials to the lower courts is slow. In the period from 2006 until late 2011, a total of 83 cases were transferred to courts that have territorial jurisdiction. A total of 52 of these cases were transferred to courts in the Federation of BiH, 27 to courts in the Republic of Srpska, and one case to the Basic Court of the Brcko District of BiH. -

Political Parties' Positions on the EU
A University of Sussex DPhil thesis Available online via Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/ This thesis is protected by copyright which belongs to the author. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Please visit Sussex Research Online for more information and further details The Attitudes of Political Parties in Serbia and Croatia towards the European Union in Comparative Perspective Marko Stojić University of Sussex Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy December, 2013 iii Contents List of Tables and Figures vi List of Abbreviations vii Acknowledgements viii Summary ix Chapter 1: Introduction 1 1.1 Setting the scene 1 1.2 Serbian and Croatian relationships with the EU/EC 4 1.2.1 Serbian and Croatian relationships with the European Community until the 1990s 4 1.2.2 A decade of lost opportunities (1990-2000) 5 1.2.3 A difficult role for latecomers (2000-2012) 8 1.3 Serbian and Croatian party politics since 2000 11 1.3.1 Serbian party politics since 2000 – the agony of political and state fragmentation 11 1.3.2 Croatian party politics since 2000 – a gradual post-conflict normalisation and stabilisation 14 1.4 General literature review 16 1.4.1 Literature on -

GENERAL ELECTIONS in CROATIA 4Th December 2011
GENERAL ELECTIONS IN CROATIA 4th December 2011 European Elections monitor The Social Democratic Opposition running favourite in the general elections on 4th December in Croatia. From Corinne Deloy Translated by Helen Levy On 31st October last the President of the Republic of Croatia, Ivo Josipovic dissolved the Hrvatski Sabor, the only chamber of parliament, and confirmed that general elections ANALYSIS would take place on 4th December next. All polls forecast that the Democratic Union 1 month before (HDZ), led by Prime Minister Jadranka Kosor, the party in office since 1991 (except for a the poll gap in 2002-2003) will lose. The Croatian electoral law and the constituencies have been redesigned. Opposition lea- der Zoran Milanovic (Social Democratic Party, SDP) criticised this change to the electoral map that took place less than a year before the general elections, qualifying it as illegal. Branko Bacic, the HDZ Secretary General said that this showed that the opposition forces were afraid of losing the election. The Croatian Political System Jadranka Kosor has 66 seats; – the Social Democratic Party (SDP), the main op- The Croatian Parliament has been unicameral position party created in 1990 and led since May since 2001 when the Chamber of Comitats was 2007 by Zoran Milanovic has 56 MPs; abolished. Its only chamber, the Hrvatski Sabor, – the Farmers’ Party (HSS), led by Josip Frisic and comprises around 150 MPs. According to the member of the outgoing government coalition has Constitution their number may vary depending on 8 seats; the legislature; there can be no less than 100 nor – the People’s-Liberal Democratic Party (HNS), more than 160. -

Dealing with the Past in the Western Balkans Initiatives for Peacebuilding and Transitional Justice in Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia
Dealing with the Past in the Western Balkans Initiatives for Peacebuilding and Transitional Justice in Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia Martina Fischer and Ljubinka Petrović-Ziemer (eds.) Berghof Report No. 18, 2013 Imprint This publication presents results of the research project “Dealing with the Past and Peacebuilding in the Western Balkans. Studying the interplay of international and local initiatives for Transitional Justice and Reconciliation in Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia”. The project was funded by the German Foundation Peace Research / Deutsche Stiftung Friedensforschung in the period March 2010–April 2012. Translations : Hana Dvornik (chapters 7.1 and 7.3) and Marija Stojanović (chapter 7.2.) Language editing: Hillary Crowe Desktop publishing: Astrid Fischer © 2013 Berghof Foundation Operations GmbH. All rights reserved. To cite this publication: Martina Fischer and Ljubinka Petrović-Ziemer (eds.) 2013. Dealing with the Past in the Western Balkans. Initiatives for Peacebuilding and Transitional Justice in Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia. Berghof Report No. 18. Berlin: Berghof Foundation. ISBN: 978-3-941514-14-0 Order at: Berghof Foundation Altensteinstraße 48a 14195 Berlin, Germany Via Internet: www.berghof-foundation.org [email protected] Content Preface and Acknowledgement Abstract 1 Dealing with the Legacies of the Past in the Balkans: A Local, Regional and International Challenge (Introduction by Martina Fischer) 1 2 Political Context and Relevant Actors (by Martina Fischer) 5 2.1 Political