Caratteristiche Geomorfologiche Dell'area
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
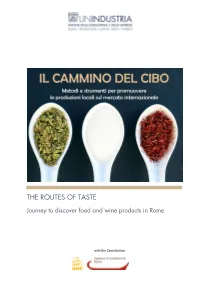
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization. -

Si Comunicano Le Variazioni Intervenute Nell'organizzazione Dell'istituto a Seguito Di Scorporo O Di Collocazione Sul Territorio Di Unità Operative
Organo: INAIL Documento: Circolare n. 25 del 22 marzo 1991 Oggetto: Variazione nell'organizzazione periferica dell'Istituto. - Unità istituite in Roma e provincia. - Sede di Barletta (già Bari 3) - Sede di Cagliari 2. - Sede di Cirie (già Torino 4) - Sede di Pinerolo - Sede di Massa (già Massa Carrara 2) Si comunicano le variazioni intervenute nell'organizzazione dell'Istituto a seguito di scorporo o di collocazione sul territorio di Unità operative. SEDE DI ROMA 1 Piazza delle Cinque Giornate, 3 - 00192 ROMA TEL.: 06/ 675901 FAX : 06/3225992 COD. AMM. : 24400 U.S.L. di competenza: 16-17-18-19-20 Comune di Roma - Linea prestaz. Via Salaria, 456 - 00199 - ROMA TEL.: 06/8380037 FAX: 06/8380084 COD. AMM.: 24400 - Linea rendite Via Palestro, 45 - 00185 - ROMA TEL.:06/4453686/7/8/9 FAX: 06/4940466 COD. AMM.: 24400 SEDE DI ROMA 2 Piazza delle Cinque Giornate, 3 - 00192 - ROMA TEL.: 06/675901 FAX :06/3225992 COD.AMM.:24470 USL: 5-7-24 Comuni: Roma, Mentana e Monterotondo - Linea prestaz. Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 - ROMA TEL.: 06/4514820/830/851/678 FAX : 06/4514737 COD. AMM.: 24470 SEDE DI ROMA 3 Via dell'Acqua Bullicante, 312 - 00177 - ROMA TEL.: 06/2715330/1/2 FAX: 06/274308 COD.AMM.: 24440 USL: 6-9 Comune di Roma SEDE DI ROMA 4 Via Michele De Marco,18/20 ang. Via Torre Spaccata - 00169 - ROMA (ha incorporato lo Sportello Prestazioni di Via Savona) TEL.:06/2678146/149/175 FAX:06/2675944 COD. AMM.: 24441 USL: 8-10-29-32 Comuni: Roma e Ciampino Lo Sportello Prestazioni di Via Savona, 12 in Roma è stato soppresso. -

Elenco Codici Uffici Territoriali Dell'agenzia Delle Entrate
ROMA Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: • Direzione Provinciale I di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 1 - TRASTEVERE , ROMA 2 - AURELIO , ROMA 3 - SETTEBAGNI • Direzione Provinciale II di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 5 - TUSCOLANO , ROMA 6 - EUR TORRINO , ROMA 7 - ACILIA , POMEZIA • Direzione Provinciale III di ROMA articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di ROMA 4 - COLLATINO , ALBANO LAZIALE , TIVOLI , FRASCATI , PALESTRINA , VELLETRI Direzione Provinciale I di ROMA Sede Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763637 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] TK2 Municipi di Roma : I, III, XII, XIII, XIV, XV. Comuni : Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano. Comune: ROMA Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763636 E-mail: [email protected] TK3 Indirizzo: VIA IPPOLITO NIEVO 36 CAP: 00153 Telefono: 06/583191 Fax: 06/50763635 E-mail: [email protected] TK3 Mappa della Direzione Provinciale I di -
Guida Alla Natura Di Canale Monterano E Della Sua Riserva Naturale
Guida alla natura di Canale Monterano e della sua Riserva Naturale gli ambienti, gli itinerari, i servizi Progetto Life+ Natura Monti della Tolfa Guida alla natura di Canale Monterano e della sua Riserva Naturale gli ambienti, gli itinerari, i servizi Ringraziamenti Si ringraziano tutti gli Autori delle foto, che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro materiale; Flavia Marani per il paragrafo Archeologia e storia; Chiara Bernetti e Stefano Picchi per la rilettura dei testi e gli utili consigli. INDICE 6 Prefazione Fabio Refrigeri Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente della Regione Lazio 7 Premessa Angelo Stefani Presidente della Riserva Naturale Regionale Monterano Sindaco di Canale Monterano 8 Introduzione 8 L’ambiente della Riserva Naturale Monterano 10 Archeologia e storia a cura di Flavia Marani, archeologa 13 La rete Natura 2000 14 La ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” 16 I SIC !"#$%&'("
Depositi E Mineralizzazioni a Manganese Nel Lazio " 22 S
Il Cercapietre, 2018, 1. www.gminromano.it GRUPPO MINERALOGICO ROMANO Associazione culturale senza fini di lucro riconosciuta ai sensi del D.P.R. n.361/2000 www.gminromano.it RIUNISCE cultori ed appassionati di mineralogia e paleontologia PUBBLICA on-line la Rivista “IL CERCAPIETRE” COLLABORA con il MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra dell’Università Sapienza di Roma e con il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre PROMUOVE studi, ricerche, scambi ORGANIZZA conferenze, mostre, attività divulgative e, dal 1979, l’annuale Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie OFFRE CONSULENZE per il riconoscimento dei minerali ASSEGNA il premio annuale ˝Lapis Latium ̏ a favore di studenti autori di lavori originali in ambito mineralogico e petrografico della regione Lazio SEDE: c/o MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra Dipartimento di Scienze della Terra - ˝Sapienza ̏ Università di Roma Piazzale A. Moro, 5 – 00185 ROMA - I Apertura: il sabato non festivo dalle ore 15,30 alle ore 19,00. Per informazioni: Tel. 3337964784 - 3338201317 - 3381540941 E-mail: [email protected] 1 Il Cercapietre, 2018, 2. www.gminromano.it Rivista on-line del Gruppo Mineralogico Romano: www.gminromano.it Anno 2018 © - Gli autori degli articoli e delle fotografie sono titolari di tutti i diritti Coordinatore: Roberto Pucci Collaboratori: Vincenzo Nasti Roberto Begini Marco Corsaletti Edgardo Signoretti Revisori scientifici: Fabio Bellatreccia Italo Campostrini Giancarlo Della Ventura Francesco Demartin Francesco Grossi Michele Lustrino Adriana Maras Annibale Mottana 40ª Mostra di minerali, fossili e conchiglie pag. 3 (7 – 8 dicembre 2018) V. Nasti I minerali blu della serie sodalite - lazurite del Lazio " 7 G. -

INFORMASALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Non Comunitari
Progetto cofinanziato da ISTITUTO NAZIONALE UNIONE SALUTE, MIGRAZIONI MINISTERO MINISTERO EUROPEA E POVERTÀ DELLA SALUTE DELL’INTERNO Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I Servizi Sanitari di ROMA e Provincia INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI ROMA E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI ROMA E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI ROMA E PROVINCIA L’assistenza sanitaria territoriale nell’ambito della Provincia di Roma si ar- ticola in otto Aziende Sanitarie Locali (ASL ROMA A, B, C, D, E, F, G, H) a loro volta suddivise in Distretti Sanitari nelle cui articolazioni territoriali viene garantita l’assistenza. Inoltre, opera a Roma l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) con sede in via di San Gallicano 25/a. L'ambulatorio polispecialistico dell'Istituto è situato in via delle Fratte di Trastevere 52 (Tel. 06.58543731/30). 2 • TERRITORI DI RIFERIMENTO E UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) ASL ROMA A Via Ariosto 3/9 · Call Center URP - Pronto Sanità 06.7307215 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 13.00-17.00 DISTRETTO 1 Municipio I Via Luzzati 8 DISTRETTO 2 Municipio II Piazza Gentile da Fabriano 7 DISTRETTO 3 Municipio III Via dei Frentani 6 TERRITORI DI RIFERIMENTO E UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DISTRETTO 4 Municipio IV Via Monte Rocchetta 14 ASL ROMA B Via Filippo Meda 35 · URP: 06.41433014 Da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 DISTRETTO 1 Municipio V Largo Domenico de Dominicis 6/8 DISTRETTO 2 3 Municipio VII Via Bresadola 56 DISTRETTO 3 Municipio VIII Via Tenuta di Torrenova 138 DISTRETTO 4 Municipio X Via Cartagine 85 ASL ROMA C Via Primo Carnera 1 URP: 06.51004555/52/54/41 DISTRETTO 6 Municipio VI Via N. -

IMMISSIONI LEPRI MESE FEBBRAIO 2020 SUL TERRITORIO LIBERO DELL’ATC Roma 1
IMMISSIONI LEPRI MESE FEBBRAIO 2020 SUL TERRITORIO LIBERO DELL’ATC Roma 1 Comune N° siti Località N° Lepri Casale Vaccareccia M.Rotondo Allumiere 4 Casale Spizzicatore 33 La Farnesiana Anguillara 3 Ponton dell'Elce( spanora/ghezzi), Cave Pantano, Sorti lunghi 12 Bracciano Prato Farina 2 14 Castel Giuliano Santa Lucia (Valle Luterana) Campagnano di Roma 1 Lo Giudice 10 Canale Monterano 2 Piamozzella Seccareccio, Santioro (Via fosso Bastianello) 14 Civitella san paolo 2 Lisano,Cerreta, 14 Capena 1 Le macchie/San Martino 14 Cannettaccio via del birbo loc. Brizzi, Tombe Etrusche Cerveteri 6 Monte Abatone Termini 36 Porrazeta Due casette Castelnuovo di Porto 2 Monte Palombo, Monte Rosello 10 Mandrione Civitavecchia 3 Sferracavallo 20 M. Cucchetto Fiano Romano 2 Piane del Tevere, La Faiola Monte Severino 20 Filacciano 1 Piane del Tevere: Casotto 10 Fiumicino 2 Aranova:Valle coppa,testa di lepre 14 Monte la Grandine Magliano Romano 2 20 Monte Stangone Manziana 2 Via Trafogliette , Matrice archi di Boccalupo 14 Mazzano Romano 1 M. Cinghiale 18 Morlupo 1 Fontenucola 12 Nazzano 3 Valle Tortora, Salamaia, Cava 10 Ponzano 2 Monte Uccio, Mandriacce 10 Riano 2 Quarto bestiame, Barchetto 14 Rignano Flaminio 3 M. Arcanello, Vallelunga,Valle Castagno 18 San Nicola (Valle del Pero) Ponte Galeria/monti dell’ortaccio, valle della sargia Labaro/M. Porcino ex Golf Roma 8 86 La Storta/ La castelluccia Via Giuseppe Clemente,San Nicola Cecanibbio, Paparozzi Sacrofano 1 Stazione Procoio (Loc. Funari) 14 Sant’Oreste 3 Monti severini, Oncia, Vallicomo 20 Santa Marinella 2 Pontoncino /est, Elletina bocca di lepre 18 Mazzalupi/Mignone Orsara/Monte Lungo Tolfa 6 Palmetta, 37 Marano(Pesoni) Femmina Morta, Para del lupo Torrita Tiberina 1 Le piane acquedotto 10 Oasi Sant’Oreste 2 Molaccia, Pinetti 19 totale 541 . -

Il Braccianese Nell' Antichità Dalla Preistoria Al Medioevo
4 IL BRACCIANESE NELL' ANTICHITÀ DALLA PREISTORIA AL MEDIOEVO (1971) 1 IL BRACCIANESE NELL' ANTICHITÀ DALLA PREISTORIA AL MEDIOEVO «Braccianese» è concetto, e nome, senza dubbio moderno: con esso intendiamo oggi comunemente la zona che ha al centro Bracciano e il suo tenitorio, ad est il lago omonimo coi comuni di Trevignano e A!1guiJlara, ad ovest i comuni di Manziana e Canale Monterano., Siamo portati quindi ad escludere, a torto, il prossimo territorio di Oriolo Romano per via della differente provincia di appartenenza e quelli di Tolfa e Allumiere che gravitano su Civi tavecchia, Anche la circoscrizione diocesana esclude dal Vicariato di Bracciano sia Oriolo sia Tolfa e Allumiere; include però Rota pur appartenendo essa territorialmente al comune di Tolfa, Ma trasferendoci dalla realtà odierna all'antichità, l'espres sione «Braccianese», territorialmente parlando, non è più valida. E non solo per essere, come abbiamo accennato, toponimo relativa mente recente, ma anche e soprattutto per l'importanza, per il condizionamento, per l'autonomia dei centri del comprensorio, diversi, diversissimi talora, da epoca ad epoca. Per limitarci a tempi a noi più vicini, basti pensare ai centri deperiti, come in primo luogo Monterano in territorio canalese di strutto dai Francesi l'ultimo anno del Settecento, o ai centri sorti ex-novo tra il Cinquecento e il Seicento come Manziana e Qua droni, Canale Monterano e Montevirginio. Assai più diverso è il quadro delle sedi umane e delle strade. del Braccianese in età romana, quando il capoluogo era Forum 2 134 IL BRACCIANESE NELL'ANTICHLTÀ Clodii (dov'è ora San Liberato) e quando dei centri attuali del Braccianese non ne esisteva alcuno o quasi. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2018
Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0002492.17-02-2020-R Ufficio del territorio di ROMA Data: 11/02/2020 Ora: 14.35.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2018 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ANIENE MONTAGNA NORD OCCIDENTALE DEI LEPINI Comuni di: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO Comuni di: CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, ROMANO, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, MANDELA, CANTERANO, MONTELANICO, SEGNI CAPRANICA PRENESTINA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, GERANO, JENNE, LICENZA, MARANO EQUO, MONTEFLAVIO, PERCILE, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 7000,00 7000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 7000,00 7000,00 BOSCO MISTO 6000,00 6000,00 CANNETO 6000,00 CASTAGNETO 17000,00 18000,00 FRUTTETO 27500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 2000,00 ORTO 31200,00 29000,00 ORTO IRRIGUO 34200,00 31200,00 PASCOLO 6000,00 5000,00 PASCOLO ARBORATO 6000,00 5000,00 Pagina: 1 di 15 Ufficio del territorio di ROMA Data: 11/02/2020 Ora: 14.35.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2018 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA -

L'acquedotto Consorziale Del Simbrivio
Luigi CESA L'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DEL SIMBRIVIO Luigi CESA è nato ad Arcinazzo Ro- mano (RM) nel 1916 e deceduto a Roma nel 2004. Ha pubblicato: Le chiese di Arcinazzo Romano e di Affile, Ediz. Eurotip, Roma, 1984; Altipiani di Arcinazzo. La villa im- periale, Ediz. Eurotip, Roma, 1987. Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per l'in- formazione e l'editoria, 1988; Racconti e rimembranze di guerra, 1994; I casati di Arcinazzo Romano dal XVI al XX secolo, Ediz. Global Me- dia, 1998; Scuola e comunità civile ad Arci- nazzo Romano - L'opera della Chiesa e delle Sorelle della Misericordia di Vero- na (1940-2001), 2002. In copertina: Trasportatori dei tubi di m/m 500 per il sifone di Vallepietra. Luigi CESA L'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DEL SIMBRIVIO INDICE PREFAZIONE INTRODUZIONE CAPITOLO I Vallepietra e le sue sorgenti CAPITOLO II Condizioni idriche dei comuni consorziati prima dell’acquedotto del Simbrivio CAPITOLO III Concessioni del Ministero dei LL. PP. e costituzione del Consorzio del Simbrivio CAPITOLO IV Statuto del Consorzio del Simbrivio costituito con decreto prefettizio n° 40783 dell’8 agosto 1923 CAPITOLO V Decreto del Ministero dei LL. PP. del 19 gennaio 1922 CAPITOLO VI L’utilizzazione delle sorgenti delle acque dell’Aniene e del suo affluente “Simbrivio” secondo un decreto di concessione del 1918 CAPITOLO VII L’acquedotto del “Simbrivio” e la relizzazione delle relative opere CAPITOLO VIII Gli artefici dell’acquedotto CAPITOLO IX Inaugurazione dell’acquedotto a Velletri CAPITOLO X Le autorità e gli enti realizzatori dell’opera CAPITOLO XI Richieste di acqua e nuove adesioni al Consorzio CAPITOLO XII Decreto di concessione del Ministero dei LL. -

Is Radon Emission in Caves Causing Deletions in Satellite DNA Sequences of Cave-Dwelling Crickets?
RESEARCH ARTICLE Is Radon Emission in Caves Causing Deletions in Satellite DNA Sequences of Cave-Dwelling Crickets? Giuliana Allegrucci*, Valerio Sbordoni, Donatella Cesaroni Department of Biology, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy * [email protected] Abstract The most stable isotope of radon, 222Rn, represents the major source of natural radioactivity in confined environments such as mines, caves and houses. In this study, we explored the possible radon-related effects on the genome of Dolichopoda cave crickets (Orthoptera, Rhaphidophoridae) sampled in caves with different concentrations of radon. We analyzed specimens from ten populations belonging to two genetically closely related species, D. geniculata and D. laetitiae, and explored the possible association between the radioactivity OPEN ACCESS dose and the level of genetic polymorphism in a specific family of satellite DNA (pDo500 Citation: Allegrucci G, Sbordoni V, Cesaroni D satDNA). Radon concentration in the analyzed caves ranged from 221 to 26000 Bq/m3. (2015) Is Radon Emission in Caves Causing Deletions in Satellite DNA Sequences of Cave- Specimens coming from caves with the highest radon concentration showed also the high- Dwelling Crickets?. PLoS ONE 10(3): e0122456. est variability estimates in both species, and the increased sequence heterogeneity at doi:10.1371/journal.pone.0122456 pDo500 satDNA level can be explained as an effect of the mutation pressure induced by Academic Editor: Joshua B. Benoit, University of radon in cave. We discovered a specific category of nuclear DNA, the highly repetitive satel- Cincinnati, UNITED STATES lite DNA, where the effects of the exposure at high levels of radon-related ionizing radiation Received: September 26, 2014 are detectable, suggesting that the satDNA sequences might be a valuable tool to disclose Accepted: February 13, 2015 harmful effects also in other organisms exposed to high levels of radon concentration. -
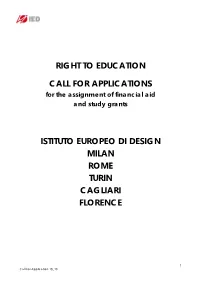
Right to Education Call for Applications Istituto
RIGHT TO EDUCATION CALL FOR APPLICATIONS for the assignment of financial aid and study grants ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN MILAN ROME TURIN CAGLIARI FLORENCE 1 Call For Application 18_19 Contents 1. ELIGIBLE APPLICANTS 2. SUM SET ASIDE FOR STUDY GRANTS 3. REQUIREMENTS 3.1 Merit requirements 3.2 Economic requirements 4. VALUE OF STUDY GRANTS 5. INTEGRATION TO THE STUDY GRANTS 6. PROCEDURES FOR PREPARING THE RANKING LISTS 7. DEADLINES 8. HOW TO APPLY 9. TRANSFER 9.1 Presentation of the application in the event of transfer to another university 9.2 Presentation of the application in the event of transfer from another university 10. NON-ADMISSION TO THE CALL FOR APPLICATIONS 11. PUBLICATION OF THE RANKING LISTS AND APPEALS 12. ASSIGNMENT OF STUDY GRANTS AND PAYMENT TERMS 13. INADMISSIBILITY, FORFEITURE, REVOCATION OF THE RIGHT 14. CHECKS ON THE TRUTHFUL NATURE OF ECONOMIC DECLARATION PROVIDED 15. INFORMATION ON THE USE OF PERSONAL DATA AND THE RIGHTS OF THE DECLARANT (Art. 13 of the Europian regulation on data protection no.2016/679 GDPR) 16. REMINDER DEADLINES APPENDIX A, B, C, D and E 2 Call For Application 18_19 1. ELIGIBLE APPLICANTS The call for applications is open to everybody: - Italian citizens, - Citizens of European Union Member States, - Citizens of States not belonging to the European Union (Italian Presidential Decree no. 394 dated 31st August 1999, implementing Italian Legislative Decree no. 286 dated 25th July 1998). Applicants must meet all the following requirements: - be a IED student admitted or enrolled in an Academic Diploma First Level course at Istituto Europeo di Design, in the seats of Milan, Rome, Turin, Cagliari or Florence, for the Academic Year 2018/2019; - Have the economic and merit requirements listed in point 3.