Intero Fascicolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mimetic Evolution. New Comparative Perspectives on the Court of Justice of the European Union in Its Federal Judicial Architecture
Mimetic Evolution. New Comparative Perspectives on the Court of Justice of the European Union in its Federal Judicial Architecture Leonardo Pierdominici Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Laws of the European University Institute Florence, 29 February 2016 European University Institute Department of Law Mimetic Evolution. New Comparative Perspectives on the Court of Justice of the European Union in its Federal Judicial Architecture Leonardo Pierdominici Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Laws of the European University Institute Examining Board Prof. Loïc Azoulai, European University Institute Prof. Bruno De Witte, European University Institute Prof. Giuseppe Martinico, Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa Prof. Laurent Pech, Middlesex University London ©Title Leonardo Name Pierdominici,Surname, Institution 2015 Title Name Surname, Institution No part of this thesis may be copied, reproduced or transmitted without prior permission of the author Researcher declaration to accompany the submission of written work Department of Law – LL.M. and Ph.D. Programmes I Leonardo Pierdominici certify that I am the author of the work “Mimetic Evolution. New Comparative Perspectives on the Court of Justice of the European Union in its Federal Judicial Architecture” I have presented for examination for the Ph.D. at the European University Institute. I also certify that this is solely my own original work, other than where I have clearly indicated, in this declaration and in the thesis, that it is the work of others. I warrant that I have obtained all the permissions required for using any material from other copyrighted publications. -

Contents VOLUME 7.1 2017
VOLUME 7.1 2017 Contents Jinshi Chen 1-18 Chunks in Information Flow: a Corpus-based Analysis of Legal Discourse Paula Trzaskawka 19-32 Investigating Trademark Terminology and Collocations in Polish, English, Japanese and German Robin Nilon 33-54 A Better Way to Fail: Teaching Critical Thinking to Chinese Lawyers 55-77 Stefan Wrbka The European Case Law Identifier Search Engine and Multilingualism: A Legal Certainty Perspective on Business-to-Consumer Situations 78-110 Wm. Dennis Huber Law, language, and corporatehood: corporations and the U.S. Constitution International Journal of Law, Language & Discourse Volume 7.1 June 2017 Chief Editor Le Cheng The International Journal of Law, Language & Discourse is an affiliated journal of Multicultural Association of Law and Language. The International Journal of Law, Language & Discourse is an interdisciplinary and cross-cultural peer-reviewed scholarly journal, integrating academic areas of law, linguistics, discourse analysis, psychology and sociology, presenting articles related to legal issues, review of cases, comments and opinions on legal cases and serving as a practical resource for lawyers, judges, legislators, applied linguists, discourse analysts and those academics who teach the future legal generations. For electronic submission Chief Editor: Le Cheng (chengle163@@hotmail.com) Editorial Manager: Jian Li ([email protected]) Production Editor: Jane Lee ([email protected]) Published by English Language Education (ELE) Publishing A diving of TESOL Asia A division of SITE Australia LTD Brisbane, Australia http://www.ijlld.com © International Journal of Law, Language & Discourse (IJLLD) 2017 This book is in copyright. Subject to statutory exception, no reproduction of any part may take place without the written permission of the IJLLD. -

This Project Has Recieved Funding from the European Union's Seventh
This project has recieved funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 285582. Table of Contents Project Information 4 What is RESPECT about? 7 RESPECT and the EU 9 Multi-disciplinary dimension of the research 10 Workplan and Methodology 11 Outcomes 15 RESPECT Target Groups 16 Dissemination activities 17 RESPECT Consortium 18 3 Project information TITLE Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies FUNDING SCHEME Collaborative project (small or medium scale focused research project) DURATION 40 months (February 2012 – May 2015) CO-ORDINATOR University of Groningen CO-ORDINATING Professor Joseph A. Cannataci PERSON WEBSITE www.respectproject.eu CONTACT E-MAIL [email protected] PARTNERS 20 partners (15 countries) and 1 international organization (representing 190 countries) EU FUNDING € 3,492,687 4 Project information SHORT DESCRIPTION Convenience and cost-effectiveness are the two key considerations for both citizens and security forces when deciding which technol- ogies to embrace or avoid in the Information Society. State actors and private corporations adopt information communication technolo- gies (ICTs) because they are cost-effective. The motivation for adoption may be differ- ent in the private and public sectors but once adopted these ICTs are then capable of being bridged in multiple ways permitting police/ security forces to go beyond the data they gather directly by increasingly tapping into data gathered and stored by private corpo- rations. These ICTs, which have to date gone through a period of largely organic growth, will be deemed “in balance” if they are im- plemented in a way which respects individual privacy while still maximising convenience, profitability, public safety and security. -

WHISH 9780857939517 PRINT.Indd
Contributors Manish Agarwal is a Research Fellow at the Centre for Regulation and Market Analysis (CRMA), School of Commerce, University of South Australia (UniSA). He is currently working on contract research under- taken by the CRMA in the area of harbour towage services in Australian ports, and is assisting in the CRMA project on the history of cartels in Australia in the 20th century. Manish received his BCom from the University of Calcutta, an MA and an MPhil in Economics from the University of Delhi, and a PhD from UniSA. Manish has worked at the CUTS Centre for Competition, Investment & Economic Regulation in India, and at the Centre for Good Governance, State Government of Andhra Pradesh, India. Manish has been involved as a researcher in projects funded by government and non-government supported agencies such as the Government of India, the British High Commission in New Delhi, the UK Department for International Development, Canada’s International Development Research Centre, the Agence Francaise de Developpement in Paris and the National Stock Exchange of India. Manish’s broad research interests include competition policy and law, merger regulation and economic regulation; he has authored and co- authored several papers in academic journals and edited books on the topics of mergers and acquisitions, merger regulation, insider trading and capital market regulation, cartels, auditing and accounting services markets, and competition in web search engines. Marco Botta is currently working with the Institute for European Integration Research of the Austrian Academy of Sciences in Vienna. He received his BA in International Relations from Turin University, LLM in European Business Law from Leiden University, and PhD in Law from the European University Institute. -

President's Annual Report on 2015
THE PRESIDENT’S ANNUAL REPORT ON 2015 The President’s Annual Report on 2015 EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE REPORT ON CALENDAR YEAR 2015, PUBLISHED IN SPRING 2016 PUBLISHED IN APRIL 2016 BY THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE © EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, 2016 The European Commission supports the EUI through the European Union budget. This publication reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. CONTENTS INTRODUCTION 7 PART 1. Reports on Academic Activities The Graduate Programme 12 Economics 14 History and Civilization 18 Law 25 -Academy of European Law 33 Political and Social Sciences 35 Robert Schuman Centre for Advanced Studies 42 Max Weber Programme for Postdoctoral Studies 50 Historical Archives of the European Union 56 Library and Institutional Repository (Cadmus) 57 Report on Publications 60 Academic Events - State of the Union 2015 61 Academic Events 2015 64 PART 2. Reports on Services 80 PART 3. The EUI in Numbers 91 PART 4. EUI Governance 105 PART 5. Annexes 112 Annex 1: President’s Decision no. 36/15 113 Annex 2: Annex 2: Framework Agreement with the European Insitute of Public Administration 128 Annex 3: Framework agreement with Le Centre international de formation européenne (CIFE) 130 LIST OF TABLES AND FIGURES Figure 1 Cadmus Usage Statistics, monthly visits in 2015 59 Figure 2 Cadmus: Growth in Content 2010-2015 59 Figure 3 Total Publications in Cadmus, divided by type 59 Figure 4 Publications by EUI members issued in 2015, by type 60 Figure 5 Applications for Ph.D. -
Merab Dekano
Merab Dekano EN & RU > ES Translator & Reviewer (Proz.com Certified PRO) Address: 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, United Kingdom ProZ profile: www.proz.com/translator/1942964 Website: www.dekano-translations.com Email: [email protected] Telephone: +34 673 92 76 77 Skype: merab.dekano BACKGROUND I am a qualified Spanish Translator and Lawyer. I studied Institutional Translation in Spain. I obtained my Master of Laws degree in the United Kingdom. My language combinations are: English-to-Spanish and Russian-to-Spanish. I only translate into Spanish, predominantly the business and law-related texts. I have been offering my services to my customers since 2010. SCOPE The type of documents I translate include but are not limited to: contracts, court orders and judgments, stipulations of settlement, annual financial reports, business correspondence, articles of incorporation, real property deeds, meeting minutes, company guides on corruption, guides to antitrust laws, business codes of conduct, national and European Union legislation, merger decisions, press releases, international news, interviews, speeches, marketing material, market surveys, business proposals, balance sheets, profit and loss statements, master service agreements and similar texts. EDUCATION (2014 - 2015). Universitat d'Alacant. MA in Institutional Translation. English to Spanish: Translation in the Economic and Commercial Fields British and Spanish Legal Systems Professional Editing and Proofreading of Texts Ethics and Professional Practice Translation in the -

RSCAS Policy Papers
ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES RSCAS Policy Papers RSCAS PP 2010/03 ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES A EUROPEAN LAW INSTITUTE? TOWARDS INNOVATION IN EUROPEAN LEGAL INTEGRATION Conference held in EUI Florence April 2010 Organised by Professors F. Cafaggi, F. Francioni, H.-W. Micklitz, and M. Poiares Maduro A European Law Institute? Towards Innovation in European Legal Integration EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, FLORENCE ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR ADVANCED STUDIES A European Law Institute? Towards Innovation in European Legal Integration ORGANISED BY F. CAFAGGI, F. FRANCIONI, H.-W. MICKLITZ, M. POIARES MADURO CONFERENCE HELD IN EUI FLORENCE APRIL 2010 F. Cafaggi, F. Francioni, H.-W. Micklitz and M. Poiares Maduro This text may be downloaded only for personal research purposes. Additional reproduction for other purposes, whether in hard copies or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the working paper, or other series, the year and the publisher. The author(s)/editor(s) should inform the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the EUI if the paper will be published elsewhere and also take responsibility for any consequential obligation(s). ISSN 1830-1541 © 2010 Organised by Professors F. Cafaggi, F. Francioni, H.-W. Micklitz, M. Poiares Maduro Printed in Italy, September 2010 European University Institute Badia Fiesolana I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italy www.eui.eu/RSCAS/Publications/ www.eui.eu cadmus.eui.eu 4 A European Law Institute? Towards Innovation in European Legal Integration Robert Schuman Centre for Advanced Studies The Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), directed by Stefano Bartolini since September 2006, is home to a large post-doctoral programme. -

'Europeanisation' of the Law: Consequences
Prof. Dr. S. Prechal Dr. R.H. van Ooik Prof. Dr. J.H. Jans Prof. Dr. K.J.M. Mortelmans ‘Europeanisation’ of the Law: Consequences for the Dutch Judiciary Table of Contents The report 1. Introduction 4 2. The horizontal dimension: general and common aspects of the ‘Europeanisation’ process of the Dutch judiciary 8 2.1 The organisation of the administration of justice in the EU 8 2.1.1 Centralised and decentralised enforcement of Community law 8 2.1.2 The interrelationship between centralised and decentralised enforcement and the shifting workload 9 2.1.3 The Constitutional Treaty and judicial enforcement of EU Law 11 2.2 EU law and national judicial procedures 13 2.2.1 The effects of EU law on national procedural law and the organisation of the courts 13 2.2.2 The duty to ensure effective judicial protection 14 2.2.3 Five practical examples of how the Court’s case law could affect the organisation of the Dutch judiciary 16 2.3 Procedural implications of recent developments in European substantive law 20 2.3.1 Free movement 20 2.3.2 Competition policy 21 2.3.3 State aid 24 2.4 The preliminary reference procedure 25 2.4.1 Length of the procedure 25 2.4.2 Proposals for revamping the preliminary reference procedure 26 2.4.3 Short term solutions 29 2.5 The Constitutional Treaty and the protection of fundamental rights 29 3. The vertical dimension: European developments specific to civil, administrative and criminal law 32 3.1 Civil law 32 3.1.1 Internal market legislation 32 3.1.2 Private international law 33 3.1.3 Enforcement and the future of European private law 34 2 ‘Europeanisation’ of the Law: Consequences for the Dutch Judiciary 3.2 Administrative law 35 3.2.1 Competition law 35 3.2.2 Environmental law 36 3.2.3 Immigration law 37 3.2.4 Telecom law 39 3.2.5 Agriculture and fisheries 40 3.3 Criminal law 40 3.3.1 The traditional role of the criminal judge 40 3.3.2 Obligation to enforce EC law through criminal law 41 3.3.3 Third pillar: police and judicial cooperation in criminal matters 42 3.3.4 Criminal law and the Constitutional Treaty 43 4. -
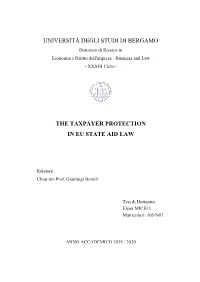
0 Bozza Tesi Completa
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dottorato di Ricerca in Economia e Diritto dell'impresa - Business and Law - XXXIII Ciclo - THE TAXPAYER PROTECTION IN EU STATE AID LAW Relatore: Chiar.mo Prof. Gianluigi Bizioli Tesi di Dottorato Elena MICELI Matricola n. 1051907 ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ............................................................ 1 CHAPTER I FISCAL STATE AID 1. The concept of State Aid in the field of taxation: introduction............................................................................. 13 2. The interplay between State Aid prohibition and direct taxation: an historical view…………………………………………… 26 3. The methodology of State Aid review of tax measures. ....... 37 3.1. State Aid criteria: selectivity and advantage. ........... 39 3.2. The three-step test: reference system, derogation and justification. ...................................................................... 53 4. Overview on recent trends: the EC investigations and decisions and the review of tax rulings under State Aid rules. ............... 73 5. What is the taxpayer's perspective? A -still- unresolved issue......................................................................................... 99 CHAPTER II THE TAXPAYER'S POSITION IN STATE AID INVESTIGATION PROCEDURE 1. The procedural rules. ............................................................. 105 II 2. Benchmark: the fundamental rights as general principles of EU law and the possible application of the EU Charter of fundamental rights. .............................................................. -

Trafficking in Human Beings Ten Years of Independent Monitoring
Trafficking in Human Beings Ten years of independent monitoring Colophon Reference: National Rapporteur on Trafficking in Human Beings (2010). Human Trafficking – ten years of independent monitoring. The Hague: BNRM Bureau of the Dutch National Rapporteur P.O.Box 20301 2500 EH The Hague +31703704514 www.bnrm.nl Production and layout: Het vlakke land, Rotterdam © bnrm 2010 0 Content Overview of Figures and Tables 5 Foreword 7 1 The office of National Rapporteur 9 1.1 Introduction 9 1.2 Interviews 14 1.3 A look into the future 20 2 Recommendations and developments 23 2.1 Introduction 23 2.2 Legislation 24 2.3 International developments 31 2.4 Victims 39 2.5 Immigration law 46 2.6 Supervision, enforcement and investigation in the sex industry 57 2.7 Training, awareness and identification 65 2.8 Prosecution and trial 77 3 Data collection and statistical trends 2000 – 2009 87 3.1 Introduction 87 3.2 Data collection 87 3.3 Victims 89 3.4 Suspects and offenders 112 4 The National Rapporteur on Trafficking in Human Beings in the Netherlands: Ten Years On 139 Bibliography 145 Appendix 149 A1 Article 273f of the Dutch criminal code (non-official translation) 151 I Article 273f of the Dutch Criminal Code (valid until 1 July 2009) 151 I I Article 273f of the Dutch Criminal Code (valid from 1 July 2009) 152 A2 Explanatory notes to Figures, Tables and Statistics 155 A3 Additional tables 157 Supplement to § 3.3.1: Victims in the CoMensha register 157 Supplement to § 3.3.2 Victims and the B9 regulation 179 Supplement to § 3.3.3: Victims and compensation -

European Union
SIB LEIDEN The Future of the European Union THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION Different aspects of the EU as discussed during the SIB Leiden Conference 2007 On November 29th 2007, the Dutch United Nations Student Association (SIB Leiden) organized a Conference, titled: “The Future of the European Union – How to Proceed in an Ever Closer Union?” The conference was meant to offer students, young academics and professionals the opportunity to engage in a debate with prominent scholars and politicians on the Future of Europe. This book contains an overview of the various issues that were discussed during the conference and attempts to do justice to both the interdisciplin- arity of the conference programme and the variety of people who attended. Therefore, readers will find contributions from both Dutch and interna- tional scholars; from young academics from SIB Leiden; and from various politicians and other professionals working daily on European Union issues. As this book offers a collection of essays resulting from a Dutch conference on an international topic, contributions are either in English or in Dutch. The editors have aimed at an equal number of English and Dutch texts. This book does not claim to be exhaustive, nor does it attempt to offer one single vision of the Union’s future. Quite the contrary: the conference was meant to explore as many scenarios for the EU as possible, and to put every aspect of the European Union up for discussion. Each of the essays in this book thus explores one such aspect of the EU, and offers the author’s view of the road that has been taken, or should be taken. -

EU PUBLIC PROCUREMENT LAW TRAINING 5-6 March 2015 – Academy of European Law (ERA) - Trier, Germany
European Judicial Training Network Réseau Européen de Formation Judiciaire EU PUBLIC PROCUREMENT LAW TRAINING 5-6 March 2015 – Academy of European Law (ERA) - Trier, Germany PANEL OF SPEAKERS Eirini VOLIKOU (ERA) [email protected] Ms Volikou joined ERA’s Business Law Section in July 2013, where she currently holds the position of Course Director responsible for EU Competition, State Aid and Public Procurement Law. She is a Law Graduate from Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2005), and hold an LL.M. in International and European Law with specialization on EU Law from University of Amsterdam, The Netherlands (2008), as well as a Postgraduate Diploma in EU Competition Law from King's College London, UK (2012). Ms Volikou was a trainee lawyer at the Skoula, Marazakis & Kefaloyannis Law Firm in Heraklion, Greece, from 2006-2007, and a Bluebook trainee dealing with Internal Market Law and harmonization issues in the Tobacco Control team of the European Commission’s DG SANCO, in Brussels, Belgium (2009). She further worked as a Freelance legal editor at Caselex S.a.r.l. covering Greek Supreme Courts judgments on the EU Internal Market and EU Employment Law (2010). Ms Volikou is qualified to practice law in Greece since 2009 and practiced as a civil and commercial lawyer at Adamantia & Eirini Volikou Law Office, in Heraklion, Greece, from 2009 to 2013. Lecture/Workshop: . Seminar Moderator Roberto CARANTA (Italy) [email protected] Roberto Caranta is a Professor of Administrative Law with the Law Department of the University of Turin (Italy), as well as the Director of two master programs on Public Procurement Management for Sustainable Development organized by the University of Turin and the ITC-ILO.