Numero II Dei Quaderni Del
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Theescapist 042.Pdf
putting an interview with the Garriott Games Lost My Emotion” the “Gaming at Keep up the good work. brothers, an article from newcomer Nick the Margins” series and even “The Play Bousfield about an old adventure game, Is the Thing,” you described the need for A loyal reader, Originally, this week’s issue was The Last Express and an article from games that show the consequences of Nathan Jeles supposed to be “Gaming’s Young Turks Greg Costikyan sharing the roots of our actions, and allow us to make and Slavs,” an issue about the rise of games, all in the same issue. I’ll look decisions that will affect the outcome of To the Editor: First, let’s get the usual gaming in Eastern Europe, both in forward to your comments on The Lounge. the game. In our society there are fewer pleasantries dispensed with. I love the development and in playerbase. I and fewer people willing to take magazine, read it every week, enjoy received several article pitches on the Cheers, responsibility for their actions or believe thinking about the issues it throws up, topic and the issue was nearly full. And that their actions have no consequences. and love that other people think games then flu season hit. And then allergies Many of these people are in the marketing are more than they may first appear. hit. All but one of my writers for this issue demographic for video games. It is great has fallen prey to flu, allergies or a minor to see a group of people who are interested There’s one game, one, that has made bout of forgetfulness. -

Wargamer's Newsletter
w*> Wargamer's Newsletter i.Tr- A MONTHLY MAGAZINE FOR THOSE WHO FIGHT BATTLES WITH MODEL SOLDIERS MINIATURE FIGURINES LTD. 5 NORTHAM ROAD, SOUTHAMPTON, S02 ONZ — TELE 20855 The Metal Model Soldier Manufacturers run by Wargamers for Wargamers offer the tTZto the Sw?nite*BRITISH COLONIAL 1880s.«oWH^Einclusivcover,n* the periods between ANCIENT EGYPT With the effect from 1st May 1971, we withdrew all HO/OO figures and therefore apologise to all our customers for any inconvenience this may give with your present Wargaming setup. This step has been taken because the "S" Range 25mm figures are now so popular it is impractical carrying two sixes of figures very close in scale, but with the 25mm detail we have no alternative other than discontinuing the HO/00 listings. The March 1971 Catalogue is available at l8p and this shows the figures now available in the 25mm range. However Dick and his Apprentice have again done the "dirty" on me so a number of new figures are available and not referenced in the listings. Again my memory was not one hundred per cent when we typed up the proof so hereunder is the current list of NEW and FORGOTTEN Napoleonic B.N. 5^S British Waterloo Foot Guards Grenadier Advancing. F.N. 6S French Line Chasseur Officer Advancing. F.N. 52S French Old Guard Drummer. F.N. 53s French Elite Light Infantry Officer. F.N. 5^S French Carabineer Advancing. F.N. 56S French Battalion Company Infantryman Advancing. ANCIENT Elephant IS is priced 75p and includes Howdah and Mahout. ENGLISH CIVIL WAR E.C.W.A. -

Donald Featherstone's Air War Games: Wargaming Aerial Warfare 1914
Donald Featherstone’s Air War Games Wargaming Aerial Warfare 1914-1975 Revised Edition Edited by John Curry This book was first published in 1966 as Air War Games by Stanley and Paul. This edition 2015 Copyright © 2015 John Curry and Donald Featherstone Sturmstaffel: Defending the Reich is copyright of Tim Gow; Rolling Thunder is copyright Ian Drury, and On a Wing and Prayer is copyright John Armatys. All three sets of rules are reproduced with permission. With thanks to all three of these people who kindly contributed to this new edition. The right of John Curry and Donald Featherstone to be identified as Author of this Work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the authors in writing. More than 30 books are currently in the History of Wargaming Project Army Wargames: Staff College Exercises 1870-1980. Charlie Wesencraft’s Practical Wargaming Charlie Wesencraft’s With Pike and Musket Donald Featherstone’s Lost Tales Donald Featherstone’s War Games Donald Featherstone’s Skirmish Wargaming Donald Featherstone’s Naval Wargames Donald Featherstone’s Advanced Wargames Donald Featherstone’s Wargaming Campaigns Donald Featherstone’s Solo Wargaming Paddy Griffith’s Napoleonic Wargaming for Fun Sprawling Wargames: Multi-player wargaming by Paddy Griffith Verdy’s ‘Free Kriegspiel’ including the Victorian Army’s 1896 War Game Tony Bath’s Ancient Wargaming Phil Dunn’s Sea Battles Joseph Morschauser’s How to Play War Games in Miniature And many others See The History of Wargaming Project for other publications. -

WWI WARGAMES Catalogue
Catalogue 168 pages of colour rich information with an introduction by writer Charles Singleton, this supplement for Pike & Shotte describes the history, armies, personalities and battles of the English Civil War. Included are detailed scenarios based on some of the most famous battles, complete with maps and orders of battle £22.50 SEASON OF BATTLE CARD FIELD OF BATTLE etc - One 54 card deck of wargames style battlefield maps. The FOB campaign System BUT USEFUL for ANY wargamer as a random Terrain Generator . £22.50 AMERICAN CIVIL WAR SMOOTHBORE ARTILLERY (SMOOTHBORE ORDNANCE JOURNAL VOLUME 10) Summerfield, Dr S 143pp., 4to, fully illus., large format pbk 38 scale plans, 107 tables, 135 photos. of contemporary & surviving ordnance covers graphically & in detail every aspect of the vital smoothbore elements of ACW artillery. £20.00 AMERICAN REVOLUTION : THE FRENCH - COMMAND & COLOURS TRICORNE - COMPASS GAMES - - £82.50 Armies of the Medieval Italian Wars 1125-1325 - Ospery MAA 523- £10.99 ARMY OF THE DUTCH REPUBLIC, 1713-1772, PART I: INFANTRY FOR ORANGE AND THE STATES. THE - £17.50 BY FORCE OF ARMS - AUSTRIAN ARMY IN THE SEVEN YEARS WAR 2) Duffy Mint hardback £65.00 HANDBOOK OF THE BELGIAN ARMY 1914 Mint hbk facsimile of British General staff study £29.50 HUSSAR SERGEANT IN THE KING'S GERMAN LEGION: The Memoirs of Cavalry Sergeant Ebbecke, 2nd Hussar Regiment, King's German Legion 1803-15 - This short memoir of Sergeant Ludwig Ebbecke was published in German in 1851, but has never before been translated into English. He served at Stralsund, the Siege of Copenhagen in 1807, and was nearly shipwrecked on the passage back to Britain. -

Wohnzimmerkriege. Vom Brettspiel Zum Computerspiel 2008
Repositorium für die Medienwissenschaft Sebastian Detering Wohnzimmerkriege. Vom Brettspiel zum Computerspiel 2008 https://doi.org/10.25969/mediarep/1560 Veröffentlichungsversion / published version Sammelbandbeitrag / collection article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Detering, Sebastian: Wohnzimmerkriege. Vom Brettspiel zum Computerspiel. In: Rolf F. Nohr, Serjoscha Wiemer (Hg.): Strategie Spielen. Medialität, Geschichte und Politik des Strategiespiels. Münster: LIT 2008 (Medien'welten. Braunschweiger Schriften zur Medienkultur), S. 87–113. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/1560. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter Attribution - Non Commercial - Share Alike 3.0 License. For more gleichen Bedingungen 3.0 Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere information see: Auskünfte zu dieser Lizenz finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 Sebastian Deterding Wohnzimmerkriege Vom Brettspiel zum Computerspiel Wells könnte nicht rechter haben: Kriegsspiele wa- .»A game for boys from twelve years of age to one ren immer schon ›a boy‘s thing‹. Noch im Kinder- hundred and fifty and for that more intelligent sort garten schmiedeten ›wir Jungs‹ Stöcke zu Maschi- of girls who like boys‘ games and books.« nengewehren. Als Kinder schnippten wir Steine H. G. Wells, Litte Wars gegen Treibholz im Fluss und phantasierten da- bei von Flugzeugträgern und Kamikazes. Unser Taschengeld floss in Transparentbeutel gratiger Plastikheere in Grün, Braun, Grau (leicht entzündliche Heere, wie wir mit Freude und zum Unmut unserer Eltern bald herausfanden), und Playmobil gewann über Lego, weil es Gewehre und Pistolen hatte. -
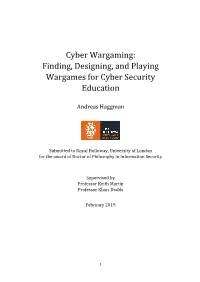
Cyber Wargaming: Finding, Designing, and Playing Wargames for Cyber Security Education
Cyber Wargaming: Finding, Designing, and Playing Wargames for Cyber Security Education Andreas Haggman Submitted to Royal Holloway, University of London for the award of Doctor of Philosophy in Information Security Supervised by Professor Keith Martin Professor Klaus Dodds February 2019 1 Declaration of authorship I, Andreas Haggman, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Signed: Date: 2 Abstract This thesis investigates, and contributes to, the use of wargaming in cyber security education. Wargaming has a rich history of pedagogic use, but little work exists that addresses the critically important subject of cyber security. Cyber security is a global problem that frequently makes news headlines, yet the field is dogged with a reputation as a domain only for technologists, when in fact cyber security requires a whole gamut of approaches to be properly understood. The thesis is broadly divided into three parts. The first part is a comprehensive literature review of wargaming scholarship, analysing the benefits and drawbacks of wargaming, and some of the justifications for why a tabletop boardgame may be more effective than a game enhanced by technology. Following on from this, the thesis provides an outline of current work in cyber wargaming by analysing existing games, evaluating their contributions as educational tools, and identifying successful game mechanics and components. The second part of the thesis outlines the design process of an original wargame created for cyber security education and awareness training. The analysis outlines what the game design intends to achieve in terms of pedagogical outcomes and how the design evolved through the development process. -

WARGAMER's NEWSLETTER NO 178 30P JANUARY 1977
WARGAMER'S NEWSLETTER NO 178 30p JANUARY 1977 A MONTHLY MAGAZINE FOR THOSE WHO FIGHT BATTLES WITH MODEL SOLDIERS WARGAMER'S NEWSLETTER !!! The NEWSPAPER of the hobby! 3000 FIGURES IN A CONSTANT SCALE -HERE ARE AFEW M O R Eiirl ALL BRITISH and FRENCH NAPOLEONIC INFANTRY and CAVALRY ARE NOW IN PRODUCTION.ORDER FROM YOUR STOCKIST or DIRECT. / Ml IMMATURE FIGURINES LTD 2t-32 NQRTHAM RIL SOUTHMMPTON. TehZOSSS ROS FIGURES and HEROICS FIGURES R OS Figures and Heroicsfigures combine to bring an unrivalled selection of micro-tanks, and Heroics unique range of1/300th scale figures together. AII ourfigures are made of high quality tin-lead alloy and great attention is paid to detail and proportion. ROS WORLD WAR II MICRO-AFV's Weasel F14A Tomcat (25p) German Sd 251/16 Flame UK 6 par USSR M4 H.S. tractor Eagle F15 (25p) Panzer MB Tetrarch 17 pdr Sd 251 Rocket Launcher T34/76B Dodge Weapons Carrier Mirage IMC (15p) Panzer MF Arm'd Mauitier Rocket L Honey 25 pdr T34/76D Italian Harrier (15p) Panzer 11 Flame Sd 250 T34/85 Grant 2 pdr M13/40 Buccaneer (25p) Wespe Sd 250/9 A/C Sherman M4A1 5.5 in howitzer KV1 CV LB/40 Lynx B IV demolition vehicle Firefly 7 2 in howitzer KV2 Semovente 75 WW2 Panzer IIIJ Opel Blitz Matilda Quad SU85. Semovente 47/32 Hanomag SdKfz/1 D- Panzer IIIM Opel Mauitier softskin Valentine II Bedford QL SU 100 47/32 AT + crew late version Panzer IIIN Kubelwagen (Bp) Chevrolet 15 cwt T35 Valentine IXX Rommel-Personality SdKfz 10 StuG MIG Schuwimmwagen (Bp) Archer Chevrolet 3 ton T28 Set including Flak vierling on Sd7 Panzer IVD BMW -

Wargamer's Newsletter
II' Wargamer's Newsletter p*% U< ifi ^£.*sri A MONTHLY MAGAZINE FOR THOSE WHO FIGHT BATTLES WITH MODEL SOLDIERS MINIATURE FIGURINES LTD. 5 NORTHAM ROAD, SOUTHAMPTON, S02 ONZ — TELE 2085S The Metal Model Soldier Manufacturers run by Wargamers for Wargamers offer the lowest priced metal figures ANYWHERE covering the periods between ANCIENT EGYPT to the BRITISH COLONIAL 1880s inclusive. We have decided to bring out a new Price List which bears a relation to our old one and with the exception of Postage shows no increase for a reasonable order. Range "S" pricings:- 1 INFANTRY Figure 1 CAVALRY Figure (Horse & Rider) 2 INFANTRY Figures 3 CAVALRY Figures k INFANTRY Figures 6 CAVALRY Figures £1 8 INFANTRY Figures 1 RIDER Only 16 INFANTRY Figures £1 1 HORSE Only 1 GUN 1 CAMEL & RIDER 1 LIMBER 1 CAMEL Only 1 BALLLSTA 1 OX Only 1 CAISSON 1 PACK HORSE CHARIOT SET of Chariot, 2 Horses and 2 men 55p- GUN SET of Gun, Limber, k Horses and 2 Riders £1.00p. AMBULANCE SET of Ambulance, 2 Horses & Rider £1„00p. CAISSON SET of Caisson, 4 Horses & 2 Riders £1„00p. CARRIAGE SET of Carriage, 2 Horses, General and Driver £1.00p. OX CHARIOT SET of Chariot, *f Oxen & 2 men 85p. POSTAGE & PACKING (Inland) Up to £1„00p 10p. Overseas Customers allow £1.00$ to £2.00p 15P- 1C$ of order value with a £2.00p to £3.00p 20p. minimum of 15P- £5„00p to £5.00p 25p. £5.00p to £10. 35P- £10 to £15- kOp. £15 to £20 50p. -

January 1974
;^2- Wargamer's Newsletter •^y A MONTHLY MAGAZINE FOR THOSE WHO FIGHT BATTLES WITH MODEL SOLDIERS MINIATURE FIGURINES LIMITED 28/32 NORTHAM ROAD, SOUTHAMPTON S02 OPA Teleph Directors SOUTHAMPTON 20855 (STD 0703) NEVILLE DICKINSON. MICM WEST END 4651 (after 7 p.m.). (STD 0421 RICHARD DICK' HIGGS. D.Art ADDITIONS TO THE ADDITIONS TO THE 1973 CATALOGUE FULL 15mm. RANGE P.B.P. £ VOLGASES 20p CATALOGUE ANCIENT - lOp each strip P.B.P.1C CARRATICUS 10p 25p 15 A 1 Roman Cavalryman P.B.P. 1 BODECIA i lOp 15 A 2 Half Armoured Caiaphracts P.B.P. 15 CARTIMANDUA 10p 15 A 3 Gaul Horse Archers P.B.P.1C DECEBALUS 20p 15 A 4 Gaul Light Lancers P.B.P.14 SAPOR 20p 15 A 5 Gaul Slingers (shioldless) FOOT 6Jp P.B.P. 1E VERCINGETORIX 20p 15 A 6 Gaul Javclmmon (shioldloss) RIDER 7}p 15 A 7 Gaul Heavy Spoaimen P.B.P. H CAESAR 20p 15 A 8 Gaul Light Spearmen P.B.P r ZENOBIA 20p HORSE 10p 15 A 9 Roman Auxiliary Archers P.B. 224 SASSANID HOWDAH SPEAR GUN 25p 15 A 10 Roman Legionnaires MAN 6)p 15mm. 10p 15 A 11 Persian Light Spearman P.B. 116a IMAGO 5mm. 5p ENGLISH CIVIL WAR P.B. 116b PRAETORIAN 2Jp 15 E 1 Royalist Musketeers P.B. 116c LEGIO each 15 E 2 Royalist Cavalrymen P.B. 116d VEXILLUM 15 E 3 Roundhead Cavalrymen P.B. 1161 AQUILA POSTAGE 15 E 4 Mounted Dragoons G. 1 THRACIAN GLADIATOR 15 E 5 Artillery Crew Up to £1 — lOp G. -

Meeting the Legendary Practical Wargamer
Editorial News/Events Column Feature Profile Scenario Painting Modelling Reviews Advertising Wargaming with Wesencraft Meeting the legendary practical wargamer Paul Stevenson and Robbie Rodiss was asked me to invite Charlie. Robbie and John always spend time with one of the great doyens of supported my wargames shows up in Newcastle with their fine the hobby who has modestly ploughed his demonstration games. I used to write a lot for Practical Wargamer own furrow for more than four decades whilst at the time and the editor, Stuart Asquith, a big Marlburian fan and a pal of Charlie’s, was keen to have some coverage of the inspiring the gaming of thousands. game in his magazine for those two good reasons. So here we were again, a little later in time, in both the real and wargame period sense, still with miniature fellows in three-cornered obbie’s lovely wife, Carol, showed me in and I loped hats, but this time they were time three times the size, featuring up the three flights of stairs to where it was all going to some really ‘old school’ figures such as the likes of Hinchliffe, happen. There he was, perched on a high stool, the first Garrison and Suren and other classics of their kind. face to greet my arrival in Robbie’s splendid wargames Rroom. Being an ex-runner, the seventy-five year old had THE GAME obviously taken the upward journey in his stride! What follows first is just a brief description of an everyday sort The first time I encountered Mr Charles Wesencraft was of wargame, but it does involve Charlie Wesencraft – and this is at a talk he gave on the Battle of Otterburn at Sunderland precisely the point. -

The Strategic Review Vol. 1, No. 3
WHAT’S GOING ON HERE? TSR NEWS As we have said before, things keep happening so fast around here that we EDITORIAL cannot keep you properly informed despite our best efforts! Item: TSR has formed a Hobbies Division, TSR HOBBIES, advertised herein. It will soon have a catalog with no less than 150 different miniatures for fantasy gaming — as well as other Donald Featherstone once said in WARGAMER’S NEWSLETTER that he goodies. Brian is in charge of this operation. Item: TSR is forming yet another believed Arnold Hendrick’s chief talent and claim to fame lay in his “pinching” of division, TSR GAMES, which will publish Mike Carr’s classic FIGHT IN Fletcher Pratt’s Naval Wargame — alluding in all likelihood to similarities be- THE SKIES in a 5th edition, as well as a super-fun fantasy boardgame in the tween Mr. Pratt’s game and the set of rules for naval miniatures authored by Mr. near future. Item: Due to the demands of running TSR, we have employed Gary Hendrick. I concurred with what was said in WARGAMER’S NEWSLETTER, Gygax full-time, and he is now responsible for all orders, billing, and accounting. and when the good Mr. Hendrick “reviewed” CHAINMAIL in a highly un- Item: TSR has not less than ten titles — rules and games — nearing completion, complimentary manner I ignored what was written, for surely most hobbyists and only available funds and publicity factors will tend to slow the pace of their could be assumed to be able to read this “review” for what it was worth and in release during the next year. -

The Handbook of Cyber Wargames: Wargaming the 21St Century Pdf, Epub, Ebook
THE HANDBOOK OF CYBER WARGAMES: WARGAMING THE 21ST CENTURY PDF, EPUB, EBOOK John Curry | 172 pages | 01 Apr 2020 | Lulu.com | 9780244868673 | English | Morrisville, United States The Handbook of Cyber Wargames: Wargaming the 21st Century PDF Book Sport plays a major part in Army culture. By providing worked examples of different types of manual cyber wargame, including aims and objectives for each, it provides a basis for the reader to understand the potential range of games on offer. Learn more at Author Central. In , he introduced wargaming and soon became the U. Sorry, there was a problem saving your cookie preferences. In the private sector, wargaming can help leaders understand the kinds of damage that could be inflicted on their organizations in the event of a cyberattack, and lead them to channel resources and investment towards more effective mitigations and capabilities. The third section explores medieval sieges and street fighting. Show all. Home Issues Regions Search Menu. Public confidence in government. He is also working on the design and autonomic monitoring of real-time and critical applications and systems. In the modern world of Facebook, blogs and even podcasts, the connection between players has never been greater. However, new dynamics of conflict are threatening the internet as we know it. Back to the Ultramodern Gaming present Message Board. Medieval warfare is part of our culture. Provide feedback about this page. Help us improve our Author Pages by updating your bibliography and submitting a new or current image and biography. Greater insight into risk and response allow public and private sector organizations to better prepare for crises before they happen and rerun history to stave off defeat in future.