Welcome to Vado Ligure, Carmel!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Targeting Israeli Apartheid: a Boycott Divestment and Sanctions Handbook
“We, representatives of Palestinian civil society, call upon international civil society organizations and people of conscience all over the world to impose broad boycotts and implement divestment initiatives against Israel, similar to those applied to South Africa in the apartheid era. We appeal to you to pressure your respective states to impose embargoes and sanctions against Israel. We also invite conscientious Israelis to support this Call, for the sake of justice and genuine peace.” Palestinian Civil Society Call for Boycott Divestment and Sanctions, 2005 “There are concrete steps that people can take, learning from the lessons of the first Intifada and the Boycott, Divestment and Sanctions campaign to dismantle the South African Apartheid regime; strategies of popular resistance, strikes, occupations, direct actions. From the streets into the offices, factories and headquarters is where we need to take this fight, to the heart of decision-makers that are supposedly making decisions on our behalf and the companies making a killing out of the occupation. The third intifada needs to be a global intifada.” Ewa Jasiewicz, from the besieged Gaza Strip, January 2009 "Israel is committing a grave crime in Gaza. 350 children have been reported dead. It's absolutely disgusting that weapons are being made in our cities in our country that are being used to kill innocent women and children and are being used indiscriminately; it's about time that something was done about it. If the law and the police can't do anything about it, it's about time somebody else did." Tom Woodhead, one of the 'EDO Decomissioners', January 2009. -

Individual Consumer Measures
Economic Advocacy Measures Options for KAIROS Members for the Promotion of Peace in Palestine and Israel January 7, 2008 KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives 129 St. Clair Ave. W. Toronto, ON M4V 1N5 www.kairoscanada.org Economic Advocacy Measures Options for KAIROS Members for the Promotion of Peace in Palestine and Israel (Note: The electronic version of this document contains embedded web links to provide the reader with background material. Web links can be accessed by clicking on the blue text. While all the links were active as of the production date of this paper, KAIROS can not guarantee their functionality in the future as third party web content may change.) 1 Introduction Canadian churches and church organizations have been working together for many years to promote a just peace between Israelis and Palestinians. The formation of KAIROS in 2001 saw the continuation of these efforts in the form of ongoing partnerships with Palestinian and Israeli organizations, education in Canada, and advocacy with the Canadian government. In 2002, the KAIROS Board passed a policy on the Israeli-Palestinian conflict (see Appendix A). KAIROS affirms the desire of the Israeli people for a secure homeland, recognizing the long, terrible and continuing history of anti-Semitism, and the vital role of Israel to Jewish people around the world. KAIROS also recognizes the great suffering of the Palestinian people, many of whom live as refugees in surrounding countries, and others who have lived under Occupation for 40 years, and affirms their right to a secure and viable homeland. KAIROS calls for an end to the Israeli Occupation of Palestinian Territories and for two secure states based on the June 4, 1967 borders. -

Made in Israel: Agricultural Exports from Occupied Territories
Agricultural Made in Exports from Israel Occupied Territories April 2014 Agricultural Made in Exports from Israel Occupied Territories April 2014 The Coalition of Women for Peace was established by bringing together ten feminist peace organizations and non-affiliated activist women in Israel. Founded soon after the outbreak of the Second Intifada in 2000, CWP today is a leading voice against the occupation, committed to feminist principles of organization and Jewish-Palestinian partnership, in a relentless struggle for a just society. CWP continuously voices a critical position against militarism and advocates for radical social and political change. Its work includes direct action and public campaigning in Israel and internationally, a pioneering investigative project exposing the occupation industry, outreach to Israeli audiences and political empowerment of women across communities and capacity-building and support for grassroots activists and initiatives for peace and justice. www.coalitionofwomen.org | [email protected] Who Profits from the Occupation is a research center dedicated to exposing the commercial involvement of Israeli and international companies in the continued Israeli control over Palestinian and Syrian land. Currently, we focus on three main areas of corporate involvement in the occupation: the settlement industry, economic exploitation and control over population. Who Profits operates an online database which includes information concerning companies that are commercially complicit in the occupation. Moreover, the center publishes in-depth reports and flash reports about industries, projects and specific companies. Who Profits also serves as an information center for queries regarding corporate involvement in the occupation – from individuals and civil society organizations working to end the Israeli occupation and to promote international law, corporate social responsibility, social justice and labor rights. -

Boycotts, Divestment & Sanctions
MA’AN DEVELOPMENT CENTER DIVESTMENT& SANCTIONS lessons learned in effective solidarity BOYCOTT, DIVESTMENT, & SANCTIONS BOYCOTT, DIVESTMENT, & SANCTIONS lessons learned in effective solidarity 2009 CONTENTS WHY BOYCOTT, DIVESTMENT, SANCTIONS? ............................ 3 THE LESSONS OF BOYCOTT ...................................................... 4 1. Boycott takes time .................................................. 4 1.2 The challenge of normalization 2. Boycott as a grassroots movement ........................ 11 3. Clear goals based on justice .................................. 17 3.1 Strategic targeting 4. Economic isolation works ...................................... 21 4.1 The challenge of dependency DEFINING BDS: TOWARDS A WORKING FRAMEWORK ........... 26 RECOMMENDATIONS ............................................................... 30 HY W OYCOTT, BDIVESTMENT SANCTIONS ? “For years the occupation of Palestine and into a powerful global movement that can apartheid in South Africa vied for attention isolate Israel. Just as the 1960 massacre from the international community. In 1994, of protesters at Sharpeville spurred on apartheid came to an end and Palestine the campaign to end Apartheid, global, became the only developing country in the regional and local civil society outrage world under the subjugation of a Western- over Israel’s actions is at a peak following affiliated regime. Herein lies its significance the massacre of over 1,400 Gazans during to the future of human rights. There are other regimes, particularly in the developing Israeli Operation Cast Lead. Now is the world, that suppress human rights, but there is opportune time. no other case of a Western-affiliated regime that denies self-determination and human This report traces the history of BDS for rights to a developing people, and that has Palestine and outlines current efforts and done so for so long.” challenges that must be overcome. -

Home >> LATEST NEWS >> January 29, 2009 Direct Action Against Israel –
home >> LATEST NEWS >> January 29, 2009 http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=3192 Direct Action Against Israel – Part 1 On the second big Gaza solidarity march in London on 10th January, angry protesters smashed the front of a Starbucks store on Kensington High St, near the Israeli embassy, while other activists occupied the Ahava beauty shop in central London. Other actions in protest at the Israeli massacre in Gaza this month have included occupying the offices of the British Israel Communications and Research Centre (BICOM) in central London, 'decommissioning' the ITT/EDO arms factory in Brighton and university occupations across the country calling for divestment. So, who are these companies and why are they being targeted by protesters and campaigners? Corporate Watch takes a detailed look. 1. ARMS COMPANIES Israel was the world's 6th largest arms importer between 2003 and 2007, accounting for 3.80% of world deliveries, according to the SIPRI Arms Transfers Database. During that period, the US accounted for 94% of the exports of arms to Israel. France, Germany and the UK accounted for a big proportion of the rest. In 2007 alone, EU member states authorised the export of €200m worth of items on the EU Military List to Israel. In 2007, the UK government blocked almost one-third of British military exports to Israel, citing "possible threats to regional stability" and fears that "the equipment might facilitate human rights violations." Despite Israel's continuous war crimes against the Palestinian people, however, the UK has no arms embargo on Israel and licences for the export of military 'goods' continue to be granted in accordance with the criteria set down in the Consolidated EU and National Arms Export Licensing Criteria (see, for example, this Parliamentary review). -

Palestine CW Report (PDF)
Corporate Watch www.corporatewatch.org [email protected] 2 contents Arms Companies 5 BAE Boeing EDO/ITT Raytheon Lockheed Martin UAV Engines Caterpillar Illegal Produce 10 Agrexco Ahava Eden Springs Veolia Leviev Banks 13 Lloyds TSB Media 14 BICOM BBC Supermarkets 15 Tesco Marks & Spencer Asda Co-op Waitrose Sainsbury's Somerfield Coffee Shops 23 Starbucks Oil & Gas 24 BG Group Notes 26 3 On the second big Gaza solidarity march in London on 10th January, angry protesters smashed the front of a Starbucks store on Kensington High St, near the Israeli embassy, while other activists occupied the Ahava beauty shop in central London. Other actions in protest at the Israeli massacre in Gaza that month included occupying the offices of the British Israel Communications and Research Centre (BICOM) in central London, 'decommissioning' the ITT/EDO arms factory in Brighton and university occupations across the country calling for divestment. So, who are these companies and why are they being targeted by protesters and campaigners? Corporate Watch takes a detailed look. 4 1. ARMS COMPANIES Israel was the world's 6th largest arms importer between 2003 and 2007, accounting for 3.80% of world deliveries, according to the SIPRI Arms Transfers Database. During that period, the US accounted for 94% of the exports of arms to Israel. France, Germany and the UK accounted for a big proportion of the rest. In 2007 alone, EU member states authorised the export of €200m worth of items on the EU Military List to Israel. In 2007, the UK government blocked almost one-third of British military exports to Israel, citing "possible threats to regional stability" and fears that "the equipment might facilitate human rights violations." Despite Israel's continuous war crimes against the Palestinian people, however, the UK has no arms embargo on Israel and licences for the export of military 'goods' continue to be granted in accordance with the criteria set down in the Consolidated EU and National Arms Export Licensing Criteria [1]. -
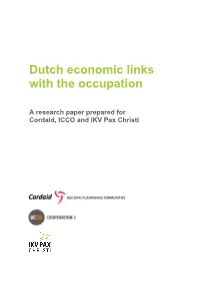
Report Profundo
Dutch economic links with the occupation A research paper prepared for Cordaid, ICCO and IKV Pax Christi Dutch economic links with the occupation A research paper prepared for Cordaid, ICCO and IKV Pax Christi 20 April 2013 Jan Willem van Gelder Barbara Kuepper Ewoud Nijhof Naritaweg 10 1043 BX Amsterdam The Netherlands Tel: +31-20-8208320 E-mail: [email protected] Website: www.profundo.nl Contents Summary .......................................................................................................... i Introduction ......................................................................................................... 1 Chapter 1 Methodology ................................................................................... 2 Chapter 2 The economy of the settlements .................................................. 4 2.1 Development of the settlements ............................................................ 4 2.2 Impact on the economic and humanitarian situation of Palestinians ............................................................................................. 6 2.3 Economic relationship with the European Union ................................. 8 2.4 EU policies with relevance to the settlements ...................................... 9 2.4.1 Human rights ............................................................................................ 9 2.4.2 Labelling of settlement products in the European Union ........................... 9 Chapter 3 Relationships between Israel and the Netherlands .................. -

Palestine's Ongoing Nakba
al majdal DoubleDouble IssueIssue No.No. 39/4039/40 BADIL Resource Center Resource BADIL quarterly magazine of (Autumn(Autumn 20082008 / WinterWinter 2009)2009) BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights jjabaliyaabaliya a wwomanoman wearswears a bellbell carriescarries a light callscalls searchessearches by Suheir Hammad through madness of deir yessin calls for rafah for bread orange peel under nails blue glass under feet gathers children in zeitoun sitting with dead mothers she unearths tunnels and buries sun onto trauma a score and a day rings a bell she is dizzy more than yesterday less than tomorrow a zig zag back dawaiyma back humming suba back shatilla back ramleh back jenin back il khalil back il quds Palestine's all of it all underground in ancestral chests she rings a bell promising something she can’t see faith is that faith is this all over the land under the belly of wind she perfumed the love of a burning sea Ongoing concentrating refugee camp crescent targeted red NNakbaakba a girl’s charred cold face dog eaten body angels rounded into lock down shelled injured shock weapons for advancing armies clearing forests sprayed onto a city o sage tree human skin contact explosion these are our children Double Issue No. 39/40 (Autumn 2008 / Winter 2009) Winter / 2008 (Autumn 39/40 No. Issue Double she chimes through nablus back yaffa backs shot under spotlight phosphorous murdered libeled public relations public quarterly magazine quarterly relation a bell fired in jericho rings through blasted windows a woman Autumn 2008 / Winter 2009 1 carries bones in bags under eyes disbelieving becoming al-Majdal numb dumbed by numbers front and back gaza onto gaza JJaffaaffa 1948....Gaza1948....Gaza 20082008 for gaza am sorry gaza am sorry she sings for the whole powerless world her notes pitch perfect the bell a death toll BADIL takes a rights-based approach to the Palestinian refugee issue through research, advocacy, and support of community al-Majdal is a quarterly magazine of participation in the search for durable solutions. -

Protokoll Zum Vorbereitungsseminar Für Die Beantragung Des DFG-Projektes Vom 4. Bis 7. November 2007 in Jerusalem
ECONOMIC INTEGRATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN ISRAEL AND PALESTINE Protokoll zum Vorbereitungsseminar für die Beantragung des DFG-Projektes vom 4. bis 7. November 2007 in Jerusalem Rico Ihle 21. November 2007 Inhaltsverzeichnis 4. November 20071 5. November 20073 6. November 20075 7. November 2007 12 Zusammenfassung Im Protokoll werden folgende Abkürzungen für die Namen der Beteiligten verwendet: AA Adar Assaf (Agrexco) HA Hillel Adiri (IPCRI/Parc) HG Harald Grethe IF Israel Finkelshtain LG Linde Götz MK Mahmoud El-Jafari RI Rico Ihle SC Stephan von Cramon-Taubadel UK Uli Kleinwechter YK Yael Kachel 4. November 2007 Zusammenfassung Exkursion mit Mahmoud El-Jafari nach Jericho Organisator: Dr. Mahmoud K. El-Jafari Professor of Economics & Director Al-Quds University of Jerusalem Faculty of Graduate Studies, Institute of Business & Economics PO Box 1012 Betlehem, West Bank, Palestine Tel Fax(office) +972-2-279-9497, Tel Fax(home) +972-2-274-4218 E-mail: [email protected] Homepage: http://www.alquds.edu/ Gesprächspartner: Azzam Tubaileh (PhD) Deputy Minister Palestinian National Authority, Ministry of Agriculture PO Box 197 Ramallah, West Bank, Palestine Tel Fax(office) +972-2-240-3320, Tel Fax(home) +972-2-240-3312 E-mail: [email protected] Ibrahim Qtishat Director Palestinian National Authority, Ministry of Agriculture Jericho Agriculture Department Jericho City, West Bank, Palestine Tel +972-2-232-2425/4460, Tel +972-2-232-1280, Mobile +972-59-956-9014 E-mail: [email protected] Ibrahim Id’iq Director of Jericho Palm Association Jericho City, West Bank, Palestine Muhammad Hamidaan Manager of Dates Packing Factory Parc Jericho City, West Bank, Palestine 2 5. -

The Unholy Land
WAKE UP!! WAKE UP!! IT’S YER RIOT-WING... Friday 19th August 2011 Free/Donation Issue 784 and fuel. More than 300,000 protesters from THE U.N.HOLY LAND different backgrounds took to the streets on AS SchNEWS TAKES AN OVERVIEW OF EVENTS IN ISRAEL/PALESTINE the 11th of August, with rallies in Jerusalem, Holon and Haifa, as well as Lod, Hod Ha- The machine-gunning of an Israeli bus been residing there for over a quarter of a sharon and Nazareth. and the subsequent air-raids on Gaza rep- century. 299 of the prisoners have been there This is the largest ever Israeli protest over resent another dangerous turn of the screw over 20 years. Further indignation comes from socio economic issues. It seems Israel is hav- for Palestine. Anxious to rescue themselves the ever decreasing access Palestinian prison- ing its Arab Spring, even if it’s a bit of a late from their own domestic discontents (see ers have to education; 1800 Palestinians were bloomer. On Saturday the 13th demonstrators SchNEWS 781) another border war might ready to take their June examinations but were were encouraged to head out of Jerusalem be just what the Israeli authorities want. prohibited by the prison service. and Tel Aviv to support protests across the While it’s the shocking attack on the Israe- All facets of a prisoner’s life are suppressed. rest of the country. There was a call-out for li bus that’s grabbed the headlines, the slow Many in need of health care are simply denied demos in eighteen different cities. -
Bernhard Freyer Jim Bingen Editors Re-Thinking Organic Food and Farming in a Changing World the International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics
The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics 22 Bernhard Freyer Jim Bingen Editors Re-Thinking Organic Food and Farming in a Changing World The International Library of Environmental, Agricultural and Food Ethics Volume 22 Series Editors Michiel Korthals, Wageningen University, Department of Applied Philosophy, The Netherlands Paul B. Thompson, Michigan State University, Department of Philosophy, USA Editorial Board Andrew Brennan, La Trobe University, Melbourne, Australia Lawrence Busch, Sociology, Michigan State University, USA Andrew Dobson, Keele University, United Kingdom Richard Haybes, University of Florida, USA Darryl Macer, UNESCO Office in Bangkok, Thailand Clare Palmer, Texas A&M University, USA Doris Schroeder, University of Central Lancashire, United Kingdom Avner de-Shalit, Hebrew University of Jerusalem, Israel More information about this series at http://www.springer.com/series/6215 Bernhard Freyer • Jim Bingen Editors Re-Thinking Organic Food and Farming in a Changing World 123 Editors Bernhard Freyer Jim Bingen Department of Sustainable Department of Community Sustainability Agriculture Systems Michigan State University Division of Organic Farming East Lansing, MI, USA University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna, Austria ISSN 1570-3010 ISBN 978-94-017-9189-2 ISBN 978-94-017-9190-8 (eBook) DOI 10.1007/978-94-017-9190-8 Springer Dordrecht Heidelberg New York London Library of Congress Control Number: 2014952291 © Springer Science+Business Media Dordrecht 2015 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. -

Vado Ligure, Carmel!
Welcome to Vado Ligure, Carmel! Testo a cura di Carlo Tombola per TransArms Europe TransArms Europe Research Center for the Logistics of Arms Trade Milano - Chicago 2 «Ogni giorno siamo informati della repressione israeliana contro la popolazione palestinese. E ogni giorno più distratti dal suo significato, come vuole chi la guida».1 Questo documento è indirizzato principalmente a chi non ha un’opinione sul conflitto palestinese, né pensa che possa riguardare personalmente la vita quotidiana di un cittadino vadese, savonese e in fondo neppure italiano. Formare un’opinione pubblica, convincere la gran parte dei cittadini – che di solito non ha un’opinione precisa – ad adottarne una attraverso il formarsi di “partiti” portatori di soluzioni in competizione tra loro: questo è uno dei meccanismi fondamentali della democrazia, che neppure i partiti della “libertà della gente” mettono in discussione. Su una tale “sovranità” dell’uomo qualunque sono stati versati fiumi di inchiostro. Su questo punto però si gioca una partita decisiva, innanzitutto sul piano locale, cioè nei territori direttamente interessati. Quando sono in campo interessi che, per autodefinizione, si pretendono superiori, ecco che si afferma la tendenza ad accantonare le laboriose pratiche democratiche – accusate di essere lente, inconcludenti, di servire solo il “partito del no” – a favore di un decisionismo sostenuto dal parere degli esperti, dei tecnici, dei consulenti, di chi è informato per professione. È il caso delle questioni a cui si attribuiscono caratteri nazionali, generali, comunitari, le questioni dell’economia e del progresso, il ruolo guida dell’Occidente, lo schema delle alleanze di politica internazionale e così via. Il fine trasparente è quello di convincere la maggioranza dis‐informata e dis‐interessata a rimanere tale, neutralizzando la democrazia.