Messe a Otto Voci Borbona, Dudlea, Fortiguerra E Simonetta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
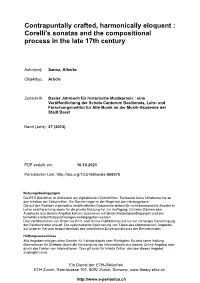
Contrapuntally Crafted, Harmonically Eloquent : Corelli's Sonatas and the Compositional Process in the Late 17Th Century
Contrapuntally crafted, harmonically eloquent : Corelli's sonatas and the compositional process in the late 17th century Autor(en): Sanna, Alberto Objekttyp: Article Zeitschrift: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis : eine Veröffentlichung der Schola Cantorum Basiliensis, Lehr- und Forschungsinstitut für Alte Musik an der Musik-Akademie der Stadt Basel Band (Jahr): 37 (2013) PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-868876 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte -

Résumés Des Articles
RÉSUMÉS DES ARTICLES Arnaldo MORELLI, Music in Rome in the seventeenth century: forty years of historical research, p. 1-13. This contribution sketches an initial review of studies on music in 17th Rome, from the 1970s to the present. It focuses above all on the main themes – sacred music, opera, patronage – that have come to occupy the attention of scholars, with a reflection on the various approaches that have oriented and characterized studies in the course of these four decades. Jean DURON, The circulation of music in the seventeenth century: the disparity of Franco-Italian relations, p. 17-34 The observation of a disparity in seventeenth-century musical exchanges between France and Italy (a disparity in favor of Italian music) leads to a reflec- tion on the causes of this singular phenomenon. The emergence in the Baroque period of highly typical «national» styles partly explains the limited circulation of French music and musicians in the peninsula: the Italians did not appreciate the sophisticated nature of the French works, while French musicians rarely felt the need to travel to Italy. Beyond these questions of taste, other factors contributed to this separation, involving the distinct evolution of musical techniques (which can be analyzed from a linguistic viewpoint) and the different relation that music maintained in these two «nations» not only with dance and theater, but also with the music of the Ancients. Gesa ZUR NIEDEN, O la Francia o la Spagna. The finalities of musical representations between political history and cultural history, p. 35-53 The article analyzes, in an interdisciplinary way, the serenades organized by the French and Spanish faction in Rome around 1700, from the viewpoint of the «new political history» or of the «cultural history of the political sphere». -

2002 II 3.Pdf
Fondazione Guido d’Arezzo Regione Toscana, Provincia di Arezzo Comune di Arezzo, Amici della Musica di Arezzo Centro Studi Guidoniani Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo Provincia di Ferrara, Comune di Codigoro Fondazione Guido d’Arezzo Centro Studi Guidoniani Fondatori Istituto della Fondazione Guido d’Arezzo su Regione Toscana proposta della Giunta esecutiva del Comitato Provincia di Arezzo Nazionale per le Celebrazioni del Millennio Comune di Arezzo della nascita di Guido d’Arezzo, monaco Amici della Musica di Arezzo pomposiano, nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Presidente Francesco Luisi Giunta esecutiva Luigi Lucherini Consiglieri Sindaco di Arezzo, Presidente del Comitato Sabrina Candi, Provincia di Arezzo Nazionale Massimo Conserva, Comune di Arezzo Piero Fabiani, Amici della Musica di Arezzo Enea Pandolfi Silvio Gennai, Amici della Musica di Arezzo Sindaco di Codigoro, Presidente della Giunta Alfredo Grandini, Comune di Arezzo esecutiva Francesco Luisi, Comune di Arezzo Carlo Alberto Neri, Provincia di Arezzo Vincenzo Ceccarelli Mario Rotta, Regione Toscana Presidente della Provincia di Arezzo Collegio dei Revisori Pier Giorgio Dall’Acqua Maria Pilar Mercanti (Presidente), Regione Presidente della Provincia di Ferrara Toscana Barbara Dini, Comune di Arezzo Elio Faralli Piero Ducci, Provincia di Arezzo Presidente di Banca Etruria Direttore artistico Sergio Lenzi Roberto Gabbiani Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara Commissione artistica Giulio Cattin Fabrizio Raffaelli Francesco Luisi -

Francesco Durante Magnificat Pdf
Francesco durante magnificat pdf Continue From ChoralWiki (Redirected from Magnificat (Francesco Durante)) Go to Navigation Go to Search (Posted 2008-08-26) CPDL #17974: Editor: Claude Talle (represented 2008-08-26). Rating information: A4, 8 pages, 218 kB Copyright: CPDL Edition notes: Keyboard abbreviation of original accompaniment. (Published 2008-02-21) CPDL #16215: Editor: Gus Sobel (represented 2008-02-21). Rating information: A4, 34 pages, 602 KB Copyright: CPDL Edition notes: Attributed to Giovanni Battista Pergolesi. The keyboard is short of the original accompaniment. Possible error (s) is defined. See the full description on the discussion page. (Published 2008-08-26) CPDL #17975: Editor: Claude Tallier (represented 2008-08-26). Rating information: A4, 3 pages, 127 kB Copyright: CPDL Edition notes: Keyboard abbreviation of original accompaniment. (Published 2008-08-26) CPDL #17976: Editor: Claude Tallier (represented 2008-08-26). Rating information: A4, 4 pages, 114 KB Copyright: CPDL Edition notes: Keyboard abbreviation of original accompaniment. (Published 2008-08-26) CPDL #17977: Editor: Claude Tallier (represented 2008-08-26). Rating information: A4, 2 pages, 82 kB Copyright: CPDL Edition notes: Keyboard abbreviation of original accompaniment. (Published 2008-08-26) CPDL #17978: Editor: Claude Tallier (represented 2008-08-26). Rating information: A4, 3 pages, 91 kB Copyright: CPDL Edition notes: Keyboard abbreviation of original accompaniment. (Published 2008-08- 26) CPDL #17979: Editor: Claude Tallier (represented 2008-08-26). Rating information: A4, 6 pages, 195 kB Copyright: CPDL Edition notes: Keyboard abbreviation of original accompaniment. Title: Magnificat Composer: Francesco Durante, often attrib. His Apprentice Giovanni Battista Pergolesi Number of Voices: 4vv Voicing: SATB genre: Sacred, Motet Language: Latin Instruments: String Ensemble: 2 Violins, Viola and Continuo First Published: Description: This is a better known four-room version of Durante's Magnificat. -

GIULIA GALASSO a Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of Birmingham City University for the Degree Of
THE MASS COLLECTION OCTO MISSAE (1663) BY FRANCESCO FOGGIA (1603-1688): AN ANALYTICAL STUDY AND CRITICAL EDITION GIULIA GALASSO A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Birmingham City University for the degree of Doctor of Philosophy August 2017 Royal Birmingham Conservatoire, The Faculty of Arts, Design and Media, Birmingham City University ABSTRACT Francesco Foggia (1603-1688) was one of the most prominent maestri di cappella of seventeenth-century Rome and an important mass composer. Historically, he has been regarded as one of the last heirs of Palestrina, largely due to the writings of Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743) and Giovanni Battista Martini (1706-1784). More recently, scholars have reassessed his style in his motets, psalms and oratorios. However, his mass style has received little rigorous scholarly attention. This is partly because of the scarcity of critical editions of his works. The present study presents critical editions of five of the masses from his Octo missae (Rome: Giacomo Fei, 1663). In conjunction with the three masses included in Stephen R. Miller‟s recent edition (2017), the entire volume is now available in full score. This enables an informed reassessment of Foggia‟s mass style. The present study analyses his use of features, such as time signatures, full choir and stile concertato, textures, thematic treatment and borrowing procedures. It compares Foggia‟s mass style with those of his predecessors, mainly Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525-1594), Ruggero Giovannelli (c.1560-1625), near predecessor Gregorio Allegri (1582-1652) and contemporaries, Bonifatio Gratiani (1604/5-1664), Orazio Benevoli (1605-1672). -

Bernardo Pasquini As a Counterpoint Teacher a Critical Introduction to I Saggi Di Contrappunto (1695)
Philomusica on-line 12 (2012) Bernardo Pasquini as a Counterpoint Teacher A Critical Introduction to I Saggi di Contrappunto (1695) Armando Carideo Istituto dell’Organo Storico Italiano, Roma [email protected] § Solo pochi anni separano i Saggi di § There are only a few years between Contrappunto (1695), le Sonate per the Saggi di Contrappunto (1695,) uno o due cembali con il basso cifrato the Sonate per uno o due cembali con (1703-04) e i Versetti con il solo basso il basso cifrato ( 1703-04,) and the cifrato (1708). Versetti con il solo basso cifrato Ciò che colpisce nei Saggi di Contrap- (1708.) punto, se paragonati ad altri trattati del What strikes in the Saggi di tempo, è la mancanza di spiegazioni Contrappunto, in comparison with teoriche. the other treatises of the time, is the Tutto il trattato si fonda sulla modalità, lack of theoretical explanations. nonostante il nascente gusto per la All the treaty is based on modality, tonalità. Questo nuovo corso era notwithstanding the rising taste for comune a Roma nei lavori di Arcangelo tonality. This new way was common Corelli e in molte altre composizioni also in Rome, in the works of per tastiera dello stesso Pasquini, come Arcangelo Corelli and in many si può constatare nel manoscritto keyboard compositions by Pasquini autografo Landsberg 215, specialmente himself, as it can be seen in the nelle arie, suite di danze e in qualche autograph manuscript Landsberg variazione. Pasquini, così come 215, especially in the arias, dance Giuseppe Ottavio Pitoni e più tardi suites and in some variations. -

Download (2810Kb)
University of Warwick institutional repository: http://go.warwick.ac.uk/wrap A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick http://go.warwick.ac.uk/wrap/69994 This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. Dramatic Figures in the Venetian Republic: Performance, Patronage, and Puppets by Melanie Zefferino Submitted in part fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy in the History of Art at the University of Warwick September 2014 This dissertation may be photocopied CONTENTS Acknowledgements i Abstract iii List of Tables iv List of Illustrations v Introduction 1 Definitions and Taxonomy 2 Scope of the Research, and Historical and Critical Approaches 4 Methodology, Literature Review, and Sources 7 Dissertation Structure 16 PART 1 – HIERATIC FIGURES AND EARLY INVENTIONS 19 I Dramatic Figures of the Middle Ages 20 The Influence from French Culture 22 Venice’s Porta da Mar: a Gate for Liturgical and Feast-day Drama 25 ‘Animated’ Sculptures for the Passio, Depositio, and Entombment of Christ 37 Marys, Marione, and Marionettes 49 II Puppets, Automata, and Theatres of the World 61 The Momarie 62 Puppetry and the Commedia dell’Arte 68 Ephemeral Theatres on the Ground and on Water 77 III Theatrical Feasts and Figures: from the Catajo Palace to Villa Contarini 84 Il Solimano, 1634 85 -

Bianca Maria Antolini Teresa M. Gialdroni Licia Sirch © Società Editrice Di Musicologia 2013
Musica vocale da camera [2] Comitato scientifico: Bianca Maria Antolini Teresa M. Gialdroni Licia Sirch © Società Editrice di Musicologia 2013 Sede legale: Lungotevere Portuense 150 00153 Roma C.F. 97701420586 [email protected] www.sedm.it Traduzione in inglese: Marcello Piras Progetto grafico: Venti caratteruzzi Impaginazione: Raffaella Barbetti Impaginazione della musica: Giacomo Sciommeri ISMN: 979-0-705061-10-9 Questa edizione è stata realizzata in collaborazione con il progetto «Clori. Archivio della cantata italiana» La presente pubblicazione è sotto copyright e tutti i diritti di utilizzo rimangono dell’editore. L’acquirente non è autorizzato a duplicare, condividere pubblicamente e riprodurre le pubblicazioni, se non per uso privato o per le esigenze strettamente connesse con le esecuzioni musicali. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge. This publication is copyright. All rights reserved. The buyer is not authorized to duplicate, share, or disseminate it. Single duplicates may only be made for personal use or concert performance. Copyright infringement will be prosecuted. Società Editrice di Musicologia Giovanni Lorenzo Lulier Cantate da camera - La Didone - Là dove a Pafo in seno - Ferma alato pensier - Amor, di che tu vuoi a cura di Chiara Pelliccia Società Editrice di Musicologia Indice Table of contents VII Introduzione 17 Ferma alato pensier, per Soprano, (violoncello), basso continuo VII Nota biografica 17 N. 1 Arioso: Ferma alato pensier, ferma il tuo volo VIII Le cantate da camera 20 N. 2 Aria: Si ribella dall’alma il pensiero IX La Didone 22 N. 3 Recitativo: Vanne dunque o pensier IX Là dove a Pafo in seno 23 N. 4 Aria: Il bel che splende X Ferma alato pensier 24 N. -

Texto Completo
Repertorio italiano en la Catedral de Pamplona: las obras de Francesco Grassi (†1703) y su recepción en los siglos XVIII y XIX MARÍA GEMBERO USTÁRROZ* INTRODUCCIÓN sta aportación se propone realizar un primer estudio de las obras de E Francesco Grassi (†1703) conservadas en la Catedral de Pamplona, si- tuándolas en el contexto de la amplia producción de este compositor italia- no, diseminada en al menos treinta y un archivos y bibliotecas europeos. Hay evidencias de que las obras de Grassi fueron interpretadas en la catedral pam- plonesa junto a composiciones de maestros locales y de otras instituciones es- pañolas al menos desde los años 30 del siglo XVIII hasta bien entrado el XIX1. El presente trabajo consta de dos secciones. En la primera presento una recopilación de los escasos datos conocidos sobre Francesco Grassi y su obra, dispersos en catálogos y publicaciones muy diversas, algunos de difícil loca- lización en España2. La segunda sección incluye la descripción y estudio de * Profesora Titular de la Universidad de Granada. 1 La primera noticia sobre las obras de Francesco Grassi en la catedral pamplonesa fue dada a co- nocer en GEMBERO USTÁRROZ, María, La música en la Catedral de Pamplona, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, I, p. 249 y II, pp. 334, 336 y 337. 2 La consulta de las obras de Francesco Grassi incluidas en la base de datos del Répertoire Internatio- nale des Sources Musicales (RISM) me fue posible gracias a la amabilidad de Francisco Javier Legasa, doc- torando de The Graduate Center, City University of New York. Quiero también expresar mi agradecimiento a Emilio Ros Fábregas que en 1996, siendo Profesor de Boston University, me facilitó copias de diversos ca- tálogos y otras referencias bibliográficas con información sobre Francesco Grassi no disponibles en España. -

Abstracts of Round Tables
Abstracts of round tables (as far as not listed as personal ones) Thursday 10-07, 9 am Christoph Graupner and the Cantata at the Court of Hesse-Darmstadt see Erdmann, Heyerick, Pegah, Kramer, Sorg Thursday 10-07, 2 pm Bach’s Thomaner – Results of a Research Project (Bach-Archiv Leipzig) see Bärwald, Koska, Maul Friday 11-07, 9 am From Philip V and Archduke Charles of Habsburg to the Borbonic Consolidation: Instrumental Music in the Iberian Peninsula and Areas of Mutual Influence (the Spanish Indies, Italy and Vienna) To the Spanish crown the War of Succession marked a change in musical paradigm, with the consolidation, following the introduction of a new dynasty, the growing and best supported reception of music and musicians from other European countries. The Peace of Utrecht meant in this sense a new international order, not only from a political point of view, but most particularly in regard to cultural transfers. The study of the historical-musical documentary heritage, preserved today in areas of the Iberian and Latin American context (often called panhispanic), increasingly throws new light on such exchanges and practices of this musical and cultural environment in which some prominent figures such as Domenico Scarlatti and José de Nebra are considered the bearers of a much broader and extended reality. see also Ezquerro Estebán, González Marín, Yáñez Navarro, Carvalho Mendes Dos Santos Saturday 12-07, 9.15 am Transalpine Geminiani Chair: Christopher Hogwood Participants: Enrico Careri, Peter Holman, Mark Kroll, Peter Walls In the introduction to Geminiani Studies (Bologna: Ut Orpheus, 2013), Christopher Hogwood noted: “Dilemmas and disagreements are also beginning to appear – a sign of health in research and a symptom of ‘cognitive discord’ to be encouraged. -

Rome Has Long Been Regarded As One of the Most Significant Cultural Centers of Western Civilization, and This Was No Less True in the 17Th and 18Th Centuries
Rome has long been regarded as one of the most significant cultural centers of Western Civilization, and this was no less true in the 17th and 18th centuries. It was particularly true for sacred music. As the center of the Catholic Church, Rome attracted the best and most celebrated musicians and composers of the day. Today there are over 800 churches in Rome, most of which are Catholic. The Choir of the Sistine Chapel, the Pope’s private musical establishment, which was founded in the 6th century and re-organized in 1441, was widely considered the very best in Europe; and the Capella Giulia, also founded in the 6th century and re-organized in 1460, served as a training ground for the Sistine Chapel Choir while providing music for St. Peter’s Basilica. In addition, music was performed in the private salons of high church officials in Rome, many of whom were significant patrons of music. Today’s program offers a cross-section of the kinds of music that would have been heard in Rome in the early 18th century. Although the first two composers are from the previous century, their music remained in the active repertory of choirs all through Europe. The Sistine Chapel Choir, in the 18th century, comprised of twenty-four men, including castrati to sing the soprano parts. The alto parts were sung by high tenors. A new member of this choir would have to be elected to the ensemble by the existing members of the choir, although the influence of the Pope or some other high church official would certainly have great weight in their being chosen. -

Fall 2017 Tuesday, October 31 6.00Pm Villa I Tatti
DEL MAR DEL MUNDO Francesco Durante and the Neapolitan School in the Hispanic Colonies of America Fall 2017 Tuesday, October 31 6.00pm Villa I Tatti Performers: Alicia Amo soprano Incipit Ensemble Ignacio Ramal violin David Torres violin Alaia Ferrán viola Hyngun Cho violincello Dani Espasa clavicembalo This concert is made possible by a generous endowment gift from F. Gordon and Elizabeth Morrill for the promotion of Music and Musicology at Villa I Tatti, in Honor of Bernard Berenson We express our gratitude to Pedro Memelsdorff (VIT'04, ESMUC Barcelona, Fondazione Giorgio Cini Venice, Université de Tours) for his assistance in planning this concert Juan Rodríguez Juárez, De mulato y mestiza, produce mulato, es torna atrás (detail), ca. 1715, Private collection Program Francesco Durante (1684-1755) Concerto per quartetto in mi minore 2 José de Torres (ca. 1670-1738) Cercadme flores, Cantada para tiple y BC Salve a Nuestra Señora, Cantada para tiple y BC 2 Francesco Durante Studi e divertimenti per cembalo Sonata per violino e cembalo 2 José de Nebra (1702-1768) Entre cándidos, bellos accidentes, Cantada para tiple y BC 2 Francesco Durante Concerto per quartetto in sol minore Partimento per cembalo 2 José de Nebra Selva florida, Rec. y aria para tiple, 2 violines y BC (da: Viento es la dicha de Amor) Gozaba el pecho mio, Rec. y aria para tiple, 2 violines, viola y BC (da: Iphigenia en Tracia) DEL MAR DEL MUNDO FRANCESCO DURANTE AND THE NEAPOLITAN SCHOOL IN THE HISPANIC COLONIES OF AMERICA In 1705 the young Francesco Durante concluded his preliminary violin and composition studies in Naples.