Scarica Scheda Divulgativa Razze Avicole
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Overview of Native Chicken Breeds in Italy: Conservation Status and Rearing Systems in Use
animals Article Overview of Native Chicken Breeds in Italy: Conservation Status and Rearing Systems in Use Annelisse Castillo 1 , Marta Gariglio 1, Alessandro Franzoni 1, Dominga Soglia 1 , Stefano Sartore 1 , Arianna Buccioni 2 , Federica Mannelli 2 , Martino Cassandro 3 , Filippo Cendron 3 , Cesare Castellini 4 , Alice Cartoni Mancinelli 4, Nicolaia Iaffaldano 5 , Michele Di Iorio 5 , Margherita Marzoni 6 , Sonia Salvucci 6, Silvia Cerolini 7 , Luisa Zaniboni 7 and Achille Schiavone 1,* 1 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino, Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco, Italy; [email protected] (A.C.); [email protected] (M.G.); [email protected] (A.F.); [email protected] (D.S.); [email protected] (S.S.) 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università di Firenze, Via delle Cascine 5, 50144 Firenze, Italy; arianna.buccioni@unifi.it (A.B.); federica.mannelli@unifi.it (F.M.) 3 Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and Environment (DAFNAE), University of Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro, Italy; [email protected] (M.C.); fi[email protected] (F.C.) 4 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121 Perugia, Italy; [email protected] (C.C.); [email protected] (A.C.M.) 5 Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del Molise, Via Francesco De Sanctis, 86100 Campobasso, -

Physical Parameters and Fatty Acids Profiles in Milanino
animals Article Physical Parameters and Fatty Acids Profiles in Milanino, Mericanel Della Brianza, Valdarnese Bianca and Commercial Hybrids (Gallus Gallus Domesticus) Table Eggs Stefano Paolo Marelli 1,* , Luisa Zaniboni 1 , Manuela Madeddu 2, Ahmad Abdel Sayed 1, Maria Giuseppina Strillacci 1 , Maria Grazia Mangiagalli 1 and Silvia Cerolini 1 1 Department of Veterinary Medicine, University of Milan, via dell’Università 6, 26900 Lodi LO, Italy; [email protected] (L.Z.); [email protected] (A.A.S.); [email protected] (M.G.S.); [email protected] (M.G.M.); [email protected] (S.C.) 2 Freelance Veterinarian, 21047 Saronno-Va, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 28 July 2020; Accepted: 29 August 2020; Published: 31 August 2020 Simple Summary: Conservation of traditional poultry breeds is closely linked to product valorization considering the renewed interest in local poultry breeds production and consumers’ orientation towards food items considered healthier and safer. The aim of the present research is to investigate the differences in egg physical parameters and fatty acid profile of three traditional chicken breeds (Mericanel della Brianza, Milanino and Valdarnese Bianca) and two commercial hybrids using marked-procured eggs. We evaluated the effects of the breeds and of the genetic origin (traditional breed or hybrid strain) on egg physical and chemical parameters, furthermore we analyzed the most influencing parameters and their effects on egg groups differentiation via Principal Component Analysis (PCA). Eggs produced by traditional breeds differentiate from eggs produced by commercial hybrids in physical and fatty acids parameters. The nutritional value of eggs obtained from traditional breeds has been demonstrated to be higher considering the yolk content, the Polyunsatured Fatty Acids - PUFA fraction, the n6/n3 ratio and the atherogenic and thrombogenic indexes. -

Conservation and Valorisation of Italian Chicken Breeds
Scuola Di Dottorato in Sanità e Produzioni Animali: Scienza, Tecnologia e Biotecnologie Dottorato di Ricerca in Produzioni Animali (Curriculum: Zoocolture) Conservation and valorisation of Italian chicken breeds Tesi di: Dott. Fabio Mosca Docente guida: Prof.ssa Silvia Cerolini 2 To Marta and Baby 3 4 ABSTRACT My research activities have been carried out within the CoVAL Project, a research program which examines the conservation of four Italian avian breeds (two chicken and two turkey breeds). The research has planned the development of several activities aiming the acquisition of a complete characterization of the breeds and the organization of a conservation program according FAO guidelines. Two conservation strategies have been considered: the primary in situ – that enables the conservation of the birds in their original background- and the complementary ex situ in vitro – with the aim to implement a semen cryobank. The project, funded by Regione Lombardia, lasted forty-two months, from December 2011 to June 2015. The results reported in this thesis only concern the two chicken breeds, in particular Milanino breed, that presents high meat- production potentialities. Data have been systematically gathered studying various generations of birds. The phenotypic characterization has highlighted the reproductive performance (fertility, hatchability) typical of each breed. Furthermore, variability of these traits has been studied depending on factors such as age, family, weight and storage period of eggs: prospects of selections and improvement have been pointed out. The results of zootechnical trials have provided a procedural guideline for outdoor extensive farming system specific for the chicken breeds. The guideline provides information about rearing density and dietary protein level during the growing period. -

Scarica La Presentazione in Pdf (0.5Mb
51° Convegno Nazionale Associazione Scientifica di Avicoltura - Sezione Italiana World’s Poultry Science Association Forlì, 16 aprile 2015 Attività di ricerca relative alla conservazione della biodiversità avicola in Italia Silvia Cerolini Dipartimento di Sanità, Produzione Animale e Sicurezza Alimentare Università degli Studi di Milano La conservazione della biodiversità animale Strategia in situ: - censimento sul territorio - caratterizzazione delle razze necessaria alla conoscenza delle stesse - gestione dei riproduttori (nuclei di conservazione) - gestione della fase di crescita - valorizzazione in sistemi produttivi Strategia ex situ: - criobanche del seme - criobanche di tessuti/DNA Riferimento: FAO Animal Production and Health Guidelines Le razze italiane di pollo Razza Regione di origine Ancona Marche Bionda Pemontese Piemonte Bianca di Saluzzo Piemonte Ermellinata di Rovigo Veneto Livorno Toscana Mericanel della Brianza Lombardia Millefiori Lonigo Veneto Milanino Lombardia Modenese Emilia Romagna Padovana Veneto 30% razze totali (n. 53) censite da Pepoi Veneto Zanon e Sabbioni (2001) Polverara Veneto Robusta maculata Veneto Robusta lionata Veneto Siciliana Sicilia Valdarnese bianca Toscana Le razze italiane di altre specie avicole Razze di tacchino Regione di origine Razze di anatra Regione di origine Brianzolo Lombardia Germanata veneta Veneto Comune bronzato Veneto Mignon Veneto Razze totali censite 9 (Zanon e Sabbioni, 2001) Ermellinato Rovigo Veneto Nero di Italia Lombardia TacchinoRazze totali di censite PR e 12PC (Zanon -

Proceedings EPGS2013
Proceedings of the 8th European Symposium on Poultry Genetics World’s Poultry Science Association (WPSA) Working Group 3 “Breeding and Genetics” 25-27 September 2013 San Servolo Conference Centre Venice, ITALY www.epgs2013.com Organising Committee Martino Cassandro Chairman and Member of Working Group 3 Steffen Weigend Chairman of Working Group 3 Achille Franchini President of the Italian Branch of WPSA Massimiliano Petracci Secretary of the Italian Branch of WPSA Maurizio Borin Head of the Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and Environment – University of Padova Massimo De Marchi, Mara Battagin, Mauro Penasa, Alba Sturaro, Valentina Toffanin, Paolo Gottardo Members of the Organising Committee Scientific Committee Daniel Guemene Institut National de la Recherche Agronomique, Unité de Recherche Avicole, UR83, Nouzilly, France. Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français SYSAAF, Nouzilly, France. David Cavero Lohmann Tierzucht GmbH, Cuxhaven, Germany Martino Cassandro Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and Environment - University of Padova, Italy Michele Tixier-Boichard Institut National de la Recherche Agronomique, UMR1313 GABI, Domaine de Vilvert, Jouy-en-Josas cedex, France Paul Hocking The Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies, University of Edinburgh, UK Pieter van As Hendrix Genetics Research, Technology and Services B.V., AC Boxmeer, the Netherlands Steffen Weigend Institute of Farm Animal Genetics, Friedrich-Loeffler-Institut, Neustadt-Mariensee, Germany Yves Jego Hubbard, Le Foeil, Quintin, France Welcome address Italian Branch of WPSA The Italian Branch of the World’s Poultry Science Association is glad to welcome the participants to the 8th European Symposium on Poultry Genetics. Genetic research is in large part responsible for the great success achieved worldwide by the poultry industry during the last decades, of course, together with the cooperation of the 10 disciplines involved in the other Working Groups of the European Federation. -

Genome-Wide SNP Analysis Reveals the Population Structure and the Conservation Status of 23 Italian Chicken Breeds
animals Article Genome-Wide SNP Analysis Reveals the Population Structure and the Conservation Status of 23 Italian Chicken Breeds Filippo Cendron 1 , Francesco Perini 2, Salvatore Mastrangelo 3 , Marco Tolone 3, Andrea Criscione 4, Salvatore Bordonaro 4 , Nicolaia Iaffaldano 5 , Cesare Castellini 2 , Margherita Marzoni 6, Arianna Buccioni 7 , Dominga Soglia 8 , Achille Schiavone 8 , Silvia Cerolini 9, Emiliano Lasagna 2,* and Martino Cassandro 1 1 Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and Environment, University of Padova, Viale dell’Università, 16, 35020 Legnaro, Italy; fi[email protected] (F.C.); [email protected] (M.C.) 2 Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, University of Perugia, Borgo XX Giugno, 74, 06121 Perugia, Italy; [email protected] (F.P.); [email protected] (C.C.) 3 Department of Agricultural, Food and Forest sciences, University of Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 4, 90128 Palermo, Italy; [email protected] (S.M.); [email protected] (M.T.) 4 Department of Agronomy, Food, and Environment, University of Catania, Via Valdisavoia, 5, 95100 Catania, Italy; [email protected] (A.C.); [email protected] (S.B.) 5 Department of Agricultural, Environment and Food, University of Molise, Via De Sanctis s/n, 86100 Campobasso, Italy; [email protected] 6 Department of Veterinary Science, University of Pisa, Viale delle Piagge 2, 56124 Pisa, Italy; [email protected] 7 Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry, -
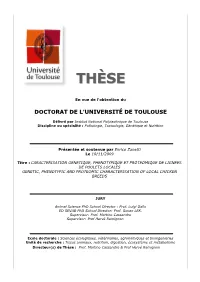
Genetic, Phenotypic and Proteomic Characterisation of Local Chicken Breeds
TTHHÈÈSSEE En vue de l'obtention du DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par Institut National Polytechnique de Toulouse Discipline ou spécialité : Pathologie, Toxicologie, Génétique et Nutrition Présentée et soutenue par Enrico Zanetti Le 10/11/2009 Titre : CARACTERISATION GENETIQUE, PHENOTYPIQUE ET PROTEOMIQUE DE LIGNEES DE POULETS LOCALES GENETIC, PHENOTYPIC AND PROTEOMIC CHARACTERISATION OF LOCAL CHICKEN BREEDS JURY Animal Science PhD School Director : Prof. Luigi Gallo ED SEVAB PhD School Director: Prof. Sovan LEK. Supervisor: Prof. Martino Cassandro Supervisor: Prof Hervé Remignon Ecole doctorale : Sciences écologiques, vétérinaires, agronomiques et bioingenieries Unité de recherche : Tissus animaux, nutrition, digestion, écosystème et métabolisme Directeur(s) de Thèse : Prof. Martino Cassandro & Prof Hervé Remignon UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Animali SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ANIMALI INDIRIZZO: GENETICA, BIODIVERSITÀ, BIOSTATISTICA E BIOTECNOLOGIE CICLO XXI GENETIC, PHENOTYPIC AND PROTEOMIC CHARACTERISATION OF LOCAL CHICKEN BREEDS Animal Science PhD School Director : Prof. Luigi Gallo ED SEVAB PhD School Director: Prof. Sovan LEK. Supervisor: Prof. Martino Cassandro Supervisor: Prof Hervé Remignon PhD Student : Enrico Zanetti This research was financed by Veneto Agricoltura 2 3 CONTENTS Summary 3 Riassunto 5 Résumé 7 General Introduction 9 1. Animal genetic resources 9 1.1 Risk status classification 11 1.2 Status of livestock genetic resources 13 2. Avian species and chicken breeds 16 2.1.1 European breeds 17 2.1.2 North American breeds 17 2.1.3 Commercial strains 17 2.1.4 Breeds from other areas 17 2.2 Status of avian genetic resources 18 3. -
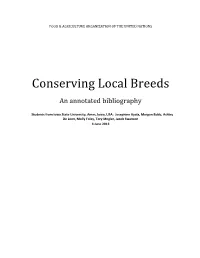
Conserving Local Breeds an Annotated Bibliography
FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Conserving Local Breeds An annotated bibliography Students from Iowa State University, Ames, Iowa, USA: Josephine Ayala, Morgan Bobb, Ashley De Leon, Molly Foley, Tory Mogler, Jacob Swanson 4 June 2013 Introduction This annotated bibliography is the product of a research team of six undergraduate students from Iowa State University, Ames, Iowa, USA. Each of the six students have primary majors within the College of Agriculture and Life Sciences and were selected for a class, The Dean’s Global Food and Agriculture Leadership Program, in the spring of 2013 to participate as part of a research team for the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The general outline of the project, including deliverables, was established via a conference call with the clients in late March. The team and their professors focused their last month of class on preparation specific to the project. Upon arrival in Rome in May, 2013, the objectives of the project were refined with FAO leadership from the Animal Production and Health Division (AGA). The growing threat of extinction that local breeds of livestock face is a primary concern to AGA1. These breeds provide value to producers and consumers alike, but are being replaced by commercialized breeds at an alarming rate. This is of concern because local breeds provide economic value as well as social and environmental value, including their ability to help sustain rural livelihoods—especially for peoples in low-income countries. Local breeds also help address issues from biodiversity and climate changes, to the empowerment of women. -

Acta Fytotechnica Et Zootechnica :: Template
Acta fytotechn zootechn, 23, 2020(Monothematic Issue :: Future Perspectives in Animal Production), 137-143 http://www.acta.fapz.uniag.sk https://doi.org/10.15414/afz.2020.23.mi-fpap.137-143 Original Paper Submitted 2020-07-02 | Accepted 2020-09-03 | Available 2020-12-01 Morphological and genetic characterization of 13 Italian local chicken breeds Francesco Perini1∗, Filippo Cendron2, Emiliano Lasagna1, Martino Cassandro2 1 University of Perugia, Department of Agricultural, Food and Environmental Science, Italy 2 University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment, Italy Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License According to census accomplished in 2001, only 9% of Italian poultry breeds are still widespread. This project aims to describe morphological variability and genetic background among 13 Italian autochthonous chicken breeds, 10 from Northern Italy and 3 from Central Italy. An updated biometrical measurement protocol was established starting from phenotypic characterization guidelines released by FAO. Six traits were registered on each animal: live body weight (LBW), body length (BL), shank length (SL), shank width (SW), breast width (BW), and wingspan (WS). Moreover, all breeds were genotyped using the Affymetrix 600 K Chicken SNP Array, in order to evaluate genetic variability and population structure. Means of BL and BW showed low variability among breeds, with the lowest value in Pepoi (BL = 32.29 ± 1.57 cm and BW = 28.92 ± 1.93 cm), and maximum in Robusta Lionata for BL (46.79 ± 1.66 cm) and in Robusta Maculata for BW (42.33 ± 3.60 cm). On the contrary, average LBW varied notably among breeds, with the highest value for Robusta Maculata (♂ 4,221.7 ± 450.6 g; ♀ 2,831.7 ± 253.2 g) and the lowest values for Modenese males (1,695.0 ± 128.1 g) and Pepoi females (1,293.3 ± 219.2 g). -
Di Consanguineità FHOM
Nome Razza Matricola Coefficiente di Inbreeding (FHOM) Ancona A11 0.1665 Ancona A12 0.2278 Ancona A13 0.2521 Ancona A16 0.531 Ancona A17 0.1883 Ancona A20 0.1956 Ancona A10 0.3072 Ancona A9 0.225 Ancona A360 0.3447 Ancona A362 0.3088 Ancona A563 0.4294 Ancona A600 0.1955 Ancona A818 0.233 Ancona A843 0.4311 Ancona H479 0.2132 Ancona I16 0.2004 Ancona K519 0.4244 Ancona L557 0.2757 Ancona L587 0.225 Ancona L591 0.1947 Ancona M676 0.4387 Ancona M690 0.3047 Ancona A21 0.3141 Ancona S233 0.201 Bianca di Saluzzo A331 0.07572 Bianca di Saluzzo V161 0.07385 Bianca di Saluzzo 159 0.001673 Bianca di Saluzzo 330B 0.07959 Bianca di Saluzzo 388R 0.1176 Bianca di Saluzzo 389A 0.09801 Bianca di Saluzzo 479 0.08323 Bianca di Saluzzo 519R 0.1295 Bianca di Saluzzo G420 0.08695 Bianca di Saluzzo G498 0.07334 Bianca di Saluzzo M332 0.08737 Bianca di Saluzzo P186 0.07146 Bianca di Saluzzo R595 0.1186 Bianca di Saluzzo V107 0.1989 Bianca di Saluzzo V114 0.05115 Bianca di Saluzzo V126 0.02779 Bianca di Saluzzo V141 -0.001607 Bianca di Saluzzo V143 -0.0139 Bianca di Saluzzo V154 0.2179 Bianca di Saluzzo V188 0.07512 Bianca di Saluzzo V191 0.003887 Bianca di Saluzzo V198 -0.00148 Bianca di Saluzzo M321 0.1383 Bianca di Saluzzo V128 0.03527 Bionda Piemontese 462 0.09636 Bionda Piemontese B352 0.09389 Bionda Piemontese M360 0.1335 Bionda Piemontese V200 0.1567 Bionda Piemontese V52 0.1028 Bionda Piemontese 129V 0.1453 Bionda Piemontese 440 0.1111 Bionda Piemontese 581R 0.08754 Bionda Piemontese A362 0.1025 Bionda Piemontese A596 0.1018 Bionda Piemontese M400 0.1477 -

Araucana F.I.A.V
A IAN ASSO AL C IT IA E Z N IO O N I I Z A A V R I C E O D L E E Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. - DL 353/03 (L46/04) art. 1 comma 2 - DCB Ferrara F Tassa riscossa - Taxe percue Aut. N. 1623/2002 del 30/01/2002 del Trib. di MO Anno VI - N. 23 - Luglio-Settembre 2007 VICOLTUR AVICULTUR A ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI AVICOLE O.N.L.U.S. TACCHINO CROLWITZ Anno VI - N. 23 0,1 Lug. - Sett. 2007 Trimestrale di Cultura, Selezione e Salvaguardia Avicola UOVA BLU Organo Ufficiale di ARAUCANA F.I.A.V. O.N.L.U.S. Federazione Italiana Associazioni Avicole Registrato al Tribunale di Modena n. 1623/2002 del 30.01.2002 ARAUCANA EDITRICE P.zza Drago, 7 F.I.A.V.-O.N.L.U.S. 30017 Lido di Jesolo (VE) www.fiav.info Presidente: Paolo Ongaretto Via Marco Polo, 56 1,0 30020 Eraclea (VE) Tel./Fax 0421.231695 E-mail:[email protected] Direttore: Alberto Setti MALTESE Via dell’Artigianato, 213 41038 San Felice sul Panaro (MO) Comitato di Redazione: Secondo Rore Lazzaro E-mail: [email protected] Fabrizio Focardi E-mail: [email protected] Marco Galeazzi E-mail: [email protected] Stampa: Sogari Arti Grafiche S.r.l. Via dell’Artigianato, 213 41038 San Felice sul Panaro (MO) Tel. 0535.85425 E-mail: [email protected] Hanno collaborato alla 1,0 0,1 realizzazione di questo numero: Stefano Bergamo On. Gianpaolo Dozzo Fabrizio Focardi Paolo Ongaretto 1,0 ITALIANA Vanni Tomasella Sabina Tonetto I collaboratori assumono piena responsabilità delle affermazioni contenute nei loro scritti. -

Universit`A Degli Studi Di Padova Genetic
UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA, ANIMALI, ALIMENTI, RISORSE NATURALI E AMBIENTE (DAFNAE) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI TESI DI LAUREA MAGISTRALE GENETIC CHARACTERIZATION AND POPULATION STRUCTURE OF LOCAL POLISH AND ITALIAN CHICKEN BREEDS Relatore: Prof. MARTINO CASSANDRO Correlatore: Prof. TOMASZ SZWACZKOWSKI Dott. FABIO MARETTO Laureanda: GIULIA ROSSI Matricola: 1036157 ANNO ACCADEMICO 2012-2013 2 Contents Abstract iii Introduction v Origin and domestication of poultry . .v The poultry sector in Europe . vi Biodiversity . vii Agro-biodiversity . .x Causes of biodoversity loss . xi Animal genetic resources . xii The importance of animal genetic resources protection . xiii The selection criteria underpinning the conservation of animal genetic variability xv Conservation methods . xvi Population genetics methods . xix Molecular Markers . xxi 1 Aim 1 2 Materials and methods 3 2.1 History and characteristics of involved breeds . .3 i ii CONTENTS 2.1.1 Breeds kept in Poland . .3 2.1.2 Italian (Venetian) chicken breeds . .7 2.2 F-statistics: genetic differentiation between populations . 11 2.3 Molecular analysis . 13 2.3.1 Genomic DNA isolation . 13 2.3.2 Genomic DNA sizing . 13 2.3.3 Microsatellites amplification . 14 2.3.4 Microsatellite Genotyping . 17 2.4 Statistical Analysis . 17 3 Results and discussion 19 3.1 Markers polymorphism . 19 3.2 Inter - breed variability . 22 3.3 Population Structure . 27 4 Conclusions 31 Acknowledgements 33 Bibliography 33 Abstract The aim of this study was to compare the genetic variation and population structure of five local chicken breeds reared in Poland with six Italian local chicken breeds undergoing in situ conservation program.