Quinto Programma Nazionale Di Ricerca Sull'aids PROGRESS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

HIV-1 Env Associates with HLA-C Free-Chains at the Cell Membrane
www.nature.com/scientificreports OPEN HIV-1 Env associates with HLA-C free-chains at the cell membrane modulating viral infectivity Received: 11 July 2016 Michela Serena1, Francesca Parolini1, Priscilla Biswas2, Francesca Sironi2, Accepted: 30 November 2016 Almudena Blanco Miranda1, Elisa Zoratti3, Maria Teresa Scupoli3, Serena Ziglio1,4, Published: 04 January 2017 Agustin Valenzuela-Fernandez4, Davide Gibellini5, Maria Grazia Romanelli1, Antonio Siccardi2, Mauro Malnati2, Alberto Beretta2 & Donato Zipeto1 HLA-C has been demonstrated to associate with HIV-1 envelope glycoprotein (Env). Virions lacking HLA-C have reduced infectivity and increased susceptibility to neutralizing antibodies. Like all others MHC-I molecules, HLA-C requires β2-microglobulin (β2m) for appropriate folding and expression on the cell membrane but this association is weaker, thus generating HLA-C free-chains on the cell surface. In this study, we deepen the understanding of HLA-C and Env association by showing that HIV-1 specifically increases the amount of HLA-C free chains, not bound toβ 2m, on the membrane of infected cells. The association between Env and HLA-C takes place at the cell membrane requiring β2m to occur. We report that the enhanced infectivity conferred to HIV-1 by HLA-C specifically involves HLA-C free chain molecules that have been correctly assembled with β2m. HIV-1 Env-pseudotyped viruses produced in the absence of β2m are less infectious than those produced in the presence of β2m. We hypothesize that the conformation and surface expression of HLA-C molecules could be a discriminant for the association with Env. Binding stability to β2m may confer to HLA-C the ability to preferentially act either as a conventional immune-competent molecule or as an accessory molecule involved in HIV-1 infectivity. -

Multi-Antigen Vaccination with Simultaneous Engagement of the OX40 Receptor Delays Malignant Mesothelioma Growth and Increases Survival in Animal Models
University of Rhode Island DigitalCommons@URI Cell and Molecular Biology Faculty Publications Cell and Molecular Biology 2019 Multi-antigen Vaccination With Simultaneous Engagement of the OX40 Receptor Delays Malignant Mesothelioma Growth and Increases Survival in Animal Models Peter R. Hoffmann Fukun W. Hoffmann Thomas A. Premeaux Tsuyoshi Fujita Elisa Soprana See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/cmb_facpubs Authors Peter R. Hoffmann, Fukun W. Hoffmann, Thomas A. Premeaux, Tsuyoshi Fujita, Elisa Soprana, Maddalena Panigada, Glen M. Chew, Guilhem Richard, Pooja Hindocha, Mark Menor, Vedbar S. Khadka, Youping Deng, Leonard Moise, Lishomwa C. Ndhlovu, Antonio Siccardi, Andrew D. Weinberg, Anne S. De Groot, and Pietro Bertino ORIGINAL RESEARCH published: 02 August 2019 doi: 10.3389/fonc.2019.00720 Multi-antigen Vaccination With Simultaneous Engagement of the OX40 Receptor Delays Malignant Mesothelioma Growth and Increases Survival in Animal Models Peter R. Hoffmann 1, Fukun W. Hoffmann 1, Thomas A. Premeaux 2, Tsuyoshi Fujita 2, Elisa Soprana 3, Maddalena Panigada 3, Glen M. Chew 2, Guilhem Richard 4, Pooja Hindocha 4, Mark Menor 5, Vedbar S. Khadka 5, Youping Deng 5, Lenny Moise 4,6, Lishomwa C. Ndhlovu 2, Antonio Siccardi 3, Andrew D. Weinberg 7, Anne S. De Groot 4,6 and Edited by: 1 Yanis Boumber, Pietro Bertino * Fox Chase Cancer Center, 1 Department of Cell and Molecular Biology, John A. Burns School of Medicine, University of Hawai’i, Honolulu, HI, United States United States, 2 Department of Tropical Medicine, John A. Burns School of Medicine, University of Hawai’i, Honolulu, HI, Reviewed by: United States, 3 Department of Molecular Immunology, San Raffaele University and Research Institute, Milan, Italy, 4 EpiVax, Arvind Chhabra, Inc., Providence, RI, United States, 5 Bioinformatics Core, Department of Complementary and Integrative Medicine, John A. -

International Md Program
UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE STUDENT GUIDE FACULTY OF MEDICINE AND SURGERY MASTER’S DEGREE COURSE INTERNATIONAL MD PROGRAM Academic Year 2017/2018 Student Guide A.Y. 2017/2018 Pag. 1 di 32 Master’s Degree Course International MD Program_Year 1 Academic Calendar Student Guide A.Y. 2017/2018 Pag. 2 di 32 Master’s Degree Course International MD Program_Year 1 Notice from the University Committee of the enhancement of quality on the questionnaires for the evaluation of courses and teaching Vita-Salute San Raffaele University considers a continuous process of monitoring and evaluating the quality of the educational mission, also in terms of planning, as essential for achieving excellence in higher education and research. UniSR Students can assess the correspondence between the teaching quality offered and their expectation. That is very important to improve teaching and training and develop successful strategies. At the end of each semester, students’ opinions are collected through evaluation questionnaires. Filling in the questionnaire is compulsory, according to the guidelines published in November 2013 by ANVUR (the National Agency for the Evaluation of the University and Research Systems). IT techniques have been implemented to speed up questionnaire collection and processing. Anonymity is fully guaranteed. Filling in the questionnaires is the necessary condition which allows a student to register for the exams. After collection, data are firstly conveyed to the Master’s degree course Coordinators and to the Deans of the Faculties and finally to the University Evaluation Commission for the analysis of data. The data collected will be a fundamental source to spot every sort of issue, thus for future improvement. -

Fusion of HCV Nonstructural Antigen to MHC Class II–Associated Invariant Chain Enhances T-Cell Responses Induced by Vectored Vaccines in Nonhuman Primates
Vaccine Technology © The American Society of Gene & Cell Therapy original article original article Invariant Chain Linkage Improves Vectored Vaccines © The American Society of Gene & Cell Therapy Fusion of HCV Nonstructural Antigen to MHC Class II–associated Invariant Chain Enhances T-cell Responses Induced by Vectored Vaccines in Nonhuman Primates Stefania Capone1, Mariarosaria Naddeo1, Anna Morena D’Alise1, Adele Abbate1, Fabiana Grazioli1, Annunziata Del Gaudio1, Mariarosaria Del Sorbo1, Maria Luisa Esposito1, Virginia Ammendola1, Gemma Perretta2, Alessandra Taglioni2, Stefano Colloca1, Alfredo Nicosia1,3,4, Riccardo Cortese1,5 and Antonella Folgori1 1Okairos, Rome, Italy; 2Cellular Biology and Neurobiology Institute (IBCN) National Research Council of Italy, Rome, Italy; 3CEINGE, Naples, Italy; 4De- partment of Molecular Medicine and Medical Biotechnology, University of Naples Federico II, Naples, Italy; 5Okairos AG, c/o OBC Suisse AG, Basel, Switzerland Despite viral vectors being potent inducers of antigen-spe- species, which establish chronic infection.1 Ads can be considered cific T cells, strategies to further improve their immunoge- self-adjuvanting vaccines because they have a natural aptitude to nicity are actively pursued. Of the numerous approaches trigger innate immunity, largely due to the activity of their struc- investigated, fusion of the encoded antigen to major his- tural viral proteins. Several innate signaling pathways have been tocompatibility complex class II–associated invariant chain implicated in the recognition of components of Ads, including (Ii) has been reported to enhance CD8+ T-cell responses. toll-like receptors (TLRs).2 Engagement of TLRs initiates a signal- We have previously shown that adenovirus vaccine encod- ing cascade involving the intracellular adaptor molecules MyD88 ing nonstructural (NS) hepatitis C virus (HCV) proteins and/or TRI-domain-containing adapter-inducing interferon-β, induces potent T-cell responses in humans. -
Corso Di Laurea in Biotecnologie Mediche E Farmaceutiche
GUIDA DELLO STUDENTE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE Anno Accademico 2010 - 2011 Guida dello Studente A.A. 2009-2010 Pag. 1 di 61 Corso di Laurea Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche INSEGNAMENTI ATTIVI II ANNO Biochimica Biologia Molecolare Fisiologia Umana Organizzazione Morfofunzionale del Sistema Nervoso Centrale Ingegneria Genetica Sperimentale Microbiologia Genetica Patologia Generale e Immunologia Espressione e Purificazione di Proteine I CORSI ELETTIVI Lettura critica di un articolo scientifico Tecniche e strategie di problem solving Una lama a doppio taglio: il sistema immunitario tra risposta ai patogeni, tumori e autoimmunità Sviluppo delle idee in genetica molecolare dal 1943 al 1975 Generazione di anticorpi monoclonali mediante librerie fagiche e loro caratterizzazione Il marketing della ricerca: dal bancone del laboratorio al mercato Guida dello Studente A.A. 2009-2010 Pag. 2 di 61 Corso di Laurea Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche Biochimica Nome del docente Coordinatore Angelo Corti Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Telefono: 022643.4802 Orario di ricevimento Su appuntamento, email [email protected] Curriculum scientifico coordinatore Name: Angelo Corti; Date of birth: July 25th, 1955 Address: DIBIT, San Raffaele Scientific Institute, via Olgettina 58, 20131 Milan, Italy; Tel.: +39-02- 26434802; Fax: +39-02-26434786 Education: 1978: Biological Sciences, University of Milan. Professional experience 1976-1978: Lab. of Biological Chemistry, University -
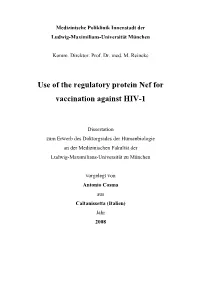
Use of the Regulatory Protein Nef for Vaccination Against HIV-1
Medizinische Poliklinik Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität München Komm. Direktor: Prof. Dr. med. M. Reincke Use of the regulatory protein Nef for vaccination against HIV-1 Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Humanbiologie an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München vorgelegt von Antonio Cosma aus Caltanissetta (Italien) Jahr 2008 Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Universität München Berichterstatter: Prof. Dr. Frank-Detlef Goebel .............................................................. Mitberichterstatter: Prof. Dr. Josef Eberle Prof. Dr. Thomas Löscher Mitbetreuung durch den Promovierten Mitarbeiter .............................................................. Dekan: Prof. Dr. med. Dietrich Reinhardt Tag der mündlichen Prüfung: 12.03.2008 2 Zusammenfassung..................................................................................................................... 5 Summary.................................................................................................................................... 7 Background ............................................................................................................................... 9 AIDS and HIV an historical overview.............................................................................................9 Natural history of HIV infection.................................................................................................... 13 Vaccination ..................................................................................................................................... -

Tesi Di Dottorato
! ! ! ! ! UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELLA RIPRODUZIONE DOTTORATO DI RICERCA IN BIOSCIENZE CICLO XXIII TESI DI DOTTORATO Humanization of murine neutralizing monoclonal antibodies against HIV-1 through a new approach based on lentiviral vectors S.S.D. BIO 11 Coordinatore: Prof.ssa Marta Palmieri Tutor: Dott. Donato Zipeto Dottorando: Dott. Pierpaolo Racchiolli Index INDEX ABBREVIATIONS ........................................................................................................... 4 ABSTRACT ....................................................................................................................... 7 RIASSUNTO ..................................................................................................................... 9 1. INTRODUCTION ....................................................................................................... 11 1.1 HIV-1 DISCOVERY, ORIGIN AND EVOLUTION .......................................................... 11 1.2 CLINICAL COURSE OF HIV INFECTION .................................................................... 14 1.3 HIV-1 STRUCTURE AND GENOME ........................................................................... 16 1.4 HIV-1 REPLICATION CYCLE .................................................................................... 21 1.5 HIV-1 VACCINE: STATE OF THE ART ....................................................................... 27 1.6 FUSION COMPLEXES ............................................................................................... -

Scientific Report 2012 Institute for Research in Biomedicine Scientific Report 2012
Università Institute for della Research in Svizzera Biomedicine italiana Institute for Research in Biomedicine Scientific Report 2012 Institute for Research in Biomedicine Scientific Report 2012 This Scientific Report covers the 2012 Research Activities of the Institute for Research in Biomedicine (IRB) The report can also be accessed at the IRB's website www.irb.usi.ch Scientific Report 2012 Foreword by Giorgio Noseda and Gabriele Gendotti Past and Present Presidents of the Foundation Council The Institute for Research in Biomedicine (IRB), a university-level research institute, has already well af- firmed itself worldwide, despite having started its operations only in the year 2000. Its key strengths are a leadership of international fame, a network of excellent collaborations, and an environment that allows for the carrying out of research with limited teaching activity. 2012 was a year rich in events for the IRB. We in fact modified the Foundation Board and elected a new President to make room for new strengths and fresh ideas and to better face the future challenges that we have undertaken for the growth of the IRB. The Presidential transition and the approval of the new Founda- tion Board of the IRB took place on June 25th, 2012, and were followed by a meeting with the Bellinzona township authorities in which notable scientific results as well as the prospects of expansion of the Institute were presented. The Foundation Board has also finalized a document that describes its future strategies, its mission, its vision, its goals and the predicted evolution of the IRB for the period from 2012 to 2016. -
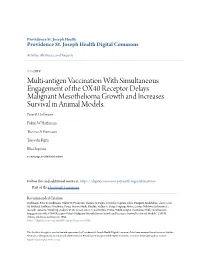
Multi-Antigen Vaccination with Simultaneous Engagement of the OX40 Receptor Delays Malignant Mesothelioma Growth and Increases Survival in Animal Models
Providence St. Joseph Health Providence St. Joseph Health Digital Commons Articles, Abstracts, and Reports 1-1-2019 Multi-antigen Vaccination With Simultaneous Engagement of the OX40 Receptor Delays Malignant Mesothelioma Growth and Increases Survival in Animal Models. Peter R Hoffmann Fukun W Hoffmann Thomas A Premeaux Tsuyoshi Fujita Elisa Soprana See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.psjhealth.org/publications Part of the Oncology Commons Recommended Citation Hoffmann, Peter R; Hoffmann, Fukun W; Premeaux, Thomas A; Fujita, Tsuyoshi; Soprana, Elisa; Panigada, Maddalena; Chew, Glen M; Richard, Guilhem; Hindocha, Pooja; Menor, Mark; Khadka, Vedbar S; Deng, Youping; Moise, Lenny; Ndhlovu, Lishomwa C; Siccardi, Antonio; Weinberg, Andrew D; De Groot, Anne S; and Bertino, Pietro, "Multi-antigen Vaccination With Simultaneous Engagement of the OX40 Receptor Delays Malignant Mesothelioma Growth and Increases Survival in Animal Models." (2019). Articles, Abstracts, and Reports. 1983. https://digitalcommons.psjhealth.org/publications/1983 This Article is brought to you for free and open access by Providence St. Joseph Health Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Articles, Abstracts, and Reports by an authorized administrator of Providence St. Joseph Health Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Authors Peter R Hoffmann, Fukun W Hoffmann, Thomas A Premeaux, Tsuyoshi Fujita, Elisa Soprana, Maddalena Panigada, Glen M Chew, Guilhem -

Human Survivin Highly Immunogenic Vaccines Peter R
University of Rhode Island DigitalCommons@URI Institute for Immunology and Informatics Faculty Institute for Immunology and Informatics (iCubed) Publications 2015 Preclinical development of HIvax: human survivin Highly Immunogenic vaccines Peter R. Hoffmann Maddalena Panigada See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/immunology_facpubs The University of Rhode Island Faculty have made this article openly available. Please let us know how Open Access to this research benefits oy u. This is a pre-publication author manuscript of the final, published article. Terms of Use This article is made available under the terms and conditions applicable towards Open Access Policy Articles, as set forth in our Terms of Use. Citation/Publisher Attribution Hoffmann, P. R, Panigada, M., Soprana, E., Terry, F., Bandar, I. S., Napolitano, A., Rose, A. H., Hoffmann, F. W., Ndhlovu, L. C., Belcaid, M., Moise, L., De Groot, A. S., Carbone, M., Gaudino, G., Matsui, T., Siccardi, A., & Bertino, P. (2015). Preclinical development of HIvax: human survivin Highly Immunogenic vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 11(7), 1585-1595. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645515.2015.1050572 This Article is brought to you for free and open access by the Institute for Immunology and Informatics (iCubed) at DigitalCommons@URI. It has been accepted for inclusion in Institute for Immunology and Informatics Faculty Publications by an authorized administrator of DigitalCommons@URI. For more information, please contact [email protected]. Authors Peter R. Hoffmann, Maddalena Panigada, Elisa Soprana, Francis Terry, Ivo Sah Bandar, Andrea Napolitano, Aaron H. Rose, Fukun W. -

TH HBV VV-001 Clinical Study
TH HBV VV-001 Clinical study Recombinant vaccine vector Modified Vaccinia Ankara-HBV (MVA-HBV) Annex IIIA according to Directive 2001/18/EC Information Required in Notifications Concerning Releases of Genetically Modified Organisms Other than Higher Plants Notifier: GlaxoSmithKline Biologicals EudraCT number: 2017-001452-55 Version 1.0 – February-2018 Confidential EudraCT Number: 2017-001452-55 Product Code: MVA-HBV 2001/18/EC Directive – Annex IIIA – V0.1 Table of contents List of Figures________________________________________________________________________ 6 List of Tables ________________________________________________________________________ 6 Abbreviations _______________________________________________________________________ 7 I. GENERAL INFORMATION _____________________________________________________________ 8 A. Name and address of the notifier (company or institute) _________________________________ 8 B. Name, qualifications and experience of the responsible scientist(s) _________________________ 8 C. Title of the project________________________________________________________________ 9 II. INFORMATION RELATING TO THE GMO _________________________________________________ 9 A. Characteristics of (a) the donor, (b) the recipient or (c) (where appropriate) parental organism(s): 9 1. scientific name; ________________________________________________________________ 9 2. taxonomy; ___________________________________________________________________ 10 3. other names (usual name, strain name, etc.); _______________________________________