Beniamino Di Martino, Società E Stato Nel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pius XII on Trial
The University of Maine DigitalCommons@UMaine Honors College 5-2014 Pius XII on Trial Katherine M. Campbell University of Maine - Main, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors Part of the Anthropology Commons, and the History Commons Recommended Citation Campbell, Katherine M., "Pius XII on Trial" (2014). Honors College. 159. https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/159 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Honors College by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. PIUS XII ON TRIAL by Katherine M. Campbell A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for a Degree with Honors (Anthropology and Political Science) The Honors College University of Maine May 2014 Advisory Committee: Henry Munson, Professor of Anthropology Alexander Grab, Professor of History Mark D. Brewer, Associate Professor of Political Science Richard J. Powell, Associate Professor of Political Science, Leadership Studies Sol Goldman, Adjunct Assistant Professor of Political Science Copyright 2014 Katherine M. Campbell Abstract: Scholars have debated Pope Pius XII’s role in the Holocaust since the 1960s. Did he do everything he could and should have done to save Jews? His critics say no because of antisemitism rooted in the traditional Catholic views. His defenders say yes and deny that he was an antisemite. In my thesis, I shall assess the arguments on both sides in terms of the available evidence. I shall focus both on what Pius XII did do and what he did not do and on the degree to which he can be held responsible for the actions of low-level clergy. -

Mystici Corporis Christi
MYSTICI CORPORIS CHRISTI ENCYCLICAL OF POPE PIUS XII ON THE MISTICAL BODY OF CHRIST TO OUR VENERABLE BRETHREN, PATRIARCHS, PRIMATES, ARCHBISHOPS, BISHIOPS, AND OTHER LOCAL ORDINARIES ENJOYING PEACE AND COMMUNION WITH THE APOSTOLIC SEE June 29, 1943 Venerable Brethren, Health and Apostolic Benediction. The doctrine of the Mystical Body of Christ, which is the Church,[1] was first taught us by the Redeemer Himself. Illustrating as it does the great and inestimable privilege of our intimate union with so exalted a Head, this doctrine by its sublime dignity invites all those who are drawn by the Holy Spirit to study it, and gives them, in the truths of which it proposes to the mind, a strong incentive to the performance of such good works as are conformable to its teaching. For this reason, We deem it fitting to speak to you on this subject through this Encyclical Letter, developing and explaining above all, those points which concern the Church Militant. To this We are urged not only by the surpassing grandeur of the subject but also by the circumstances of the present time. 2. For We intend to speak of the riches stored up in this Church which Christ purchased with His own Blood, [2] and whose members glory in a thorn-crowned Head. The fact that they thus glory is a striking proof that the greatest joy and exaltation are born only of suffering, and hence that we should rejoice if we partake of the sufferings of Christ, that when His glory shall be revealed we may also be glad with exceeding joy. -

The Mediation of the Church in Some Pontifical Documents Francis X
THE MEDIATION OF THE CHURCH IN SOME PONTIFICAL DOCUMENTS FRANCIS X. LAWLOR, SJ. Weston College N His recent encyclical letter, Hurnani generis, of Aug. 12, 1950, the I Holy Father reproves those who "reduce to a meaningless formula the necessity of belonging to the true Church in order to achieve eternal salvation."1 In the light of the Pope's insistence in the same encyclical letter on the ordinary, day-by-day teaching office of the Roman Pontiffs, it will be useful to select from the infra-infallible but authentic teaching of the Popes some of the abundant material touching the question of the mediatorial function of the Church in the order of salvation. The Popes, to be sure, do not speak and write after the manner of theo logians but as pastors of souls, and it is doubtless not always easy to transpose to a theological level what is contained in a pastoral docu ment and expressed in a pastoral method of approach. Yet the authentic teaching of the Popes is both a guide to, and a source of, theological thinking. The documents cited are of varying solemnity and doctrinal importance; an encyclical letter is clearly of greater magisterial value than, let us say, an occasional epistle to some prelate. It is not possible here to situate each citation in its documentary context; but the force and point of a quotation, removed from its documentary perspective, is perhaps as often lessened as augmented. Those who wish may read them in their context, if they desire a more careful appraisal of evidence. -

Godność Człowieka I Dobro Wspólne W Papieskim Nauczaniu Społecznym
Rozdział III Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu papieskim w latach 1878−1958 1. Leon XIII i fundamenty papieskiego nauczania o godności człowieka i dobru wspólnym Nikomu nie wolno naruszać bezkarnie tej godności człowie- ka, którą sam Bóg z wielka czcią rozporządza899. Cel bowiem wytknięty państwu dotyczy wszystkich oby- wateli, bo jest nim dobro powszechne, w którym uczestni- czyć mają prawo wszyscy razem i każdy z osobna, w części należnej900. Uczestnicy współczesnego dyskursu politycznego w poszukiwaniu aksjologicznych fun- damentów dla ustawodawstwa krajowego czy ponadnarodowego odwołują się do takich kategorii, jak: wolność, równość, prawa człowieka. Do tych fundamentalnych idei zaliczyć należy również dignitas humana i bonum commune901. Wydaje się poza dyskusją, że wielką rolę w przetrwaniu i rozwoju tych idei odegrała katolicka nauka społeczna, co uzasadnia poddanie analizie poglądów w tej materii twórcy papieskiego nauczania społecznego Le- ona XIII. Wybrany 20 lutego 1878 r. na papieża arcybiskup Perugii, kardynał Vincenzo Gioacchi- no Aloiso Pecci (1810−1903) przybrał imię Leona XIII. Nowy papież rozbudził w środowi- skach katolickich, zwłaszcza w kręgach zajmujących się problemami społecznymi, wielkie nadzieje na zmiany, które byłyby w stanie dostosować Kościół katolicki do istniejących 899 Rerum novarum Jego Świątobliwości Leona, z opatrzności Bożej papieża XIII, encyklika o robot- nikach z 15 maja 1891 r. Osobne odbicie z „Notyfi kacyj” Kuryi Książęco-Biskupiej w Krakowie, nr VII i VIII z roku 1891, Kraków 1891, s. 27. 900 Ibidem, s. 33. 901 Szerzej na ten temat por. M. Sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, [w:] Studia Erasmiana Wratislaviensia − Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. -

The Lateran Pacts and the Debates in the Italian Constituent Assembly with Reference to Religious Freedom, and the Consequences for Religious Minorities (1946-1948)
_________________________________________________________________________Swansea University E-Theses The Lateran Pacts and the debates in the Italian Constituent Assembly with reference to religious freedom, and the consequences for religious minorities (1946-1948). Thomas, Huw Martin How to cite: _________________________________________________________________________ Thomas, Huw Martin (2005) The Lateran Pacts and the debates in the Italian Constituent Assembly with reference to religious freedom, and the consequences for religious minorities (1946-1948).. thesis, Swansea University. http://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa43092 Use policy: _________________________________________________________________________ This item is brought to you by Swansea University. Any person downloading material is agreeing to abide by the terms of the repository licence: copies of full text items may be used or reproduced in any format or medium, without prior permission for personal research or study, educational or non-commercial purposes only. The copyright for any work remains with the original author unless otherwise specified. The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holder. Permission for multiple reproductions should be obtained from the original author. Authors are personally responsible for adhering to copyright and publisher restrictions when uploading content to the repository. Please link to the metadata record in the Swansea University repository, Cronfa (link given in the citation -
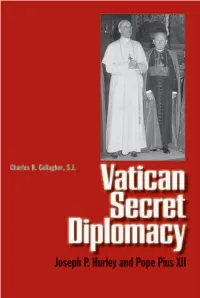
Vatican Secret Diplomacy This Page Intentionally Left Blank Charles R
vatican secret diplomacy This page intentionally left blank charles r. gallagher, s.j. Vatican Secret Diplomacy joseph p. hurley and pope pius xii yale university press new haven & london Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Copyright © 2008 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Set in Scala and Scala Sans by Duke & Company, Devon, Pennsylvania. Printed in the United States of America by Sheridan Books, Ann Arbor, Michigan. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gallagher, Charles R., 1965– Vatican secret diplomacy : Joseph P. Hurley and Pope Pius XII / Charles R. Gallagher. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-12134-6 (cloth : alk. paper) 1. Hurley, Joseph P. 2. Pius XII, Pope, 1876–1958. 3. World War, 1939–1945— Religious aspects—Catholic Church. 4. Catholic Church—Foreign relations. I. Title. BX4705.H873G35 2008 282.092—dc22 [B] 2007043743 A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Com- mittee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 To my father and in loving memory of my mother This page intentionally left blank contents Acknowledgments ix Introduction 1 1 A Priest in the Family 8 2 Diplomatic Observer: India and Japan, 1927–1934 29 3 Silencing Charlie: The Rev. -

G L O S S a R Y O F T E R
GLOSSARY OF TERMS ● anti-Judaism: hostility toward the Jewish religion, usually based on Christian theological principles. ● antisemitism: term created in 1879 by Wilhelm Marr in Germany. Jews were defined as a distinct “race”; a contemporary name for “Jew-hatred” or “Judeophobia.” ● Black Nobility: the papal aristocracy who remained loyal to the Holy See after the abolition of the papal states in 1870. ● congregation: a Vatican department supervising a specific part of church government: for example, Congregation for the Sacraments supervised the liturgical life of the church. ● Curia: the governing body of the Catholic Church. ● deicide: literally “the murder of God”; a charge levelled against the Jews by many of the Church Fathers. Officially rejected by the Catholic Church in 1965. ● dicastery: subsection of a congregation. ● Diocese: geographical region governed by a bishop. ● diplomatic note: a less formal communication between governments. ● encyclical: formal papal letter addressed to the whole church or, in special cases, addressed to a particular country, specifying an area of Catholic faith and morals. ● Endlösung: The “Final Solution”; Nazi euphemism for the murder of the Jews. It was the “Final Solution” of the Judenfrage (the Jewish question). ● Holy See: the seat of the bishop of Rome, the symbol of unity within the Catholic Church. Often used interchangeably with Vatican. ● Holy Week: most sacred week in the Christian calendar stretching from Palm Sunday through to the Easter Triduum (Holy or Maundy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, Easter Sunday). It recalls the last days of Christ and is marked with liturgies of special solemnity. ● legate: papal representative in a country without formal diplomatic relations with the Holy See. -

How to Read, Study and Benefit from Papal Encyclicals
How to Read, Study and Benefit from Papal Encyclicals Contents What is an Encyclical ..................................................................................................................................... 1 How to Read and Study an Encyclical ........................................................................................................... 2 Are Encyclicals Infallible Teachings of a Pope ............................................................................................... 2 History of Encyclicals ..................................................................................................................................... 3 Why Read Encyclicals if You are Not Catholic? ............................................................................................. 4 Links to Other Encyclicals and Lists of All Encyclicals ................................................................................... 4 List of Encyclicals ........................................................................................................................................... 4 What is an Encyclical The word encyclical literally means "in a circle." It is a letter intended to travel— to circulate. However in modern times it has become almost exclusively used to denote teachings from the Pope. Comparing an encyclical to other kinds of official Roman Catholic documents is a good way to understand the significance of an encyclical. Firstly, when the pope makes a declaration of some article of faith or moral law it is -

The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965 Ii Introduction Introduction Iii
Introduction i The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965 ii Introduction Introduction iii The Catholic Church and the Holocaust, 1930 –1965 Michael Phayer INDIANA UNIVERSITY PRESS Bloomington and Indianapolis iv Introduction This book is a publication of Indiana University Press 601 North Morton Street Bloomington, IN 47404-3797 USA http://www.indiana.edu/~iupress Telephone orders 800-842-6796 Fax orders 812-855-7931 Orders by e-mail [email protected] © 2000 by John Michael Phayer All rights reserved No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and re- cording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. The Association of Ameri- can University Presses’ Resolution on Permissions constitutes the only exception to this prohibition. The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Perma- nence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984. Manufactured in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Phayer, Michael, date. The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965 / Michael Phayer. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-253-33725-9 (alk. paper) 1. Pius XII, Pope, 1876–1958—Relations with Jews. 2. Judaism —Relations—Catholic Church. 3. Catholic Church—Relations— Judaism. 4. Holocaust, Jewish (1939–1945) 5. World War, 1939– 1945—Religious aspects—Catholic Church. 6. Christianity and an- tisemitism—History—20th century. I. Title. BX1378 .P49 2000 282'.09'044—dc21 99-087415 ISBN 0-253-21471-8 (pbk.) 2 3 4 5 6 05 04 03 02 01 Introduction v C O N T E N T S Acknowledgments ix Introduction xi 1. -

Did Pope Pius XII Help the Jews?
Did Pope Pius XII Help the Jews? by Margherita Marchione 1 Contents Part I - Overview………………………3 Did Pius XII help Jews? Part II - Yad Vashem …………………6 Does Pius XII deserve this honor? Part III - Testimonials…………………11 Is Jewish testimony available? Part IV - Four Hundred Visas……….16 Did Pius XII obtain these visas? Part V - Documentation………………19 When will vilification of Pius XII end? Part VI - World Press………………...23 How has the press responded? Part VII - Jewish Survivors…………...31 Have Survivors acknowledged help? Part VIII - Bombing of Rome…………34 Did the Pope help stop bombing? Part IX - Nazis and Jews Speak Out…37 Did Nazis and Jews speak out? Part X - Conclusion…………………....42 Should Yad Vashem honor Pius XII? 2 Part I - Overview Did Pius XII help Jews? In his book Adolf Hitler (Doubleday, 1976, Volume II, p. 865), John Toland wrote: "The Church, under the Pope's guidance [Pius XII], had (by June, 1943) already saved the lives of more Jews than all other churches, religious institutions and rescue organizations combined, and was presently hiding thousands of Jews in monasteries, convents and Vatican City itself. …The British and Americans, despite lofty pronouncements, had not only avoided taking any meaningful action but gave sanctuary to few persecuted Jews." It is historically correct to say that Pope Pius XII, through his bishops, nuncios, and local priests, mobilized Catholics to assist Jews, Allied soldiers, and prisoners of war. There is a considerable body of scholarly opinion that is convinced Pius XII is responsible for having saved 500,000 to 800,000 Jewish lives. -

Mag 45 FINAL.Qxd
May/June 2000 /$5.00 Magazine A m essage from the American T FP Where Is Elian’s Journey Leading Us? This statement was he steady stream of photos of a smiling Cuban people. 2 Even the United Nations Human also published in The Elian Gonzalez reunited with his father Rights Commission has again condemned Cuba Tcould well foster the impression of a for its human rights violations. 3 Washington Times and happy ending to the sad story of this young There is no freedom in that island prison, The Wanderer. Cuban refugee. Were one naive enough to where the most basic civil liberties — the free - believe this, one might well conclude that the dom to practice one’s faith, to own property, to entire matter was a tempest in a Miami teapot. associate with friends of one’s choosing, to Moreover, one would think that Bernard Cardi - express one’s opinions openly, to travel in safety nal Law of Boston was quite right when he said — are routinely denied. the whole thing was nothing but a circus with a Elian’s return to Cuba — forced or simple solution: returning the boy to his father. 1 voluntary — cannot alter that fundamental With possession regarded as nine points of reality. By holding on to him, the Cuban-Ameri - the law, Elian’s is a closed case for many Ameri - can community was fighting to defend him cans. All too soon, this family affair will be yes - from a police state whose constitution decrees terday’s news. Father knows best, and Fidel — that the government must see to “the formation who in a candid moment described himself as of the communist personality of youths and the true father of all Cubans — will have won children”. -

Human Development As Integral Development: the Os Cial Teaching of the Church in an African Context Joseph Kariuki Kamau
Duquesne University Duquesne Scholarship Collection Electronic Theses and Dissertations Fall 2009 Human Development as Integral Development: The oS cial Teaching of the Church in an African Context Joseph Kariuki Kamau Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/etd Recommended Citation Kamau, J. (2009). Human Development as Integral Development: The ocS ial Teaching of the Church in an African Context (Doctoral dissertation, Duquesne University). Retrieved from https://dsc.duq.edu/etd/727 This Immediate Access is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection. For more information, please contact [email protected]. HUMAN DEVELOPMENT AS INTEGRAL DEVELOPMENT THE SOCIAL TEACHING OF THE CHURCH IN AN AFRICAN CONTEXT A Dissertation Submitted to the McAnulty College and Graduate School of Liberal Arts Duquesne University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosphy By Kamau Joseph Kariuki December 2009 Copyright by Kamau Joseph Kariuki 2009 iii HUMAN DEVELOPMENT AS INTEGRAL DEVELOPMENT THE SOCIAL TEACHING OF THE CHURCH IN AN AFRICAN CONTEXT By Kamau Joseph Kariuki Approved November 18, 2009 Approved: _________________________________________ Dr. Gerald Boodoo, Dissertation Director Approved: _________________________________________ Dr. George S. Worgul, Jr., First Reader Approved: _________________________________________ Dr. Daniel Scheid, Second Reader Approved: _________________________________________ Dr. George S. Worgul, Jr. Chair of the Theology Department Approved: _________________________________________ Christopher M. Duncan, Ph.D. Dean, McAnulty College and Graduate School of Liberal Arts iv ABSTRACT HUMAN DEVELOPMENT AS INTEGRAL DEVELOPMENT THE SOCIAL TEACHING OF THE CHURCH IN AN AFRICAN CONTEXT By Kamau Joseph Kariuki December 2009 Dissertation supervised by Gerald Boodoo, Ph.D.