Sussidio 2010/2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CAPRICCIO Songbook
CAPRICCIO KARAOKE SongBOOK ITALIA – ENGLAND – SPANIEN DEUTSCHLAND – SCHWEIZ – PORTUGAL – FRANCE - BALKAN KARAOKE ItaliA www.capricciomusic.ch [email protected] Aktualisiert am: 01. Februar 2013 Artist Title 2 Black e Berte' Waves of Love (in alto Mare) 360 Gradi Baba bye 360 Gradi Sandra 360 Gradi & Fiorello E poi non ti ho vista piu 360 Gradi e Fiorello E poi non ti ho vista più (K5) 400 colpi Prendi una matita 400 Colpi Se puoi uscire una domenica 78 Bit Fotografia 883 Pezzali Max Aereoplano 883 Pezzali Max Bella vera 883 Pezzali Max Bella Vera (K5) 883 Pezzali Max Chiuditi nel cesso 883 Pezzali Max Ci sono anch'io 883 Pezzali Max Come deve andare 883 Pezzali Max Come mai 883 Pezzali Max Come mai (K5) 883 Pezzali Max Come mai_(bachata) 883 Pezzali Max Come maiBachata (K5i) 883 Pezzali Max Con dentro me 883 Pezzali Max Credi 883 Pezzali Max Cumuli 883 Pezzali Max Dimmi perche' 883 Pezzali Max Eccoti 883 Pezzali Max Fai come ti pare 883 Pezzali Max Fai come ti pare 883 Pezzali Max Favola semplice 883 Pezzali Max Gli anni 883 Pezzali Max Grazie Mille (K5) 883 Pezzali Max Grazie mille 1 883 Pezzali Max Grazie mille 2 883 Pezzali Max Hanno Ucciso L'Uomo Ragno (K5) 883 Pezzali Max Hanno ucciso l'uomo ragno 1 883 Pezzali Max hanno ucciso l'uomo ragno 2 883 Pezzali Max Il meglio deve ancora arrivare 883 Pezzali Max Il mio secondo tempo 883 Pezzali Max Il mondo insieme a te 883 Pezzali Max Il mondo Insieme a Te (K5) 883 Pezzali Max Innamorare tanto 883 Pezzali Max Io ci saro' 883 Pezzali Max Jolly blue 883 Pezzali Max La dura legge del -

Rassegna Del 16/04/2019
Rassegna del 16/04/2019 EVIDENZA 16/04/19 Corriere della Sera 13 Musica ... 2 Roma 16/04/19 Repubblica Roma 22 Musica ... 3 16/04/19 Messaggero Cronaca di 49 Il meglio - Serata in musica per il Gemelli ... 4 Roma 16/04/19 Messaggero Cronaca di 49 Lirica e Concerti ... 5 Roma 16/04/19 Italia Oggi 16 Nel cervello una danza di parole Ferroni Gianfranco 6 16/04/19 Leggo Roma 21 Raggi: «Cento milioni per la cultura» P.L.M. 8 16/04/19 Leggo Roma 24 RomaEuropa festival, visioni sui Paesaggi dell'uomo d'oggi Benelli Elena 9 16/04/19 Leggo Roma 25 Da non perdere. Con Gemelli per la vita Da Alexia a Simone ... 10 Cristicchi 16/04/19 Repubblica Bari 15 Mirko Signorile e Trio Trip il jazz minimalista nel segno di Bill Camero Gilda 11 Evans SPETTACOLI 16/04/19 Corriere della Sera 13 Reggiani, Brilli e Fuortes alla Vedova allegra Ro.Petr. 13 Roma 16/04/19 Messaggero 26 Mina direttrice di Sanremo 2020 L'ad Rai, Salini: «Incontriamoci» - Scarpa Andrea 14 Mina a Sanremo 2020 Salini: «Incontriamoci» COMUNE DI ROMA 16/04/19 Repubblica 16 Raggi isolata nel M5S Di Maio, difesa gelida "La città era già Cuzzocrea Annalisa 17 distrutta" 16/04/19 Repubblica Roma 1 Anche Meloni in marcia su Roma Capitale d'Europa - Dopo Salvini Rizzo Sergio 19 anche Meloni marcia su Roma Capitale d'Europa 16/04/19 Messaggero 12 Roma, si muove il Viminale Le paure della sindaca: un nuovo Canettieri Simone 20 prefetto pro-Lega 16/04/19 Messaggero Cronaca di 42 Crollo al Flaminio, pagano i residenti - Flaminio, beffa dopo il crollo Troili Raffaella 21 Roma «Lavori a carico dei residenti» .. -

Artist Title Count PURPLE DISCO MACHINE FEAT. MOSS KENA & THEFIREWORKS KNOCKS 92 LEONY FADED LOVE 83 ONEREPUBLIC RUN 82 ATB FT
Artist Title Count PURPLE DISCO MACHINE FEAT. MOSS KENA & THEFIREWORKS KNOCKS 92 LEONY FADED LOVE 83 ONEREPUBLIC RUN 82 ATB FT. TOPIC & A7S YOUR LOVE 81 JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR PEACHES 81 COLDPLAY HIGHER POWER 80 IMAGINE DRAGONS FOLLOW YOU 80 OLIVIA RODRIGO GOOD 4 YOU 80 REGARD X TROYE SIVAN X TATE MCRAE YOU 79 ALVARO SOLER MAGIA 74 RITON X NIGHTCRAWLERS FRIDAY 74 LOST FREQUENCES RISE 70 JONAS BLUE FT. AVA SOMETHING STUPID 69 THE WEEKND SAVE YOUR TEARS 69 KUNGS NEVER GOING HOME 68 ED SHEERAN BAD HABITS 68 JUSTIN WELLINGTON FEAT. SMALL JAM IKO IKO 67 MAJESTIC X BONEY M. RASPUTIN 67 ROBIN SCHULZ FT. FELIX JAEHN & ALIDA ONE MORE TIME 66 RAG'N'BONE MAN ALL YOU EVER WANTED 64 DUA LIPA LOVE AGAIN 63 JOEL CORRY FT. RAYE & DAVID GUETTA BED 63 JASON DERULO & NUKA LOVE NOT WAR 62 MEDUZA FT. DERMOT KENNEDY PARADISE 59 AVA MAX MY HEAD & MY HEART 58 DUA LIPA WE'RE GOOD 57 MARTIN GARRIX FEAT. BONO & THE EDGE WE ARE THE PEOPLE 57 JOEL CORRY HEAD AND HEART 56 CALVIN HARRIS FT. TOM GRENNAN BY YOUR SIDE 56 DOJA CAT FEAT. SZA KISS ME MORE 56 PINK ALL I KNOW SO FAR 54 OFENBACH FT. LAGIQUE WASTED LOVE 53 PINK + WILLOW SAGE HART COVER ME IN SUNSHINE 53 MALARKEY SHACKLES (PRAISE YOU) 50 MASTER KG FT. NOMCEBO JERUSALEMA 49 SIA & DAVID GUETTA FLOATING THROUGH SPACE 48 SUPER-HI & NEEKA FOLLOWING THE SUN 48 ALVARO SOLER FT. CALI Y EL DANDEE MANANA 44 MARCO MENGONI MA STASERA 42 AVA MAX EVERYTIME I CRY 41 TATE MCRAE YOU BROKE ME FIRST [LUCA SCHREINER41 REMIX] MAROON 5 LOST 40 OFENBACH & QUARTERHEAD HEAD SHOULDERS KNEES & TOES 38 PS1 FT. -

Elenco Basi Musicali
Elenco basi musicali (Nella scheda d'iscrizione indicare sempre 3 titoli di canzoni) 1 Grazie mille 883 2 Bella vera 883 3 Viaggio al centro del mondo 883 4 Nient'altro che noi 883 5 Come deve andare 883 6 Io ci saro' 883 7 Come mai 883 8 Nord Sud Ovest Est 883 9 Le ragazze fanno grandi sogni Edoardo Bennato 10 Sembra ieri Edoardo Bennato 11 Si tratta dell'amore Edoardo Bennato 12 L'isola che non c'e' Edoardo Bennato 13 W la mamma Edoardo Bennato 14 Il gatto e la volpe Edoardo Bennato 15 C'e' il sole Edoardo De Crescenzo 16 Ancora Edoardo De Crescenzo 17 Abbronzatissima Edoardo Vianello 18 I watussi Edoardo Vianello 19 Guarda come dondolo Edoardo Vianello 20 Hully Gully In Dieci Edoardo Vianello 21 Pinne fucile ed occhiali Edoardo Vianello 22 Luce (tramonti a Nord-Est) Elisa 23 Rainbow Elisa 24 Broken Elisa 25 Una poesia anche per te Elisa 26 Eppure sentire (un senso di te) Elisa 27 Stay Elisa 28 Pavimento liquido Ale Baroni 29 La distanza di un amore Ale Baroni 30 I Want Love Elton John 31 Something About The Way You Look Tonight Elton John 32 Written In The Stars Elton John 33 Nikita Elton John 34 In The Ghetto Elvis Presley 35 It's Now Or Never (O Sole Mio) Elvis Presley 36 Can't Help Falling In Love Elvis Presley 37 Il portiere di notte Enrico Ruggeri 38 Mistero Enrico Ruggeri 39 Rhythm Divine Enrique Iglesias 40 Sad Eyes Enrique Iglesias 41 Bailamos RM Enrique Iglesias 42 Be With You Enrique Iglesias 43 Escape Enrique Iglesias 44 Cose della vita Eros Ramazzotti 45 Un angelo non e' Eros Ramazzotti 46 Piu' che puoi Eros Ramazzotti -
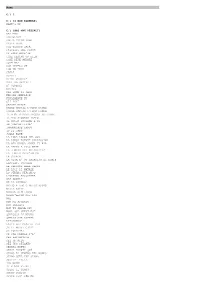
Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT's up C:\ \883 MAX PEZZALI
Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT'S UP C:\ \883 MAX PEZZALI\ 883 MIX AEROPLANO ANDRÀ TUTTO BENE BELLA VERA CHE GIORNO SARÀ CHIUDITI NEL CESSO CI SONO ANCH'IO COME DENTRO UN FILM COME DEVE ANDARE COME MAI CON DENTRO ME CON UN DECA CREDI CUMULI DIMMI PERCHE' DURI DA BATTERE E' VENERDI ECCOTI FAI COME TI PARE FAVOLA SEMPLICE FINALMENTE TU GLI ANNI GRAZIE MILLE HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE IL MIO SECONDO TEMPO IL MONDO INSIEME A TE IN QUESTA CITTA' INNAMORARE TANTO IO CI SARÒ JOLLY BLUE LA DURA LEGGE DEL GOL LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA LA MIA BANDA SUONA IL RAP LA RADIO A 1000 WATT LA REGINA DEL CELEBRITA' LA REGOLA DELL'AMICO LA STRADA LA VITA E' UN PARADISO DI BUGIE LASCIATI TOCCARE LE CANZONI ALLA RADIO LE LUCI DI NATALE LO STRANO PERCORSO L'ULTIMO BICCHIERE MAI UGUALI ME LA CAVERO' MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO NELLA NOTTE NESSUN RIMPIANTO NIENT'ALTRO CHE NOI NOI NON MI ARRENDO NON PENSAVI NON TI PASSA PIÙ NORD SUD OVEST EST QUALCOSA DI NUOVO QUELLO CHE CAPITA RITORNERO' ROTTA PER CASA DI DIO SE TI MUOVI COSI' SE TORNERAI SE UNA REGOLA C'E' SEI FANTASTICA SEI UN MITO SEI UNO SFIGATO SEMBRO MATTO SENZA AVERTI QUÌ SIAMO AL CENTRO DEL MONDO SIAMO QUEL CHE SIAMO SOLITA ITALIA TENENDOMI TI SENTO VIVERE TIENI IL TEMPO TORNO SUBITO TUTTO CIO' CHE HO TUTTO CIÒ CHE HO UN GIORNO COSI UN GIORNO COSI' UNA CANZONE D'AMORE UNA LUNGA ESTATE CALDISSIMA UN'ESTATE CI SALVERA' UNO IN PIÙ UNO SFIGATO VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO WEEKEND WELCOME TO MIAMI YOU NEEDED ME C:\ \A HA\ ANALOGUE COSY PRISONS DREAM -

Karaoke Mietsystem Songlist
Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Musica, Ritmo, Impegno
U.I.L.D.M - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus di UDINE Numero 12 Via Diaz, 60 - 33100 Udine - 0432 510261 - www.udine.uildm.org - [email protected] Settembre 2019 Sto “ammirando”… Nelle pagine centrali un poster un mare di realizzato da Luca Rigonat burocrazia! Musica, ritmo, impegno Intervista al musicista U. T. GANDHI - a pag. 6 Inoltre in questo numero: QUELLA “NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI” ............................................... pag. 2 AQUILEIA PER TUTTI - di Luca Rigonat ............................................ pag. 4 MUSICA E SOLIDARIETA’ - di Diego Badolo ..................................... pag. 12 INTERVISTA DOPPIA: Maurizia e Mario ............................................... pag. 14 MUSICA: ELISA - di Herrman Fanin ........................................................... pag. 16 CINEMA: Sulla mia (e nostra) pelle - di Diego Badolo .............. pag. 17 MADRACS E FALCONS .................................................................................................. pag. 18 CREATIVITÀ SENZA BARRIERE ...................................................................... pag. 20 Testimonianze la Redazione Quella “notte prima degli esami” Una tappa che chi studia deve prima o poi affrontare. Fonte di paure, ansie e un miscuglio di emozioni che non si dimenticano. Abbiamo chiesto ad alcuni amici della UILDM di raccontarci come hanno vissuto l'esame di maturità. Ecco cosa ci hanno raccontato SAMUELE MARCON - 2018/19 sicuro, escludendo la tipologia del testo argomentativo e quella del tema d’attualità, per non La mia notte prima degli esami è stata un vero e rischiare di incorrere in errori grossolani che proprio susseguirsi di emozioni contrastanti fra di avrebbero potuto incidere in maniera importante loro: sono passato infatti da sensazioni di ansia e sulla valutazione della prova. paura, poiché l’esame di maturità viene spesso Gli esami in sé erano a mio avviso alla portata di descritto dai professori come uno scoglio di tutti. -

Il Repertorio Dei Redrose
Il repertorio dei RedRose (aggiornato al 27/06/2019) Le canzoni sono elencate in ordine alfabetico col nome del cantante che le ha rese famose e si intendono “CANTATE” dal vivo. Altre canzoni si possono inserire a richiesta. I repertori sono divisi per “Repertorio Davide”, “Repertorio Rossella”, “Repertorio in coppia”. Questi sono i brani che cantiamo come sottofondo. Poi però abbiamo molti altri brani come “Balli di gruppo”, “lenti”, “Dance Remix”, “liscio”, ecc (che troverete nella seconda metà di questo elenco). Repertorio Davide 883 – Medley (LUomoRagno, 6UnMito,NordSudOvestEst, RicordatiDiMe_AltaMarea) RottaXCasaDiDio, NellaNotte) Antonello Venditti – Notte prima degli esami 883 – Ci sono anch'io Antonello Venditti– Ogni volta 883 – Come mai Antonello Venditti– Sotto il segno dei pesci 883 – Eccoti Antonello Venditti– Stella 883 – Gli Anni (anche sola Chitarra Acustica) Antonello Venditti– Vento Selvaggio 883 – Grazie Mille ... e le altre a richiesta 883 – Io ci sarò Artisti Vari – Mix Anni 60 (La Fisarmonica, 883 – La Regina Del Celebrità UnOraSolaTiVorrei, IoChe non Vivo, CieloInUnaStanza, 883 – La Regola Dell'Amico NelBluDipintoDiBlu) 883 – Nessun rimpianto Barry Manilov – Mandy 883 – Nient'altro che noi Ben & king – Stand By Me (anche in versione Seal) 883 – Quello che capita Biagio Antonacci– Angela 883 – Senza Averti Qui Biagio Antonacci– Aprila 883 – Ti sento vivere Biagio Antonacci– Che differenza c'è 883 – Un giorno così Biagio Antonacci– Così presto no 883 ....le altre a richiesta Biagio Antonacci– Le cose che hai amato -

Lista Dal Nostro Repertorio Di Musica Dal Vivo – Controlla Le Novita’ Direttamente Sul Sito
SITO: WWW.MUSICADENTRO.IT – POSTA: [email protected] – TEL. 338 2692022 (Whatsapp) LISTA DAL NOSTRO REPERTORIO DI MUSICA DAL VIVO – CONTROLLA LE NOVITA’ DIRETTAMENTE SUL SITO ...PER CERCARE LA TUA CANZONE PREFERITA USA IL TASTO RICERCA DEL TUO LETTORE PDF E DIGITA UNA PAROLA I'M NOT IN LOVE 10CC WHAT'S UP 4 NON BLONDES BELLA VERA 883 - MAX PEZZALI CI SONO ANCH'IO 883 - MAX PEZZALI CISONOANCHIO 883 - MAX PEZZALI COME DEVE ANDARE 883 - MAX PEZZALI COME MAI 883 - MAX PEZZALI ECCOTI 883 - MAX PEZZALI GRAZIE MILLE 883 - MAX PEZZALI HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO 883 - MAX PEZZALI IL MONDO INSIEME A TE 883 - MAX PEZZALI IO CI SARÒ 883 - MAX PEZZALI LA REGOLA DELL’AMICO 883 - MAX PEZZALI LASCIATI TOCCARE 883 - MAX PEZZALI LO STRANO PERCORSO 883 - MAX PEZZALI L’UNIVERSO TRANNE NOI 883 - MAX PEZZALI NELLA NOTTE 883 - MAX PEZZALI NESSUN RIMPIANTO 883 - MAX PEZZALI NORD SUD OVEST EST 883 - MAX PEZZALI ROTTA PER CASA DI DIO 883 - MAX PEZZALI SEI UN MITO 883 - MAX PEZZALI SENZA AVERTI QUI 883 - MAX PEZZALI TE LA TIRI 883 - MAX PEZZALI TIENI IL TEMPO 883 - MAX PEZZALI UNA CANZONE D'AMORE 883 - MAX PEZZALI VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 - MAX PEZZALI ‘A CITTA’ E PULECENELLA AA.VV. (NAPOLI) COMME FACETTE MAMMETA AA.VV. (NAPOLI) DICITENCELLO VUJE AA.VV. (NAPOLI) FUNICOLI’ FUNICULA’ AA.VV. (NAPOLI) LA LUNA MEZZ’O MARE AA.VV. (NAPOLI) LUNA CAPRESE AA.VV. (NAPOLI) MALAFEMMENA AA.VV. (NAPOLI) MUNASTERIO E SANTA CHIARA AA.VV. (NAPOLI) NINI' TIRABUCIO' AA.VV. (NAPOLI) NUN E' PECCATO AA.VV. -

Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba Ba Bay 360
www.cristommasi.com Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba ba bay 360 Gradi MIDI Giorno di sole 360 Gradi MIDI Sandra 360 Gradi MIDI E poi non ti ho vista più 360 Gradi & Fiorello MIDI Anything 3T MIDI Spaceman 4 Non Blondes MIDI What's up 4 Non Blondes MIDI In da club 50 Cent MIDI Fotografia 78 Bit MIDI Andrà tutto bene 883 MIDI Bella vera 883 MIDI Chiuditi nel cesso 883 MIDI Ci sono anch'io 883 MIDI Come deve andare 883 MIDI Come mai 883 MIDI Con dentro me 883 MIDI Con un deca 883 MIDI Cumuli 883 MIDI Dimmi perchè 883 MIDI Eccoti 883 MIDI Favola semplice 883 MIDI Finalmente tu 883 MIDI Gli anni 883 MIDI Grazie mille 883 MIDI Il mondo insieme a te 883 MIDI Innamorare tanto 883 MIDI Io ci sarò 883 MIDI Jolly blue 883 MIDI La regina del Celebrità 883 MIDI La regola dell'amico 883 MIDI Lasciati toccare 883 MIDI Medley 883 MIDI Nella notte 883 MIDI Nessun Rimpianto 883 MIDI Nient'altro che noi 883 MIDI Non mi arrendo 883 MIDI Non ti passa più 883 MIDI Quello che capita 883 MIDI Rotta per casa di Dio 883 MIDI Se tornerai 883 MIDI Sei un mito 883 MIDI Senza averti qui 883 MIDI Siamo al centro del mondo 883 MIDI Tenendomi 883 MIDI Ti sento vivere 883 MIDI 1/145 www.cristommasi.com Tieni il tempo 883 MIDI Tutto ciò che ho 883 MIDI Un giorno cosi 883 MIDI Uno in pi 883 MIDI Aereoplano 883 & Caterina MIDI L'ultimo bicchiere 883 & Nikki MIDI Dark is the night A-Ha MIDI Stay on these roads A-Ha MIDI Take on me A-Ha MIDI Desafinado A.C. -

Lista 16 APRILE 2020
Fabio e Mirko - Basi Karaoke Lista aggiornata al 16 Aprile 2020 TITOLO ARTISTA (COGNOME-NOME) WAVES OF LUV (IN ALTO MARE) 2 BLACK SANDRA 360 GRADI WHAT'S UP 4 NO BLONDES AEREOPLANO 883 - CATERINA BELLA VERA 883 (PEZZALI MAX) CHIUDITI NEL CESSO 883 (PEZZALI MAX) COME DEVE ANDARE 883 (PEZZALI MAX) COME MAI 883 (PEZZALI MAX) CON UN DECA 883 (PEZZALI MAX) CREDI 883 (PEZZALI MAX) ECCOTI 883 (PEZZALI MAX) FAI COME TI PARE 883 (PEZZALI MAX) FINALMENTE TU 883 (PEZZALI MAX) GLI ANNI 883 (PEZZALI MAX) GRAZIE MILLE 883 (PEZZALI MAX) HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO- 883 (PEZZALI MAX) I COWBOY NON MOLLANO 883 (PEZZALI MAX) IL MIO SECONDO TEMPO 883 (PEZZALI MAX) IL MONDO INSIEME A TE 883 (PEZZALI MAX) IO CI SARO' (PEZZALI 883) 883 (PEZZALI MAX) L'ULTIMO BICCHIERE 883 (PEZZALI MAX) L'UNIVERSO TRANNE NOI 883 (PEZZALI MAX) LA DURA LEGGE DEL GOL 883 (PEZZALI MAX) LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA 883 (PEZZALI MAX) LA REGINA DEL CELEBRITA' 883 (PEZZALI MAX) LA REGOLA DELL'AMICO 883 (PEZZALI MAX) ME LA CAVERO' 883 (PEZZALI MAX) MEDLEY 883 883 (PEZZALI MAX) MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO 883 (PEZZALI MAX) NESSUN RIMPIANTO 883 (PEZZALI MAX) NIENT'ALTRO CHE NOI 883 (PEZZALI MAX) NON MI ARRENDO 883 (PEZZALI MAX) NORD SUD OVEST EST 883 (PEZZALI MAX) QUELLO CHE CAPITA 883 (PEZZALI MAX) QUELLO CHE COMUNEMENTE NOI 883 (PEZZALI MAX) RAGAZZO INADEGUATO 883 (PEZZALI MAX) RITORNERO' 883 (PEZZALI MAX) ROTTA PER CASA DI DIO 883 (PEZZALI MAX) SE TORNERAI 883 (PEZZALI MAX) SEI FANTASTICA 883 (PEZZALI MAX) SEI UN MITO 883 (PEZZALI MAX) SENZA AVERTI QUI 883 (PEZZALI MAX) SOPRAVVIVEREI 883 (PEZZALI MAX) TIENI IL TEMPO 883 (PEZZALI MAX) TORNO SUBITO 883 (PEZZALI MAX) UNA CANZONE D'AMORE 883 (PEZZALI MAX) VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 (PEZZALI MAX) WELCOME TO MAIAMI 883 (PEZZALI MAX) SEMPRE NOI 883 (PEZZALI MAX) - J-AX AMAPOLA (BEGUINE) AA.VV. -

Catalogo MIDI
M-LIVE CATALOGO COMPLETO MIDI - 29/09/2021 COMME FACETTE LA CAMMESELLA MEDLEY ESTATE 2018 - POR UNA CABEZA (TANGO AC/DC 1 MAMMETA LA CUCARACHA VOL.2 STRUMENTALE) BACK IN BLACK CONCERTO D'ARANJUEZ (INSTRUMENTAL) MEDLEY ESTATE 2019 - QUEL MAZZOLIN DI FIORI 10CC HIGHWAY TO HELL CORAZON DE MELON LA CUMPARSITA VOL.1 REGINELLA CAMPAGNOLA YOU SHOOK ME ALL NIGHT I'M NOT IN LOVE CU CU RRU CU CU (INSTRUMENTAL TANGO) MEDLEY ESTATE 2019 - ROMA NUN FA LA STUPIDA LONG PALOMA (ESPANOL) LA GELOSIA NON È PIÙ VOL.2 STASERA ACE OF BASE 2 DEUSTCHLAND UBER DI MODA MEDLEY FOX TROT - VOL.1 ROMA ROMANTIC MEDLEY ALL THAT SHE WANTS ALLES - DAS LIED DER LA GONDOLIERA MEDLEY FOX TROT - VOL.2 RUSTICANELLA (QUANDO 2 EIVISSA CRUEL SUMMER DEUTSCHEN (GERMANY LA MARSEILLAISE (INNO MEDLEY FOX TROT - VOL.3 PASSA LA LEGION...) OH LA LA LA LIFE IS A FLOWER HYMN) NAZIONALE FRANCIA) MEDLEY FOX TROT - VOL.4 SAMBA DE ORFEO 24KGOLDN FT. IANN DIOR LIVING IN DANGER DIMELO AL OIDO LA MONTANARA (VALZER MEDLEY FUNK - 70'S (INSTRUMENTAL) MOOD THE SIGN (INSTRUMENTAL TANGO) LENTO) INSTRUMENTAL SBARAZZINA (VALZER) 2BLACK FT. LOREDANA ACHEVERÈ DO BASI DE FOGO LA PALOMA MEDLEY GIRO D'ITALIA SCIURI SCIURI LUNA DE ORIENTE (SALSA) BERTÈ DON'T CRY FOR ME (INSTRUMENTAL) MEDLEY GRUPPI ANNI 70 - SHAME AND SCANDAL IN WAVES OF LUV (IN ALTO ARGENTINA LA PICCININA VOL.1 THE FAMILY (SKA ACHILLE LAURO MARE) DOVE STA ZAZÀ (INSTRUMENTAL POLCA) MEDLEY HULLY GULLY - VERSION) 1969 2UE EBB TIDE LA PIMPA (SIGLA RAI VOL.2 SICILIANA BRUNA C'EST LA VIE LA TUA IMMAGINE EL BARBUN DI NAVILI YOYO) MEDLEY HULLY GULLY - SILENT NIGHT (ASTRO DEL MALEDUCATA EL CUMBANCHERO LA PUNTITA VOL.3 CIEL) MARILÙ 3 (INSTRUMENTAL) LA VEDOVA ALLEGRA MEDLEY HULLY GULLY - SILENT NIGHT (DANCE ME NE FREGO EL GONDOLIER (INSTRUMENTAL VALZER) VOL.5 RMX) ROLLS ROYCE 360 GRADI ESPANA CANÌ LARGO AL FACTOTUM MEDLEY HULLY GULLY - SIORA GIGIA SOLO NOI BA BA BAY (INSTRUMENTAL PASO (FROM IL BARBIERE DI VOL.7 SOMEWHERE OVER THE ACHILLE LAURO FT.