Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Albanian Elections: the Never-Ending Story – Part 1: 2011 Local Elections Author: Endri Xhaferaj
Albanian Elections: The never-ending story – Part 1: 2011 Local Elections Author: Endri Xhaferaj Niente c'è di definitivo nel mondo, ma le cose meno definitive di questo mondo sono le vittorie elettorali. Nothing is definitive in the world, but the least definitive things of this world are the electoral victories Benito Mussolini, Scritti e discorsi, 1914/39 Introduction This article intends to be a first part of a diachronic comparative analyses between the local elections held on May 2011 and the general elections to be held on June 2013 in Albania. The comparative analyses will be performed by using the Qualitative Process Tracing Method. The Qualitative Process Tracing Method is defined as 'the systematic examination of diagnostic evidence selected and analyzed in light of research questions and hypotheses posed by the investigator. It can contribute decisively both to describing political and social phenomena and to evaluating causal claims.'(Collier 2011). Process-tracing has two fundamental characteristics: description and sequence. Careful description is a foundation of process tracing, a perspective emphasized by Mahoney (2010). Process tracing inherently analyzes trajectories of change and causation, but the analysis fails if the phenomena observed at each step in this trajectory are not adequately described. Hence, what in a sense is “static” description is a crucial building block in analyzing the processes being studied. On the other hand, process tracing gives close attention to sequences of all relevant variables. (Mahoney, ibidem). In this sense, what I try to point out, with regards to process tracing of Albanian elections, is to whether or not find on the 2013 Albanian general elections, the continuity of a series of peculiar elements, already verified in the 2011 local elections. -

How Has Been the Evaluation of Generated Information by Cell-Phone in Albania During 2010-2015?
European Journal of Research in Social Sciences Vol. 4 No. 1, 2016 ISSN 2056-5429 HOW HAS BEEN THE EVALUATION OF GENERATED INFORMATION BY CELL-PHONE IN ALBANIA DURING 2010-2015? Fatos Salliu, PhD (c) Science of Communication, at European University of Tirana Lecturer of “Rhetoric” and “Media presentation” subjects at University “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Journalist at ABC News & Tv Klan. ABSTRACT During these lately years Albania has been increasing the use of mobile services in an incredible way. Some of Internet World statistics rank Albania as one of the most developed countries in the region. Mobiles are becoming the most important devices for communication. This technology not only satisfies personal needs, but it also helps the community. Information generated by mobiles includes a very wide range of services related to health, education, environment, weather, products, transactions, entertainment, politic. The interaction with Internet has matched all massive communication ways to converge in a point, mobile media. From this aspect, “the third screen” seems to have eclipsed even Web by its self. Social fragmentation is making people consume more and more the Online Media. The traditional Media is not anymore, an information monopoly. The category of youths cooperates a lot with Mobile media. The major objective and purpose of this research is connected with the evolution of generated mobile information during these 5 years in Albania. Which are the factors for favoring or precluding it further? What politics should the government follow so all can have access in using it? The research is based on accumulated statistics from different authorities and specialized monitoring. -

Albanian Elections Observatory – First Draft
Albanian Elections Observatory Brief Issue No 3_June 19, 2013 Election Campaign, Party Strategies, Public Opinion Polls Introduction ELIAMEP’s South-East Europe Programme has recently established the Albanian Elections Observatory to closely monitor the political developments in Albania in the lead up to the country’s national elections, which will take place on June, 23 2013. This briefing note analyzes Albania’s election Albanian Election 2013 - Summary campaign which has entered its final phase in a tense political atmosphere and amidst mutual recriminations by the leaders of Type of Elections Parliamentary the two main parties. This brief will offer an overview of the Election Date 23 June 2013 political parties’ platforms and their respective strategies, while Start of Election 24 May 2013 Campaign giving special emphasis to their electoral pledges, which are too End of Election 21 June 2013 ambitious to be considered credible. In addition, this brief will Campaign deal with Albania’s EU integration, which is high on the Electoral Districts 12 electoral agenda, and the political consensus between Socialists Parliamentary Seats 140 and Democrats that recently led to the adoption of three laws Candidates 7,127 linked to the country’s EU membership. Finally, we present an Eligible Voters 3,271,885 overview of the main findings of the opinion polls on the Albanian elections that were conducted in recent months. Certified Political 68 Entities The Campaign Political parties 66 Intensive Campaigning and Deep Polarization Independent 2 Candidates The 30-day election campaign officially started on May 24 and Coalitions 2 has been dominated by the two main political parties – the ruling Democratic Party of Sali Berisha and the opposition Election Administration: Socialist Party of Edi Rama. -
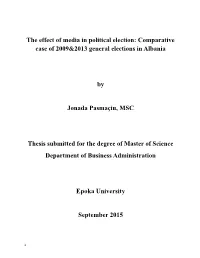
The Effect of Media in Political Election: Comparative Case of 2009&2013
The effect of media in political election: Comparative case of 2009&2013 general elections in Albania by Jonada Pasmaçiu, MSC Thesis submitted for the degree of Master of Science Department of Business Administration Epoka University September 2015 1 Approval Page Thesis Title : The effect of media in political election: Comparative case of 2009&2013 general elections in Albania Author : Jonada Pasmaçiu, Msc Qualification Master of Science Program Business Administration Department Business Administration Faculty : Economics and Administrative Sciences Thesis Date : September 2015 I certify that this thesis satisfies all the legal requirements as a thesis for the Master of Science (MSc) degree. (Title, Name and Signature) Head of Department I certify that I have read this study that is fully adequate, in scope and quality, as a thesis for the Master of Science (MSc) degree. Dr.Vusal Gambarov Supervisor Exam Board of Thesis 2 Thesis Title : The effect of media in political election: Comparative case of 2009&2013 general elections in Albania Author : Jonada Pasmaçiu, BA Qualification : Master of Science Date : September 2015 Members (Title, Name and Signature) ………………………. (Title, Name and Signature) ………………………. (Title, Name and Signature) ………………………. Abstract The aim of this thesis is about the influence that media has in peoples life but in this case it will see the influence that media has during the campaigns. How has media changed in Albania from communism period in democratic period? How this change has effected in peoples life? 3 Furthermore it will show what strategies are used during campaigns. How important is political marketing and media in the elections of 2009-2013? Although an analysis will be done for two main parties which are Democratic Party and Socialist Party and what marketing has they done during elections of 2009-2013. -

Manuscript Preparation for International Conference On
ICRAE2014 Conference- Paper Proceedings, ISSN: 2308-0825 TECHNOLOGY AND ELECTORAL CAMPAIGN: FROM SIMPLE POLITICS TO VIRTUAL POLITICS Rigels Xhemollari1 1Faculty of Political-Legal Science, Department of Justice, University “Aleksandër Moisiu", Durrës, Albania, E mail: [email protected] Abstract Recent electoral campaigns in Albania are following the trend of electoral campaigns in Eestern countries, where information technology and social networks have outpacing traditional methods of communication. Eager to introduce in Albania the latest technological practices borrweed from abroad, Albanian model comes with features and great misunderstandings. From rallies have passed on social networks, by contact with citizens have crossed in the virtual politics, from the need for transparency have passed in the exchange of selected information, from party newspapers propaganda move to tough political struggle in social networks. The paper analyzes these flows in recent campaigns, compares them with the practices of other countries and argues that this practice introduced in Albania risks misused to control information in other forms and that voters, more than candidate and the program is primarily to the choice of political image. The paper analyzes the MMB in CEC reports and reports of the OSCE, and other international institutions and appealing way and mechanisms how political parties to avoid drain of politics from citizen contact to virtual, and how information should be forwarded complete and impartial to citizens. One candidate is unable to stand 24 hours a day on social networks to communicate with voters and happens to not be really active but avoid direct communication with the citizen or someone else to be the response.