N. 14 COP 1,2,3,4 Prova 2.Ai
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ricerca E Confronti 2010 ATTI
Ricerca e confronti 2010 ATTI Giornate di studio di archeologia e storia dell’arte a 20 anni dall’istituzione del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-artistiche dell’Università degli Studi di Cagliari (Cagliari, 1-5 marzo 2010) Simona Campus Architetti e artisti per l’industrial design. Lo showroom Olivetti a New York ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte Supplemento 2012 al numero 1 Registrazione Tribunale di Cagliari n. 7 del 28.4.2010 ISSN 2039-4543. http://archeoarte.unica.it/ ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte (ISSN 2039-4543) Supplemento 2012 al numero 1 a cura di Maria Grazia Arru, Simona Campus, Riccardo Cicilloni, Rita Ladogana Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari Sezione di Archeologia e Storia dell’Arte Cittadella dei Musei - Piazza Arsenale 1 09124 CAGLIARI Comitato scienti!co internazionale Alberto Cazzella (Università di Roma La Sapienza); Pierluigi Leone De Castris (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli); Attilio Mastino (Università degli Studi di Sassari); Giulia Oro!no (Università degli Studi di Cassino); Philippe Pergola (CNRS - Université de Provence. Laboratoire d’archéologie médiévale méditerranéenne); Michel-Yves Perrin (École Pratique des Hautes Études); Antonella Sbrilli (Università di Roma La Sapienza); Mario Torelli (Accademia dei Lincei) Direzione Simonetta Angiolillo, Riccardo Cicilloni, Annamaria Comella, Antonio M. Corda, Carla Del Vais, Maria Luisa Frongia, Marco Giuman, Carlo Lugliè, Rossana Martorelli, Alessandra Pasolini, Fabio Pinna, Maria Grazia Scano, Giuseppa Tanda Direttore scienti!co Simonetta Angiolillo Direttore responsabile Fabio Pinna Impaginazione Nuove Gra!che Puddu s.r.l. in copertina: Il Castello di Cagliari nel 1358 Architetti e artisti per l’industrial design. -

1 Craft and the Birth of Post-War Italian Design
Macintosh HD:ROSSI 9780719089404 PRINT.indd / 9:3:AM - 08-12-2014 9:3:AM - 08-12-2014 / Macintosh HD:ROSSI 9780719089404 PRINT.indd 1 ✧ Craft and the birth of post-war Italian design Introduction N N OVEMBER 1950 Italy at Work: Her Renaissance in Design Today opened at New York’s Brooklyn Museum (see plate 1).1 Primarily I American conceived, funded and organised, Italy at Work aimed to boost Italy’s post-war reconstruction by presenting the nation’s hand- made wares to the American consumer. Despite the word ‘design’ in the title, craft materials and techniques dominated the two thousand five hundred exhibits (see figure 1.1) and the five room sets designed by architects including Carlo Mollino and Gio Ponti. Enjoying critical and popular acclaim, Italy at Work spent the next three years travelling to eleven other museums across North America, closing at the Museum of the Rhode Island School of Design in November 1953.2 In May 1951, just as Italy at Work was embarking on the second leg of its tour, the ninth Triennale di Milano esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura moderna (Milan Triennial International Exposition of Modern Decorative and Industrial Arts and Modern Architecture) (see plate 2) opened in Milan, with the theme L’unità delle arti (The Unity of the Arts). The Italian architect and artist organisers attempted to project a unified image of post-war modernity, but this was clouded by internal conflicts that reflected wider political turmoil. While industrial design was present, craft remained the main- stay of Italy’s exhibits, and both were given multiple roles by competing visions for the nation’s post-war future. -

From Architecture to Design and Back
Res Mobilis Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos Vol. 9, nº. 10, 2020 FROM ARCHITECTURE TO DESIGN AND BACK: THE ARCHITECTURAL ROOTS OF THE ITALIAN DESIGN SYSTEM, 1920-1980 DE LA ARQUITECTURA AL DISEÑO IDA Y VUELTA: LAS RAÍCES ARQUITECTÓNICAS DEL SISTEMA DE DISEÑO ITALIANO, 1920-1980 Elena Dellapiana* Politecnico di Torino Fiorella Bulegato Università IUAV di Venezia Abstract The histories of Italian design and architecture may be more readily understood if one considers that many of the protagonists are architect-designers. Identifying the root of this convergence in an academic and professional educational system based on the idea of the "complete architect", trained to work at any scale of design, this paper frames the work of the architect-designers within the cultural, economic and manufacturing context of the period between the 1920s and 1980s, when for historical reasons their role became particularly significant. Furthermore, many design historians in Italy are the product of the same education as the architects, and having followed the same course of studies as the architectural historians, they acquired the same techniques of investigation and interpretation, which they later refined in their own fields. The theme is thus explored from the perspectives of the two authors, both architects but with specific training one as an architectural historian, and the other as a design historian. The relationship between the two research directions – the theoretical debate and its narrations, the relationship between designers and manufacturers – makes it possible to clarify some of the aspects that distinguish the history of Italian design culture compared to that of other Western nations. -
Towards a Genealogy of the Thematic Contemporary Art
TOWARDS A GENEALOGY OF THE THEMATIC CONTEMPORARY ART EXHIBITION: ITALIAN EXHIBITION CULTURE FROM THE MOSTRA DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA, (1932) TO THE PALAZZO GRASSI’S CICLO DELLA VITALITÀ (1959-1961) STEFANO CAGOL A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the Royal College of Art for the degree of Doctor of Philosophy September 2013 The Royal College of Art ABSTRACT The goal of this thesis is to look at the emergence of the thematic contemporary art exhibition in Italy through an analysis of the influence of Fascism and the commercial sector in the three exhibitions composing the Cycle of Vitality, organised between 1959 and 1961 at the Centro Internazionale delle Arti e del Costume (CIAC), opened at the Palazzo Grassi in Venice in 1951. The cycle falls within the fields of both curatorial studies and the history of modern and contemporary exhibitions, two disciplines that have been developed since the 1990s. This inquiry contributes to them by clarifying further their specific fields of investigation, or in presenting alternative genealogies by casting light on overlooked antecedents; and by addressing the curator as a distinct cultural producer, the institution as a medium for social change and the history of exhibitions. The exhibitions analysed belong to the genealogy that resulted from the shift in the display language of international inter-war avant-garde experiments in exhibition design as manipulated by Fascism and commerce in the 1930s. Modernist architects were engaged in turning the exhibition into a medium for social change, and a mass-medium to bring a sense of the future into the present: It was from this premise that the model of the thematic exhibition emerged. -

Architecture and the Novel Under the Italian Fascist Regime
Architecture and the Novel under the Italian Fascist Regime Francesca Billiani Laura Pennacchietti Architecture and the Novel under the Italian Fascist Regime Francesca Billiani • Laura Pennacchietti Architecture and the Novel under the Italian Fascist Regime Francesca Billiani Laura Pennacchietti School of Arts, Languages and Cultures School of Arts, Languages and Cultures University of Manchester University of Manchester Manchester, UK Manchester, UK ISBN 978-3-030-19427-7 ISBN 978-3-030-19428-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-19428-4 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2019. This book is an open access publication. Open Access This book is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence and indicate if changes were made. The images or other third party material in this book are included in the book’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the book’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. -

Design Process Olivetti 1908-1983 DESIGN PROCESS
Design Process Olivetti 1908-1983 DESIGN PROCESS Renzo Zorzi 1. I should not like to get into too analytical a discussion on the different meanings this expression may have, depending on whether we press the pedal, as it were, of one or the other of the two words that make it up. More simply I'd say that by "design process" I mean both an attitude and a method. By attitude I mean the consideration of a problem in planning or design as a whole, and an approach to every single choice, in form and expression, in technology and economics which does not contradict this concept of wholeness and thus the complementary components of the complex mosaic, the sensitive image of the flow of an enterprise in motion. By method I mean dealing with each problem according to procedures that are specific to design, without fanciful innovations, escaping into unthinking "spontaneity" or rootless experimentation, and without going in the other direction toward mechanical and lifeless repetition. Understood in this two-fold but convergent, and in the end homologous meaning, the expression "design process" we might say embraces on the one hand the ensemble of qualities and technics necessary in planning, and on the other the determination of their actual application. Some, more than others — or more strictly and explicitly - have believed that the ensemble of images through which a reality is perceived and grasped is not dredged up from time to time from the infinite congeries of possible signs and of achievable hypotheses. It is selected, rather, according to criteria of predetermination and indivisible identity - the expression and almost the testimony of a need to be that will be attained only at the end of the process, or at an advanced stage of its development, in which willpower and creativity, necessity and innovation, rule and fantasy all come together. -

Download File
The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936-1972 Shantel Blakely Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2011 © 2011 Shantel Blakely All rights reserved ABSTRACT The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936-1972 Shantel Blakely The topic of this dissertation is the significance of industrial design in the work of architect Marco Zanuso (1916-2001), who lived and practiced in Milan, Italy. As a leading architect, as well as a pioneer in industrial design in the early postwar period, Zanuso was a key protagonist in the relationship of postwar Italian architecture culture to industrialization and capitalism. He is therefore an indicative figure with respect to the broader shift from Modernism to Postmodernism in architecture. Whereas previous studies of Zanuso have addressed either his architecture or his industrial design, this study traces the mutual influence of these practices in Zanuso's early work. The four chapters examine a selection of his projects to reconstruct their relationships to concurrent discourses in Italian art, architecture, and industry. In addition, the chapters show how these projects can be understood as conceptual and practical benchmarks along the way to the eventual realization of a continuum of design from small to large scale, and especially an architecture in which the serial nature of mass production would be explicit. The first chapter, whose topic is Zanuso's relationship to Italian modern architecture between the two World Wars, relates his embrace of mass-production around 1946, in essays on prefabricated architecture, to his student work in the 1930s and to his first projects during Reconstruction, emphasizing the influence of the Gruppo 7, Giuseppe Pagano, and Ernesto Nathan Rogers. -
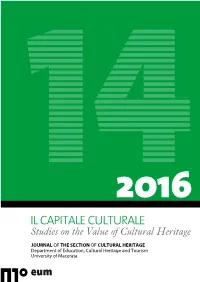
N. 14 COP 1,2,3,4 Prova 2.Ai
14 2016 IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage JOURNAL OF THE SECTION OF CULTURAL HERITAGE Department of Education, Cultural Heritage and Tourism University of Macerata Il Capitale culturale Fiorella Dallari, Stefano Della Torre, Maria Studies on the Value of Cultural Heritage del Mar Gonzalez Chacon, Maurizio De Vita, Vol. 14, 2016 Michela Di Macco, Fabio Donato, Rolando Dondarini, Andrea Emiliani, Gaetano Maria ISSN 2039-2362 (online) Golinelli, Xavier Greffe, Alberto Grohmann, Susan Hazan, Joel Heuillon, Emanuele Invernizzi, Lutz Klinkhammer, Federico © 2016 eum edizioni università di macerata Marazzi, Fabio Mariano, Aldo M. Morace, Registrazione al Roc n. 735551 del 14/12/2010 Raffaella Morselli, Olena Motuzenko, Giuliano Pinto, Marco Pizzo, Edouard Pommier, Carlo Direttore Pongetti, Adriano Prosperi, Angelo R. Pupino, Massimo Montella Bernardino Quattrociocchi, Mauro Renna, Orietta Rossi Pinelli, Roberto Sani, Girolamo Co-Direttori Sciullo, Mislav Simunic, Simonetta Stopponi, Tommy D. Andersson, Elio Borgonovi, Michele Tamma, Frank Vermeulen, Stefano Rosanna Cioffi , Stefano Della Torre, Michela Vitali Di Macco, Daniele Manacorda, Serge Noiret, Tonino Pencarelli, Angelo R. Pupino, Web Girolamo Sciullo http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult e-mail Coordinatore editoriale [email protected] Francesca Coltrinari Editore Coordinatore tecnico eum edizioni università di macerata, Centro Pierluigi Feliciati direzionale, via Carducci 63/a – 62100 Macerata Comitato editoriale tel (39) 733 258 6081 Giuseppe Capriotti,