Fondata Da Bruno Cartosio E Alessandro Portelli Ácoma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chief's File Cabinet
CHIEF’S FILE CABINET Ronny J. Coleman ____________________________________ They Died with Their Boots On Somewhere back in the 1950’s there was a movie made about the United States Cavalry called “They Died with Their Boots On”. As an avid follower of Saturday morning serials and anything starring John Wayne or Randolph Scott I recall going to see that movie. Some of the older generation may remember it. It is unlikely however that anybody below the age of 50 will. I don’t remember the specific plot. However, I do recall in the end a whole bunch of cavalry guys got wiped out by the Indians. The reason it happened is they did a whole bunch of stupid things. In the movie all of those guys were heroes. Yes, they died with their boots on. But being dead is a very limited reward for recognition. Recently, I got myself aligned with a system on the Internet that advises me of every line of duty death that occurs. And, it sure appears to be that fire fighters are still dying with their boots on too. Not unlike the Cavalry soldiers of the last century they are sallying forth into battle sometimes poorly lead and sometimes drastically under estimating the situation. Now that I think about it the main theme of the movie that I referred to in the previous chapters was General George S. Custer. The fight was the Little Big Horn and Custer’s Last Stand. Can we really afford more last stands at the scene of fires? I have read all the literature I can get my hands on, on fire fighters safety. -
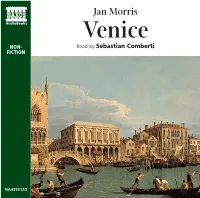
Venice NON- Read by Sebastian Comberti FICTION
Jan Morris Venice NON- Read by Sebastian Comberti FICTION NA435312D 1 Introduction by Jan Morris 8:19 2 Venice by Jan Morris read by Sebastian Comberti 6:43 3 So the Venetians became islanders... 5:00 4 Venice stood at the mouth of the great Po valley… 5:19 5 You can tell a Venetian by his face. 6:41 6 The Venetians always had an eager eye for a monopoly… 5:41 7 And among them all, the very image of Venice… 7:01 8 I once passed an idle breakfast... 6:22 9 Venice is a complicated place, physically and spiritually… 5:44 10 The women of Venice are very handsome, and very vain. 7:26 11 There are very few mortal children in the pictures… 4:29 12 There are, however, some gorgeous artificial horses. 5:30 13 Most people, though, will remember Venice as a city of birds. 5:06 14 There were magnificent regattas, and gymnastic competitions… 6:04 15 Half a century later another Patriarch of Venice became Pope… 5:16 16 The Venetians are not quite so religious as you might suppose… 6:58 17 If the Venetians are not always devout… 5:59 18 There are still about 800 Jews in Venice. 5:20 19 There are still Armenians in Venice too. 5:06 20 The Venetians have never quite re covered from their loss… 4:09 2 21 It was the end of an era... 5:08 22 Venice stands, as she loves to tell you... 7:13 23 The bridges of the lagoon have linked Venice… 4:44 24 A wonderful variety of boats has been developed… 4:41 25 Different indeed is the character of the gondola… 5:37 26 There are many houses in Venice that do not stand upon canals… 6:40 27 The early Venetian bridges were used by horses… 6:39 28 Several different kinds of policemen keep Venice safe… 4:14 29 Everybody dies in Venice. -

Editkings.Com | 323.658.5700 AFTERSHOCK DIGITAL 8222 MELROSE AVENUE SUITE #304 LOS ANGELES, CA 90046
FRITZ FEICK | EDITOR | www.editkings.com | 323.658.5700 AFTERSHOCK DIGITAL 8222 MELROSE AVENUE SUITE #304 LOS ANGELES, CA 90046 FEATURES DIRECTOR PRODUCER WHAT WOULD TREJO DO? Kevin Donovan Kevin Donovan Starring Danny Trejo THE TREASURE WITHIN Ryan McGinnis Fritz Feick Starring Robert Loggia, Melissa McGinnis CHE Josh Evans Robert Evans Starring Eduardo Noriega EXPIRED Cecilia Miniucchi Fred Roos, Jeffrey Coulter Official Selection, Cannes Film Festival (2007] Official Selection, Sundance Film Festival (2007) Starring Samantha Morton & Jason Patric SAVE THE LAST DANCE Thomas Carter Paramount Pictures Starring Julia Stiles & Sean Patrick Thomas BETWEEN David Ocanas David Oconas Nominated, Grand Jury Prize, Sundance Film Festival (2005) Starring Poppy Montgomery & Danny Pino OTIS E. Jeff Daniel Phillips Susan R. Rodgers Official Selection, Hollywood Film Festival (2009) Nominated, Best Feature, Noor Film Festival (2009) Starring Kevin Durand EVERYBODY DIES Josh Evans Image Entertainment “Memorable… echoes of Godard and Resnais.” –LA Weekly DARK STREETS Rachel Samuels Claus Clausen, Andrea Balen Starring Gabriel Mann, Bijou Phillips & Elias Koteas BETTER HOUSEKEEPING Frank Novak Modernica Pictures Winner, Grand–Jury Prize, Slamdance Film Festival (2000) Director’s Fortnight, Cannes Film Festival (2000) GACY – THE CRAWL SPACE Clive Saunders Peninsula Films LOS ANGELES Josh Evans Westlake Entertainment Starring Michael Madsen, Dick Van Patten THE ENDURING CALL Fritz Feick Aftershock Digital Gold Award, Houston Worldfest (2009) Official Selections: -

Sundance Institute Names Projects for Its Screenwriters Lab, Documentary Edit and Story Labs and New TheatreMakers Residency
FOR IMMEDIATE RELEASE Media Contact: June 8, 2016 Chalena Cadenas 310.360.1981 [email protected] Sundance Institute Names Projects for its Screenwriters Lab, Documentary Edit and Story Labs and New TheatreMakers Residency Concurrent Labs Provide Artists with Unique CrossDisciplinary Opportunities Encouraging Creativity with Different Storytelling Forms Los Angeles, CA — Sundance Institute has selected 25 projects to participate in its Screenwriters Lab, Documentary Edit and Story Labs and new TheatreMakers Residency, which will take place concurrently this summer in the mountains of the Sundance Resort in Utah. The confluence of these three artist development programs will provide Fellows the unprecedented opportunity to experience portions of the other Labs and will support a crosspollination of creativity and personal expression across different storytelling forms. Under the guidance of established creative advisors, screenwriters will participate in individualized story sessions exploring their workinprogress screenplays while documentary filmmakers in postproduction embark on a rigorous exploration of story, structure, and character development. At the TheatreMakers Residency, artists with plays not yet ready for actors will have the time and space to reflect on and develop their new work. Keri Putnam, Executive Director of Sundance Institute, said, “The unique gathering of independent voices, for the first time in a multiLab setting, allows our artists to collaborate across different creative -

The Roadkill Club a Full-Length Play
DUKE UNIVERSITY Durham, North Carolina The Roadkill Club A Full-length Play Valerie Muensterman June 10, 2020 Undergraduate Creative Writing Honors Thesis Trinity College of Arts and Sciences English Department Characters Nan A determined young woman who seems older than she is. A busybody by nature with obsessive tendencies. She is 28. Roy A spirited teenage girl. A seer and believer. She is turning 18. Dusty A simple man with a philosophical mind. He is disheveled, sloppy, and gentle. He is early 30s. Mack Grimm A fourteen-year-old boy with a steely-eyed glare. He appears ragged, dirty, dangerous. The Man A man in his fifties. He wears a rumpled, old-fashioned suit that is slightly too large for him and looks like it has been buried in the ground. Setting The present. A kitchen, connected to a porch, connected to an expanse of yard. In the kitchen, a table and four chairs. On the porch, a six-foot-long hope chest. It’s shaped like a coffin. The porch is surrounded by orange ditch lilies: plastic flowers in real dirt. The inside and outside blend together. Author’s Note There is little sarcasm in this play. The play works best when the characters are played with sincerity, and likewise, when irony is underplayed rather than overplayed. Scene One. Morning. Nan waters the ditch lilies with a pitcher of water. On the porch, the radio mumbles Willie Nelson’s “Sad Songs and Waltzes.” Roy, her younger sister, sits on the stoop, watching. ROY I feel so kin to ditch lilies. -

1 CONTEMPORARY MONOLOGUES Wild Abandon by Daniel Macivor (Canadian) STEVE One Time? I Was a Little Kid Like Nine – This Woman?
CONTEMPORARY MONOLOGUES MEN Wild Abandon by Daniel MacIvor (Canadian) STEVE One time? I was a little kid like nine – this woman? We were out in some stupid family rest-o-rant and everybody’s fighting in low voices and complaining about the food and that, and this woman, sitting over across at another table, she keeps looking at me, staring at me. I don’t say nothing and I start thinking: she’s really staring okay! And I start thinking: “Hey! This woman, she’s my real mother right. She followed me here. She’s been watching me for weeks and she’s my real mother and she’s gonna come over and say. “This boy is my son” and take me away from my stupid ugly family who won’t let me do nothing and never let me talk and never let me listen and won’t let me have a black room. She’s take me away and out into her new car – that smells new and – a convertible and – with the roof down and we’d drive far away to this house – this castle she lives in and I’d live there too and I’d have my own huge fucking room…So I’m thinking this and the woman, she gets up and starts walking over to me. I’m thinking: “HOLY SHIT! HOLY SHIT! It really IS my mother!” I got so nervous. She comes right up to me. Standing right there. I’m sitting down okay, she’s right there, and she reaches back…and jabs this fork into my stomach and starts screaming: “DEVIL’S EYES DEVIL’S EYES DEVIL’S EYES!” Black Rain by Lisa Rembzac JACK Ever since I can remember, people have been trying to tell me what to do; how to dress, how to talk…how to live my life. -

Download House Md Season 3 Episode 5
Download house md season 3 episode 5 House M.D. - Season 3: In this provocative and compelling season, House's unpredictable Scroll down. TV Series House M.D. season 5 Download at High Speed! Full Show Where to download House M.D. season 5 episodes? Episode 3. Watch House M.D. Season 3 Episode 5 Download in HD cause Foreman to ponder the strength of true love, and House abuses one too many patients with. and his team. House M.D. (season 1,2,3,4,5,6,7,8) download full episodes. Season 6 episode 22 is missing can this be uploaded please. House M.D. Season 3 Episode 4 Download S03E04 p, M. House M.D. Season 3 Episode 5 Download S03E05 p, M. House MD. Season 3 Episode 4 Lines in the Sand House MD. Season 3 Episode 5 Fools for Love House MD. Season 3 Episode 6 Que Será. The first episode of the Drama, Comedy, Mystery series House M.D. (season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) was released in by Fox. Watch House M.D. - Season 3 On Seriesonline, In this provocative and compelling season, Favorite Comment Report Download subtitle 10 Episode 9 Episode 8 Episode 7 Episode 6 Episode 5 Episode 4 Episode 3 Episode 2 Episode 1. Watch House M.D. - Season 3 Full Movie Online Free | Series9 | Gostream | Fmovies Favorite Comment Report Download subtitle 10 Episode 9 Episode 8 Episode 7 Episode 6 Episode 5 Episode 4 Episode 3 Episode 2 Episode 1. House M.d. Season 3 Episode 5 (s03e05) You can also download House M.d. -

1210 Transcript
A DAY WITH WALLY SAMPSON HERBAL HOPE ADJUSTING THE JOINTS NEEDLES AND NERVES HEALING TOUCH A DAY WITH WALLY SAMPSON ALAN ALDA (NARRATION) America the melting pot is also America the crossroads for ideas about healing. We have a huge range of alternatives for medical treatment available to us. That presents people like Wally Sampson with all kinds of difficulties. He's a retired oncologist and Stanford Medical School professor, but he's still hard at work. ALAN ALDA Hi. Good morning… WALLY SAMPSON Ah, good morning, Alan. Come on in. ALAN ALDA Thanks. ALAN ALDA (NARRATION) Wally started a journal to do what he says we all should - look at alternative medicine with a cool, scientific eye. But given human nature, that's easier said than done. ALAN ALDA I know people who started out thinking, for instance, that acupuncture was foolishness. I mean, how could there be these meridians in the body and Qi coursing through your body? How could needles have any effect on it? Then they got desperate because they're in pain. Then they went to an acupuncturist and felt relief from their symptoms. And they went from being highly skeptical to now recommending it to their friends. What happens there? What's going on there? WALLY SAMPSON That's a very deep experience for people. It's almost like having a transcendent or a religious discovery experience. When two events occur in close proximity, one beforehand is always interpreted as having something to do with the second one. Now the trick is to tell the difference between what really was the cause and what was the natural history of what was going to happen anyway. -

Everyone Dies When They Come to My House
LMU/LLS Theses and Dissertations Spring April 2017 Everyone Dies When They Come to My House David Techman Loyola Marymount University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lmu.edu/etd Part of the Screenwriting Commons Recommended Citation Techman, David, "Everyone Dies When They Come to My House" (2017). LMU/LLS Theses and Dissertations. 306. https://digitalcommons.lmu.edu/etd/306 This Thesis is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Loyola Marymount University and Loyola Law School. It has been accepted for inclusion in LMU/LLS Theses and Dissertations by an authorized administrator of Digital Commons@Loyola Marymount University and Loyola Law School. For more information, please contact [email protected]. Everyone Dies When They Come to My House Written by David Techman A thesis screenplay presented to the Faculty of the Department of the School of Film & Television Loyola Marymount University In partial fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Fine Arts in Screenwriting May 2017 EVERYBODY DIES WHEN THEY COME TO MY HOUSE Draft 5 Written by David Techman Based loosely on the writer's experience with various swing scenes. 414 High St. Staunton, VA 24401 Pennsylvania 6-5000--uh, I mean (757)-775-0727 FADE IN: EXT. DANCE STUDIO - NIGHT A three-story building. Mostly dark, although some light shines from the third-floor windows. Billie Holliday’s “Just the Way You Look Tonight” softly plays. SUPER: 1957 INT. DANCE STUDIO - NIGHT A empty wooden floor, chairs set around the walls. Only half the incandescent bulbs in the ceiling burn. -

Episode Guide
Last episode aired Monday May 21, 2012 Episodes 001–175 Episode Guide c www.fox.com c www.fox.com c 2012 www.tv.com c 2012 www.fox.com The summaries and recaps of all the House, MD episodes were downloaded from http://www.tv.com and processed through a perl program to transform them in a LATEX file, for pretty printing. So, do not blame me for errors in the text ^¨ This booklet was LATEXed on May 25, 2012 by footstep11 with create_eps_guide v0.36 Contents Season 1 1 1 Pilot ...............................................3 2 Paternity . .5 3 Occam’s Razor . .7 4 Maternity . .9 5 Damned If You Do . 11 6 The Socratic Method . 13 7 Fidelity . 15 8 Poison . 17 9 DNR ............................................... 19 10 Histories . 21 11 Detox . 23 12 Sports Medicine . 25 13 Cursed . 27 14 Control . 29 15 Mob Rules . 31 16 Heavy . 33 17 Role Model . 35 18 Babies & Bathwater . 37 19 Kids ............................................... 39 20 Love Hurts . 41 21 Three Stories . 43 22 Honeymoon . 47 Season 2 49 1 Acceptance . 51 2 Autopsy . 53 3 Humpty Dumpty . 55 4 TB or Not TB . 57 5 Daddy’s Boy . 59 6 Spin ............................................... 61 7 Hunting . 63 8 The Mistake . 65 9 Deception . 67 10 Failure to Communicate . 69 11 Need to Know . 71 12 Distractions . 73 13 Skin Deep . 75 14 Sex Kills . 77 15 Clueless . 79 16 Safe ............................................... 81 17 AllIn............................................... 83 18 Sleeping Dogs Lie . 85 19 House vs. God . 87 20 Euphoria (1) . 89 House, MD Episode Guide 21 Euphoria (2) . 91 22 Forever . -
Selected Video Screenings 2021
SELECTED VIDEO SCREENINGS 2021 "Everybody Dies!" carriage trade, New York, NY Experiments In Cinema 16.1, Albuquerque, NM Big Muddy Film Festival, Carbondale, IL Alchemy Film and Moving Image Festival, Hawick, Scotland, UK Moving Image Arts International Short Film Festival, Toronto, Ontario, CA Antimatter, Victoria, British Columbia, Canada Transient Visions, Johnson City, NY Social Photography lX, carriage trade, NY 2020 "Public Images" carriage trade, New York, NY Cine Club Split, Split, Croatia Social Photography Vlll, carriage trade, New York, NY Galeria Cortabitarte, Soria, Spain "Window Cinema", Canal Street Research Association, New York, NY 2019 57th Ann Arbor Film Festival, Ann Arbor, MI Experiments in Cinema v14.2, Albuquerque, NM Stockholm Animation and Experimental Film Festival, Stockholm, Sweden 40th Big Muddy Film Festival, Carbondale, IL London Experimental, London, UK Athens International Film and Video Festival, Athens, OH MicroActs, London, UK Cine Club, University of Guanajuato, Mexico Dallas Medianale, Dallas, TX "Social Photography VII”, carriage trade, New York, NY Barcelona International Short Film and Video Festival, Spain 2018 "Picture City lll" carriage trade, New York, NY "TR*MP TH*S", Experimental Response Cinema, Austin, TX "Millenium Film Journal No. 68", Anthology Film Archives, School of Visual Arts, New York, NY Swedenborg Film Festival, curated by Nora Foster (Frieze) and Gareth Evans (Whitechapel Gallery), London, UK Experiments in Cinema, Albuquerque, NM Bali International Short Film Festival, Bali, -
House Md Season 8 Full Episodes Online Free
House md season 8 full episodes online free click here to download A surprising visitor makes House an offer he can't refuse by givi Oct 10, Harsh Lighting. Episode 3: Charity Case. When Benjamin. A year has passed since House crashed his car into Cuddy's home, and we find House spending time behind bars at the East New Jersey Correctional Facility. Watch House M.D. - Season 8 online House M.D. - Season 8 Free movie House M.D. - Season 8 Streaming. House M.D. - Season 8 The final season of House M.D opens as House in jail after the events ''Moving On''. After two months in prison, he loses his job, his. Watch House M.D. - Season 8, House M.D. - Season 8 Full free movies Online HD. An antisocial maverick doctor who specializes in. House M.D. - S3 E7 - Son of Coma Guy. last year • 47K House M.D. - S 1 E 5 - Damned If You Do. last April House M.D. - S 8 E 11 - Nobody's Fault. last April. Watch House M.d.: Season 8 Online | house m.d.: season 8 | House M.d. Season 8 () | Director. Watch House Online: Watch full length episodes, video clips, highlights and more. All Free (22); All Paid () Season 8 (28) House M.D.: Love Is Blind still. When House returns to Princeton-Plainsboro Teaching Hospital from the prison, he finds WatchSeries House M.D. - Season 8 Episode Everybody Dies. House Season 8 Full House Episodes online watch them all online streaming website. SKS Plays House M. $ & FREE Shipping on eligible orders.