Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
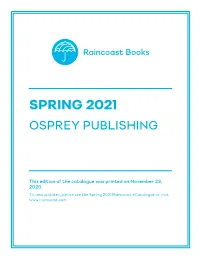
Spring 2021 Catalog
SPRING 2021 OSPREY PUBLISHING This edition of the catalogue was printed on November 23, 2020. To view updates, please see the Spring 2021 Raincoast eCatalogue or visit www.raincoast.com 21S Macm Osprey Page 1 of 42 Absolute Emperor Napoleonic Wargame Battles by Boyd Bruce A set of mass battle rules for wargaming in the Napoleonic Wars, allowing players to refight the battles that shaped Europe. From the late Revolutionary Wars and Egyptian campaign, to the battles of Austerlitz, Borodino, Leipzig and Waterloo, Absolute Emperor is a mass battle wargame that provides all the rules needed to play during this period of grand armies and sweeping campaigns. Players' armies are composed of multiple corps, with command and control being of the utmost importance, all influenced by the elan of your general. Do you follow in the footsteps of Napoleon and be crowned the Absolute Emperor or stand against tyranny as Wellington and Blucher. Author Bio Osprey Boyd Brucehas been a librarian, a soldier, a father, and a wargamer. Relying On Sale: May 25/21 upon his history degree, his love of books, his years of service, and a passion 7.24 x 9.76 • 64 pages for wargaming, he has made the transition from participant to instigator with 9781472843654 • $26.99 • pb Absolute Emperor . Playing all types of tabletop wargaming, Boyd's main History / Europe / General gaming interest will always be historical, with Napoleonic gaming holding a Series: Osprey Wargames favorite place in his heart. Notes Promotion - Online ads targeted on such gaming sites as BoardGameGeek -

Television Network Industry
Social Insights on the Television Network Industry © Brandwatch.com Contents 1.0 A FOREWORD ON TELEVISION NETWORKS ................................................................. 3 2.0 AIM & METHODOLOGY ....................................................................................................... 4 3.0 THE TELEVISION NETWORK SOCIAL PERFORMANCE INDEX .................................. 5 4.0 THE VOLUME OF CONVERSATION .................................................................................. 7 5.0 THE NETWORK-AUDIENCE RELATIONSHIP ................................................................ 11 5.1 WHERE: THE LANDSCAPE OF SOCIAL PLATFORMS �������������������������������������������������������������������� 11 5.2 WHEN: TIMING COMMUNICATION ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 5.3 WHAT: CONTENT FORMAT ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 5.4 WHO: THE DEMOGRAPHICS OF NETWORK AUDIENCES ������������������������������������������������������������� 18 6.0 TELEVISION NETWORKS IN REVIEW ............................................................................25 7.0 ABOUT BRANDWATCH .....................................................................................................26 Social Insights on the Television Network Industry © 2015 Brandwatch.com | 2 1.0 A Foreword on Television Networks Television networks are facing an unsettling transition. Innately linked to traditional -

SAG-AFTRA to Honor Finest Performances of 2014 at the 21 St
! SAG-AFTRA to Honor Finest Performances of 2014 st ® at the 21 Annual Screen Actors Guild Awards Simulcast Live on TNT and TBS on Sunday, Jan. 25, 2015, at 8 p.m. (ET) / 5 p.m. (PT) The 21st Annual Screen Actors Guild Awards®, one of the awards season’s premier events, will honor outstanding performances from 2014 in five film categories and eight television categories, including the distinctive ensemble awards. The coveted Actor® statuettes will be handed out at the Los Angeles Shrine Exposition Center during a live simulcast on TNT and TBS Sunday, Jan. 25, 2015, at 8 p.m. (ET) / 5 p.m. (PT). TNT will present a primetime encore of the ceremony immediately following the live telecast. The SAG Awards can also be viewed live on the TNT and TBS websites, and also the Watch TNT and Watch TBS apps for iOS or Android. (Viewers must sign in using their TV service provider user name and password). Of the top industry honors presented to performers, only the SAG Awards are conferred solely by actors’ peers in the Screen Actors Guild-American Federation of Television and Recording Artists (SAG-AFTRA). The SAG Awards was the first televised awards show created by a union to acknowledge the work of actors and the first to establish ensemble and cast awards. The presentation of this year’s SAG Awards marks the 18th telecast of this prestigious industry event on TNT and the ninth simulcast on TBS. This year's ceremony will be telecast internationally, as well as to U.S. -

Dressing in American Telefantasy
Volume 5, Issue 2 September 2012 Stripping the Body in Contemporary Popular Media: the value of (un)dressing in American Telefantasy MANJREE KHAJANCHI, Independent Researcher ABSTRACT Research perspectives on identity and the relationship between dress and body have been frequently studied in recent years (Eicher and Roach-Higgins, 1992; Roach-Higgins and Eicher, 1992; Entwistle, 2003; Svendsen, 2006). This paper will make use of specific and detailed examples from the television programmes Once Upon a Time (2011- ), Falling Skies (2011- ), Fringe (2008- ) and Game of Thrones (2011- ) to discover the importance of dressing and accessorizing characters to create humanistic identities in Science Fiction and Fantastical universes. These shows are prime case studies of how the literal dressing and undressing of the body, as well as the aesthetic creation of television worlds (using dress as metaphor), influence perceptions of personhood within popular media programming. These four shows will be used to examine three themes in this paper: (1) dress and identity, (2) body and world transformations, and (3) (non-)humanness. The methodological framework of this article draws upon existing academic literature on dress and society, combined with textual analysis of the aforementioned Telefantasy shows, focussing primarily on the three themes previously mentioned. This article reveals the role transformations of the body and/or the world play in American Telefantasy, and also investigates how human and near-human characters and settings are fashioned. This will invariably raise questions about what it means to be human, what constitutes belonging to society, and the connection that dress has to both of these concepts. KEYWORDS Aesthetics, Body, Dress, Falling Skies, Fringe, Game of Thrones, Identity, Once Upon a Time, Telefantasy. -

Primetime Series Returns for Season Two Sunday, August 6 on Hallmark Channel Part of Hallmark Channel's
Primetime Series Returns for Season Two Sunday, August 6 on Hallmark Channel Part of Hallmark Channel’s “Summer Nights” Programming Event Jesse Metcalfe, Meghan Ory, Treat Williams, Diane Ladd, Barbara Niven, Laci Mailey, Emilie Ullerup, Brendan Penny and Andrew Francis Star Gregory Harrison, Victor Webster and Jerry Trimble Guest Star in Season Two Hallmark Channel’s hit primetime series ‘CHESAPEAKE SHORES’ returns for Season Two Sunday, August 6 (9pm ET/PT, 8C) and runs through October 2017 with new episodes every Sunday night. Season one of “Chesapeake Shores” was the most-watched and most-successful series in Hallmark Channel’s history. Based on the novels of the same name by New York Times bestselling author Sherryl Woods, the series stars Jesse Metcalfe (“Dallas”), Meghan Ory (“Once Upon A Time”), Golden Globe® nominee Treat Williams (“Everwood,” “Hair”), Academy Award® nominee Diane Ladd (“Wild At Heart”), Barbara Niven (“Cedar Cove”), Laci Mailey (“Falling Skies”), Emilie Ullerup (“Sanctuary”), Brendan Penny (“Motive”) and Andrew Francis (“Final Destination 3”). Gregory Harrison (“One Tree Hill”), Victor Webster and Jerry Trimble guest star in season two. Season two of the multi-generational family drama “Chesapeake Shores” follows Abby O’Brien (Meghan Ory), a high-powered career woman, divorcee and mother to twin daughters, as she adjusts to life back in her hometown of Chesapeake Shores. Abby now balances a budding relationship with her former high school sweetheart, Trace (Jesse Metcalfe), working for a firm that does business with her uncompromising father Mick (Treat Williams) and raising two young daughters. Returning to her hometown means engaging in the lives of her siblings: Jess (Laci J. -

Falling Skies” Season 5, Episode 3: “Hatchlings” Review by Sam Totten - Jul 21, 2015
“Falling Skies” Season 5, Episode 3: “Hatchlings” Review By Sam Totten - Jul 21, 2015 Alien-human hybrids, biological weapons, romance, tragedy, death and torture. What is really going on in this show? It seems like “Falling Skies” is pulling out all the stops for its final season. When we last left the 2nd Mass, they had stumbled upon a massive field full of alien hornets. What’s more, we also learned that the Skitters are using human DNA to make full-fledged Skitter-human hybrids biologically. The Espheni are nd really stepping up their game—is there any hope for the 2nd Mass? For a full recap of Episode Two, click here. The theme for the third episode, “Hatchlings,” was humanity. Humanity was especially a main factor in the brother-sister duo recently taken in by the 2nd Mass: Caitlyn and Brian. Brian has been recently Skitterized; however, he still maintains his human eyes. Even though Brian was locked up, Caitlyn pleaded his human self was trapped inside along with his ability to empathize. Later on in the episode, Brian escaped, abducting his sister in the process. Tragically, Brian accidentally killed his sister after she jumped in front of Maggie to take a bullet. In turn, Brian pulled the trigger on himself. This begs the question: was Brian aware of his actions? Did he know what he was doing? Was he able to empathize? Another test of human nature was shown when Anthony was left alone with the Skitter Overlord—and needless to say, he failed. After Denny’s death, Anthony went on a torture rampage toward the enemy. -

2015 Pilot Production Report
Each year between January and April, Los Angeles residents observe a marked increase in local on-location filming. New television pilots, produced in anticipation of May screenings for television advertisers, join continuing TV series, feature films and commercial projects in competition for talent, crews, stage 6255 W. Sunset Blvd. CREDITS: space and sought-after locations. 12th Floor Research Analysts: Hollywood, CA 90028 Adrian McDonald However, Los Angeles isn’t the only place in North America Corina Sandru hosting pilot production. Other jurisdictions, most notably New Graphic Design: York and the Canadian city of Vancouver have established http://www.filmla.com/ Shane Hirschman themselves as strong competitors for this lucrative part of @FilmLA Hollywood’s business tradition. Below these top competitors is FilmLA Photography: a second-tier of somewhat smaller players in Georgia, Louisiana Shutterstock and Ontario, Canada— home to Toronto. FilmL.A.’s official count shows that 202 broadcast, cable and digital pilots (111 Dramas, 91 Comedies) were produced during the 2014-15 development cycle, one less than the prior year, TABLE OF CONTENTS which was the most productive on record by a large margin. Out of those 202 pilots, a total of 91 projects (21 Dramas, 70 WHAT’S A PILOT? 3 Comedies) were filmed in the Los Angeles region. NETWORK, CABLE, AND DIGITAL 4 FilmL.A. defines a development cycle as the period leading up to GROWTH OF DIGITAL PILOTS 4 the earliest possible date that new pilots would air, post-pickup. DRAMA PILOTS 5 Thus, the 2013-14 development cycle includes production COMEDY PILOTS 5 activity that starts in 2013 and continues into 2014 for show THE MAINSTREAMING OF “STRAIGHT-TO-SERIES” PRODUCTION 6 starts at any time in 2014 (or later). -

Stronghold Cities. Dystopian Fears in Utopian Asylums in Audiovisual Narratives
The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series7 (1/2018): 77–94 [article] DOI: 10.4467/24506249PJ.18.004.9778 Stronghold Cities. Dystopian Fears in Utopian Asylums in Audiovisual Narratives Ksenia Olkusz Abstract In the past few years there has been a growing interest in depicting permanently sieged strongholds, secluded last stands, or quarantined asylums within a post-apocalyptic world so as to strengthen the sense of the ultimate isolation and disconnection from the desolated world outside. The majority of those narratives share a similar world-model, featuring an over-crowded, fortified refuge and its ruler turning auto- pian sanctuary into a dystopian confinement. This means that the soci- ety in such a world faces two actual threats: one imminent, be it a zom- bie apocalypse, bands of scavengers, or epidemic that forces people to take refuge – and the other one, concealed, which reveals itself when everything seems to be under control. Keywords: dystopia, game, movie, narrative, utopia Ksenia Olkusz is a literary historian, critic, and theorist; she is as- sistant professor at the head of Facta Ficta Research Centre in Kraków as well as editor-in-chief of open access Facta Ficta Journal (factaficta- journal.com); she has authored books Współczesność w zwierciadle hor- roru. O najnowszej polskiej literaturze grozy [The Contemporaneity in the Mirror of Horror: On the Newest Polish Gothic Fiction] (2010) and Ma- terializm kontra ezoteryka: drugie pokolenie pozytywistów wobec “spraw nie z tego świata” [Materialism versus Esotericism. The Second Gener- ation of Polish Positivists and the Otherworldly] (2017) as well as ed- ited volumes Zombie w kulturze [Zombies in Culture] and Światy grozy [Worlds of Terror] (2016), and also More After More. -

AUDIO LOVER's GUIDE to Falling Skies
AUDIO LOVER’S GUIDE TO Falling Skies: The Complete First Season The Most Memorable Audio Moments as Selected by Rick Steele and Michael Graham “Our goal is to make the sounds dramatic, emotional, say something. And Rick [Steele] is a master at that, coming up with different sounds to make people feel something.” —Michael Graham Michael Graham Rick Steele Sound Supervisor Sound Designer Hiding from Mechs and Skitters (Episode 1: “Live and Learn” – 2:25–4:56) While Tom and Hal are looking for food, they are attacked by mechs and skitters. They hide in a store for safety. Listen for: Animal sounds as the skitters talk Skitter Getting Shot and Dying Tom Defeats the Skitter (Episode 1: “Live and Learn” – 31:42–35:38) (Episode 3: “Prisoner of War” – 19:52–21:16) Tom leads a group of resistance fighters on a food run. In the Tom and his crew are scouting out the group of harnessed kids process, his son Hal catches sight of his missing brother, Ben, that includes his captured son, Ben. In the process, Tom has to walking with a group of harnessed kids in the same direction as face down a skitter one-on-one. He shoots a couple of legs off the the Second Massachusetts regiment. Hal wants to go after him, skitter and beats it into unconsciousness. but Tom convinces him otherwise. The resistance fighters instead enter a warehouse, find food, blow up a mech, and shoot a skitter. Listen for: The reverberation of the huge mech feet As the resistance fighters stare down at the dying skitter, there is a The staccato of the skitter feet terse, bleakly funny -
Volunteers Make Clean Sweep of River Frank Lewis Got a Lot That We Can Pick Up.” Mouth Municipal Court
A1 LOG ONTO WWW.PORTSMOUTH-DAILYTIMES.COM FOR ARCHIVE • GAMES • FEATURES • E-EDITION • POLLS & MORE 60422658 Serving the Ohio Valley since 1852. INSIDE STORY WEATHER SPORTS ONLINE Freedom Hall Mostly cloudy. Baseball heats up Busy? Check project moving High of 86. Low in Gene Bennett us out online, forward.... Page A6 of 67..... Page A3 Classic.... Page B1 anytime at: portsmouth-dailytimes.com Vol. 162, No. 25 SUNDAY, JUNE 16, 2013 $1.50 Sunday Volunteers make clean sweep of river Frank Lewis got a lot that we can pick up.” mouth Municipal Court. PDT Staff Writer Crippen said a lot of people “The charges against these made the River Sweep possible, people range from driving under Plastic bags in hand, a group including the Coca-Cola com- suspension to small petty thefts, of kids from Hillbilly Kids 4-H pany for providing refreshments, minor things like that,” Kyle Mc- Club head west and community Jane Kitts in the Scioto Coun- Cain from Portsmouth Municipal service workers from Ports- ty Commissioners Office, the Court said. “The come out here mouth Municipal Court head Scioto County Commissioners, and perform community service. east in search of litter along the Dan Palmer of the Solid Waste In lieu of going to jail our judges banks of the Ohio River Satur- District, Miller’s Gas Station for sentence people to community day morning. Clean Sweep 2013 donating the ice, Phil Malone for service to help keep population was officially underway. creating posters for the program, down at the (Scioto County) jail.” “We’re going to try to pick up and Mark Thacker and Danny Co- McCain said a lot of thanks as much of this river bank as we pley, manning the other two sites should go out to the state for a can,” Jeff Crippen of Scioto Coun- involved in the sweep. -

Falling Skies Volume 2: the Battle of Fitchburg Free
FREE FALLING SKIES VOLUME 2: THE BATTLE OF FITCHBURG PDF Paul Tobin,Danilo Beyruth,Mark Verheiden,Patric Reynolds,Juan Ferreyra,Scott Allie | 136 pages | 16 Oct 2012 | DARK HORSE COMICS | 9781616550141 | English | Milwaukee, United States Falling Skies: The Battle of Fitchburg (Volume) - Comic Vine The Battle of Fitchburg is a web comic released on fallingskies. It takes place four weeks after Falling Skies Volume 2: The Battle of Fitchburg end of Season 1 and it consists of Falling Skies Volume 2: The Battle of Fitchburg chapters online, and four chapters in the paperback. Catastrophe approaches as Dai makes it back to camp, only to deliver bad news … news that could lead to a final stand for the Second Mass. Uncle Scott and many others fight for their lives as Anne and Lourdes look on helplessly. None of them is aware of what the patrol team has uncovered and the peril they are really in. The enemy is closing in and the situation is desperate. Can they survive their mission … and can Weaver survive his decision to send them? He gives Pope the green light. When the town is too quiet and the retreat too easy, Weaver gets suspicious. Pope and his Berserkers unite with the rest of the 2nd Mass, only to find that themselves outmanned and outgunned by a surrounding group of skitters and mechs. The situation looks hopeless—will anything of the 2nd Mass survive when the latest battle is over? The saga of The Battle of Fitchburg comes to a close as the 2nd Mass makes what could be their last stand against the alien invaders. -

Falling Skies by Paul Tobin , Juan Ferreyra , Andrew Dalhouse (Artist)
Read and Download Ebook Falling Skies... Falling Skies Paul Tobin , Juan Ferreyra , Andrew Dalhouse (Artist) PDF File: Falling Skies... 1 Read and Download Ebook Falling Skies... Falling Skies Paul Tobin , Juan Ferreyra , Andrew Dalhouse (Artist) Falling Skies Paul Tobin , Juan Ferreyra , Andrew Dalhouse (Artist) In the heart of Boston, following the devastating events of an alien invasion, history professor Tom Mason and his sons meet up with the 2nd Mass, a militia group determined to wipe out the aliens. But with the militia's supplies running low, Tom must locate an old friend to equip him and his team in order to ensure the survival of the human race! * Falling Skies is from DreamWorks Television and stars Noah Wyle * Falling Skies Details Date : Published June 28th 2011 by Dark Horse Books (first published June 14th 2007) ISBN : 9781595827371 Author : Paul Tobin , Juan Ferreyra , Andrew Dalhouse (Artist) Format : Paperback 104 pages Genre : Sequential Art, Graphic Novels, Science Fiction, Fiction, Graphic Novels Comics, Aliens Download Falling Skies ...pdf Read Online Falling Skies ...pdf Download and Read Free Online Falling Skies Paul Tobin , Juan Ferreyra , Andrew Dalhouse (Artist) PDF File: Falling Skies... 2 Read and Download Ebook Falling Skies... From Reader Review Falling Skies for online ebook Andrienne says Falling Skies reminded me of "War of the Worlds." It had a dad and his children running for their lives from aliens. It had a good pace, interesting characters, and good action sequences. It held my attention especially regarding the mystery surrounding the kids being taken and harnessed. Denise says I've been marathon re-watching Falling Skies over the past few days and figured I'd have a look whether there might be something readable available as well.