Piano Regionale Dei Trasporti E Della Mobilità
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lo Stato Di Attuazione Del Programma
XVII LEGISLATURA servizio studi LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Dalla “legge obiettivo” alle opere prioritarie XVII LEGISLATURA servizio studi Lo stato di attuazione del Programma 10° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione n. 234 - 2016 servizio studi XVII LEGISLATURA servizio studi LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Dalla “legge obiettivo” alle opere prioritarie Lo stato di attuazione del Programma 10° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione n. 234 parte seconda - maggio 2016 Documentazione e ricerche: Le infrastrutture strategiche - Dalla “legge obiettivo” alle opere prioritarie” – 10° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici: - Nota di sintesi e focus tematici, n. 234 Parte prima, maggio 2016; - Lo stato di attuazione del Programma, n. 234 Parte seconda, maggio 2016. Il presente Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 29 luglio 2015, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Istituto di ricerca CRESME. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Ambiente 066760-9253 [email protected] CD_ambiente INDICE CAPITOLO PRIMO Evoluzione del Programma e scenari di riferimento 1 1.1. -
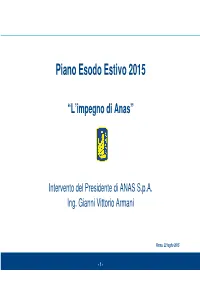
(Microsoft Powerpoint
Piano Esodo Estivo 2015 “L’impegno di Anas” Intervento del Presidente di ANAS S.p.A. Ing. Gianni Vittorio Armani Roma, 22 luglio 2015 - 1 - Il Piano Esodo 2015 è elaborato da Anas in collaborazione con: - 2 - Cosa vuole chi viaggia GLI ITALIANI IN VACANZA Vedere risolte le difficoltà Ricevere assistenza e le emergenze ed aiuto nei casi nel più breve di problemi tempo possibile meccanici o in caso di necessità Un viaggio sicuro, Essere informato senza difficoltà sul traffico - 3 - Le risposte di Anas • Risolvere le emergenze di viabilità: Viadotto Italia della A3 • Monitorare 24 ore su 24 il traffico sulla rete stradale nazionale dedicando risorse e mezzi • Individuare e ridurre i cantieri presenti sulla rete stradale autostradale di competenza, in particolare sugli itinerari dell vacanze • Predisporre, ove possibile, un piano di viabilità alternativ in corrispondenza dei cantieri inamovibili e comunque di gestion delle criticità • Predisporre - assieme agli altri attori della mobilità - il calendari del traffico con i “giorni critici” • Predisporre il piano di comunicazione per i viaggiator rafforzando i canali di informazione - 4 - Il monitoraggio e le risorse umane 1 Sala Operativa Nazionale (in funzione h24) 20 Sale Operative Compartimentali In turnazione, circa 2.500 addetti per la sorveglianza, il pronto intervento, l’assistenza ai clienti, il coordinamento delle attività tecniche e di gestione e la comunicazione 1070 automezzi, 1800 telecamere, 300 pannelli a messaggio variabile - 5 - Il monitoraggio dei tratti critici A3 Salerno-Reggio -

Rassegna Stampa Di G [Orno
Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE RASSEGNA STAMPA DI G [ORNO 14-4-2017 A cura di Sandro Cuzari Responsabile Ufficio Stampa CAS Quotidiano Data 14-04-2017 GIORNALE DI SICILIA Pagina 1 +4/5 PALERMO ePROVINCIA Foglio 1/3 LA BUFERA SUI CAS. I «furbetti dell'incentivo» I FURBETTI DELL'INCENTIVO Autostrade & affari ILSISTEMA PER POTER SPARTIRE UN MILIONE £300 MILA EURC Ecco tutti i lavori Una «miniera» finiti sotto inchiesta SULLA MESSINA-PALERMO dalle autostrade, IN CODA PER I TANTI CANTIERI ANSALONI E BARBERA ALLE PAGINE 4 E 5 così il Consorzio accontentava tutti O Nelle carte dell'inchiesta l'elenco dei lavori «fantasma» Liquidati 32.944 euro per un progetto della Siracusa-Gela Altri 35.262 per uno spartitraffico della Messina-Catania recati negli uffici del consorzio auto- 2012 riguarda i lavori per il ripristino stradale per chiedere quali fossero i delle barriere di sicurezza danneggia- Letìzia Barbera progetti a sostegno di quegli incentivi te a seguito di incidenti lungo la Messi- MbSSINA mainaicunicasi nonhanno trovato al- na-Palermo. L'incentivo complessi- •••II ripristino di barriere a seguito di cun progetto che potesse giustificare vamente liquidato fu dÌ33.128euro. La incidenti stradali, la stabilizzazione di quegli incentivi mentre in altri casi i documentazione a supporto risulta frane, le opere per rimuovere condi- progetti c'erano ma, sulla scorta di una assente. Il decreto 201 del 2012 riguar- zioni di pericolo lungo i Eratti autostra- consulenza tecnica, sono risultati dava lavori di manutenzione straordi- dali, lavori di manutenzione agli im- mancanti di alcuni documenti. naria di rifacimento della pavimenta- pianti elettrici e di pavimentazione. -

Allegato "A" Al D.D.G. N° 968 Del 26/10/2020 - Elenco Sedi Disponibili Per Il 3° Interpello
Allegato "A" al D.D.G. n° 968 del 26/10/2020 - Elenco sedi disponibili per il 3° interpello DESCRIZIONE N. PROGRESSIVO DESCRIZIONE DELLA SEDE TIPO SEDE CRITERIO TOPOGRAFICO PREVISTA INDENNITA' DESCRIZIONE PROVINCIA CODICE ISTAT COMUNE COMUNE COMUNE FARMACEUTICA FARMACEUTICA DELLA SEDE FARMACEUTICA DI AVVIAMENTO Campobello di Comprende le frazioni di "Tre Fontane" e Trapani 81004 4 Vacante SI NO Mazara "Torretta Granitola". Zona di Sperone interessando le vie: Assieni da Piazza Sperone, fino alla intersezione con la Via Zara, Via Sperone e Scucina fino all'intersezione NO NO Trapani 81007 Custonaci 2 con Via Zara, Via S. Vito, da Piazza Sperone fino Di nuova istituzione alla Via Valderice. Zara e traverse, S. Vito e traverse fino all'intersezione di Via Valderice. Trapani 81009 Favignana 3 Isola di Marettimo Vacante NO SI Trapani 81011 Marsala 21 C.de Bosco-Pecorume, Ciappola e Dara. Di nuova istituzione NO NO Quartiere "Mazara 2" - con l'esclusione del tratto NO NO Trapani 81012 Mazara del Vallo 14 Via Degli Archi. Di nuova istituzione Zona Trasmazzaro/Tonnarella - tratto di Via del Mare (dal Lungomare Fata Morgana a Via NO NO Trapani 81012 Mazara del Vallo 15 America), Via America, con esclusione del tratto Di nuova istituzione di Via Bessarione. Zona Bocca Arena/Falcone-Borsellino - Via California, tratto della Via Napoli (da Via California a Via Belluno), Via Belluno, Strada Provinciale Mazara - Torretta Granitola (da Via NO NO Trapani 81012 Mazara del Vallo 16 California fino al confine del Comune di Di nuova istituzione Campobello, ed agglomerato urbano di Torretta Granitola, con l'esclusione del tratto Lungomare San Vito e tratto Viale Africa). -

Industria Di Marca Distribuzione Moderna
INDUSTRIA DI MARCA | DISTRIBUZIONE MODERNA Mappatura Offerta di Trasporto Ferroviario Novembre 2016 Indice1 ECR Italia .............................................................................................................................. 6 Introduzione .......................................................................................................................... 7 Imprese ferroviarie ................................................................................................................ 8 *Captrain Italia S.r.l. ............................................................................................................................. 8 ChemOil Logistics AG – Filiale Italiana .............................................................................................. 10 Compagnia Ferroviaria Italiana .......................................................................................................... 11 DB Schenker Rail Italia Services S.r.l. ............................................................................................... 12 *ERS Railways B.V. ........................................................................................................................... 13 Nordcargo S.r.l. .................................................................................................................................. 15 Oceanogate Italia S.p.A. .................................................................................................................... 16 Rail Cargo Italia S.r.l. ........................................................................................................................ -

Partiamo Dopo Pranzo, Circa Alle 15, Ed Entriamo Nell'autostrada A1 Da Arezzo in Direzione Sud, Verso Civitavecchia Dove Ci As
Partiamo dopo pranzo, circa alle 15, ed entriamo nell’autostrada A1 da Arezzo in direzione sud, verso Civitavecchia dove ci aspetta il traghetto. Usciamo quindi ad Attigliano, in quanto vi erano code per uscire ad Orte, ed entriamo dentro Bomarzo. Ci fermiamo poco dopo il paese per una pausa, e riprendiamo la strada, entrando così nella SS675 in direzione Viterbo. Dopo Vetralla la 4 corsie finisce e prendiamo così la SS1bis, che ci conduce fino a Tarquinia, lungo la quale i molti cantieri fanno pensare ad un allungamento della 4 corsie verso il mare. Qui prendiamo l’A12 ed usciamo a Civitavecchia Porto, da dove con la E840 arriviamo al porto. Siamo in anticipo, e dopo svariati tentativi nella ricerca del cartello con scritto Termini Imerese, ci viene indicato che quello giusto è per Tunisi. Ci mettiamo così in coda aspettando che venga aperto il cancello per entrare nell’area d’imbarco, ma al momento dell’apertura ci viene detto che prima dobbiamo fare il check-in, ossia cambiare il biglietto acquistato online con quello effettivo, che noi ovviamente non sapevamo. Possiamo così entrare nell’area d’imbarco, e mangiando i nostri panini aspettiamo di essere chiamati per salire sulla nave. Al nostro momento veniamo fatti salire nel piano superiore, al garage D, e da qui una volta parcheggiato il camper possiamo salire a bordo. Ci vengono consegnate le chiavi per la cabina, che troviamo subito, dopo aver individuato con un po’ di difficoltà il terzo letto, andiamo a visitare il traghetto GNV. Andiamo subito sopra, da dove vediamo il tramonto sul mare e l’Argentario, e Civitavecchia che pian piano entra nella notte, intanto parte un traghetto Tirrenia per la Sardegna. -

BILANCIO 2019 RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 Anas S.P.A
BILANCIO 2019 RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) Capitale Sociale: euro 2.269.892.000,00 i.v. Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma Codice Fiscale e Registro delle Imprese: 80208450587 R.E.A.: 1024951 Partita IVA: 02133681003 Sito web: www.stradeanas.it Umbria – Direttrice Perugia-Ancona, strada statale 318 ‘di Valfabbrica’ Anas Bilancio 2019 Anas Bilancio 2019 MISSIONE DELLA SOCIETÀ ORGANI SOCIALI Anas S.p.A. gestisce la rete stradale e autostradale italiana non a pedaggio di interesse nazionale ed è sottoposta Consiglio di Amministrazione*: al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie al Presidente Dott. Claudio Andrea Gemme notevole bagaglio di esperienza accumulato in oltre 90 anni di attività e alle competenze del personale, Anas Amministratore Delegato Ing. ha ampliato la gamma dei servizi offerti, svolgendo attività di supporto agli enti pubblici e offrendosi come Massimo Simonini elemento catalizzatore in Italia e all’estero nei servizi di progettazione, costruzione e manutenzione della rete Consigliere Arch. Ivo Roberto Cassetta viaria. Consigliere Dott.ssa Vera Fiorani L’impegno della Società nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture stradali si concentra Consigliere Avv. Antonella D’Andrea sulla sicurezza della rete, tutela dell’ambiente, efficienza energetica nonché sulla salvaguardia del patrimonio paesaggistico del nostro territorio. L’obiettivo di Anas è quello di garantire la realizzazione del Contratto di Programma, nel rispetto dei tempi e Collegio Sindacale**: dei costi preventivati, la continuità territoriale della rete e una viabilità sempre più sicura ed efficiente, anche Presidente Dott.ssa Antonella Bientinesi attraverso lo studio e l’uso di tecnologie innovative. -

Bilancio D'esercizio Al 31 Dicembre 2018
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetto all’attività di direzione e coordi- namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) Capitale Sociale: euro 2.269.892.000,00 i.v. Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma Codice Fiscale e Registro delle Imprese: 80208450587 R.E.A.: 1024951 Partita IVA: 02133681003 Web address: www.stradeanas.it Direttrice Perugia-Ancona, strada statale 318 “di Valfabbrica” ANAS BILANCIO 2018 MISSIONE DELLA SOCIETÀ opere. Anas ha fatto della qualità uno dei pilastri della sua attività e della tecnologia un mezzo importante per garantirla. A questo proposito il Centro sperimentale stradale di Cesano è il punto di riferimento scientifico, tecnico e di supporto per tutte le attività di costruzione e manutenzione delle infrastrutture e certifica le norme tecniche e i criteri di qualità nella realizzazione Anas S.p.A. gestisce la rete stradale e autostradale italiana non a pedaggio di interesse nazionale ed è sottoposta al controllo dei nuovi interventi. e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie al notevole bagaglio di esperien- za accumulato in oltre 90 anni di attività e alle competenze del personale, Anas ha ampliato la gamma dei servizi offerti, svolgendo attività di supporto agli enti pubblici e offrendosi come elemento catalizzatore in Italia e all’estero nei servizi di ORGANI SOCIALI progettazione, costruzione e manutenzione della rete viaria. L’impegno della Società nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture stradali si concentra sulla sicurezza della rete, tutela dell’ambiente, efficienza energetica, nonché sulla salvaguardia del patrimonio paesaggistico del nostro Consiglio di Amministrazione*: Presidente Dott. -

La Chiesa Di San Michele
CENNI STORICI Sulla sommità del Monte d'Oro, in contrada Croce, a circa un km dall'odierno abitato, sono presenti le rovine dell'antico centro arabo-normanno di Qal’at as-sirat. Sulla sommità nord di questo rilievo, in una piattaforma a quota 703 m s.l.m. scoscesa e inaccessibile, si estende per circa un chilometro in linea d’aria un antico abitato medievale, che è visibile ancora per la presenza di numerose rovine (abitazioni, mura di fortificazione, torri di vedetta e una struttura interpretabile come un castello). In questo sito la presenza umana è attestata fin dall’antichità classica, come dimostra il ritrovamento in sito di alcuni reperti (soprattutto ceramici) riferibili ad epoca greco-romana. Un insediamento umano stabile è datato soltanto in età medievale, sotto la dominazione araba della Sicilia. Nel XII secolo (1130-1131) si ebbe la distruzione e l’abbandono della città. Il centro rimase parzialmente abitato ancora nel corso del XII secolo e venne del tutto abbandonata nel secolo seguente. Nel 1181 veniva già definita villa vetus ("città vecchia"). In età moderna (XVI-XVIII secolo) l’antico abitato sul Monte venne variamente identificato dagli storici siciliani dell’epoca con alcune città greco-romane (Parapo, Alesa). Nel 1972 il sito è stato oggetto di una brevissima campagna di scavi archeologici, condotta dalla Soprintendenza ai beni archeologici della Sicilia occidentale: sono stati riportati alla luce una buona quantità di reperti, tra i quali un denaro databile ad età sveva (XIII secolo), una fibula altomedievale, una lucerna, e una notevole quantità di ceramica grezza da mensa e da conserva. -

Perché, Più Dei Furti, È Il Silenzio La Vera Minaccia Al Patrimonio Culturale Pag. 8
ATTUALITÀ Banche, non sempre le dimensioni contano pag. 19 UNIVERSITÀ La ricerca scientifica non è un optional pag. 46 Spedizione in a.p. - d.l. 353/2003 Art.1, Comma 1, DCB Milano - Contiene I.C. 1, DCB Milano Art.1, Comma 353/2003 - d.l. a.p. in Spedizione Cura l’arte Perché, più dei furti, è il silenzio la vera minaccia al patrimonio culturale pag. 8 --- INTERNI STABILITÀ, PUNTO PER PUNTO Le novità della finanziaria 2016 pag. 13 --- AMBIENTE IL REFERENDUM SULLE TRIVELLE Le buone ragioni dei comitati pag. 16 --- MULTINAZIONALI STA ARRIVANDO STARBUCKS Fotografia del gigante del caffé pag. 24 179 --- ESTERI SLOVENIA: CONFINE SPINATO A soli 30 chilometri dall’Italia pag. 42 febbraio 2016 www.altreconomia.it Come abbonarsi ad Altreconomia 1. Compila il modulo, indicando il tipo di abbonamento scelto e i tuoi dati o TUTTO INCLUSO! - Annuale: 49 e o Estero - Annuale (11 numeri): 55 e o AE + Mosaico di pace: 64 e o Ordinario - Annuale (11 numeri): 40 e o AE + Azione Nonviolenta: 63 e o AE + Valori: 72 e o Amico - Annuale (11 numeri): 100 e o AE + Narcomafie: 62 e o AE + Nigrizia: 66 e o Biennale - (22 numeri): 78 e o AE + Gaia: 52 e o Semestrale - (6 numeri): 22 e NOME COGNOME VIA CITTÀ CAP PROV E-MAIL 2. Effettua il pagamento o Conto corrente postale n.14008247 intestato o Bonifico bancario presso Banca Etica. Conto corrente a Altra Economia Soc. Coop - via Vallarsa 2 - IBAN IT18 Y050 1801 6000 0000 0100 814 20139 Milano intestato ad Altra Economia Soc. -

Senato Della Repubblica Xiv Legislatura
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA 638ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO GIOVEDI` 15 LUGLIO 2004 (Pomeridiana) Presidenza del vice presidente DINI INDICE GENERALE RESOCONTO SOMMARIO ...............Pag. V-XI RESOCONTO STENOGRAFICO ........... 1-29 ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ...................31-42 ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comu- nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) ........43-50 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250) Senato della Repubblica– iii – XIV Legislatura 638ª Seduta (pomerid.) Assemblea - Indice 15 Luglio 2004 INDICE RESOCONTO SOMMARIO Interpellanza sul porto di Gela . .........Pag. 36 Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, RESOCONTO STENOGRAFICO sull’innalzamento del limite di velocita` in al- cune autostrade . .................... 37 CONGEDI E MISSIONI ...............Pag. 1 Interpellanza sulle procedure relative al con- INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI dono edilizio . .................... 40 Interrogazione sull’affidamento delle attivita` Svolgimento: di sorveglianza sanitaria presso l’ANAS . 40 Tortoli, sottosegretario di Stato per l’am- Interrogazione sui collegamenti ferroviari biente e la tutela del territorio .......... 2, 5 della citta` di Orvieto . ............. 41 Rotondo (DS-U) .................... 4 Baratella (DS-U) ................... 7 Vallone (Mar-DL-U) ................ -

L'hotel Tonnara Di Trabia
La storia della Tonnara di Trabia La tonnara di Trabia è la più antica di Sicilia essendo stata attiva fin dal 1375, come attestato da fonti notarili. Terzo e più orientale stabilimento del territorio trabiese – dopo quelle di San Nicola l’Arena e quella della Vetrana – essa ricade entro il complesso proto industriale del castello dei principi Lanza, sorto sull’impronta quadrata del fortilizio cui si deve il nome dell’insediamento sorto nel XVII secolo; Trabia deriva, infatti, dall’arabo At Tarbiq (‘La Quadrata’), dal quale il generale aglabita Ben Muhammad lanciò l’assedio alla ricca città di Termini Imerese (827 dC) e che ospitò il primo pastificio per la produzione di spaghetti di farina di grano duro (ar. Itryia) d’Europa, stando all’attestazione del geografo della corte normanna al Idrisi (1132 dC). L’area è stata interessata da un grande oleificio (sec. XIII), un cannameleto (sec. XIV), una fabbrica di colla, una di panni e una di olio di nocciolo (sec. XIX). Parallelamente, lo specchio d’acqua prospiciente i magazzini per lo stoccaggio, salatura, essiccazione e conservazione del pescato fu teatro della mattanza, ovvero di quel rito che si rinnovava ogni anno tra maggio e giugno con la costruzione di architetture temporanee consistenti in corridoi e 5 camere dalla camera di ponente e quella di levante e della morte per una estensione di 3 km, e la cui traccia permane in un sito archeologico subacqueo ricco di ben 89 ancore. L’Hotel Tonnara di Trabia L’hotel Tonnara è il frutto di un attento restauro della antica Tonnara di Trabia, di proprietà insieme al prestigioso castello della famiglia Lanza Branciforte di Trabia.