Speciale Rivista Giuridica Telematica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Examining the Human Health Effects of Asbestos and the Methods of Mitigating Such Impacts
S. HRG. 110–1096 EXAMINING THE HUMAN HEALTH EFFECTS OF ASBESTOS AND THE METHODS OF MITIGATING SUCH IMPACTS HEARING BEFORE THE COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS UNITED STATES SENATE ONE HUNDRED TENTH CONGRESS FIRST SESSION JUNE 12, 2007 Printed for the use of the Committee on Environment and Public Works ( Available via the World Wide Web: http://www.gpo.gov/fdsys/browse/ committee.action?chamber=senate&committee=environment U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 61–969 PDF WASHINGTON : 2011 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2104 Mail: Stop IDCC, Washington, DC 20402–0001 COMMITTEE ON ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS ONE HUNDRED TENTH CONGRESS FIRST SESSION BARBARA BOXER, California, Chairman MAX BAUCUS, Montana JAMES M. INHOFE, Oklahoma JOSEPH I. LIEBERMAN, Connecticut JOHN W. WARNER, Virginia THOMAS R. CARPER, Delaware GEORGE V. VOINOVICH, Ohio HILLARY RODHAM CLINTON, New York JOHNNY ISAKSON, Georgia FRANK R. LAUTENBERG, New Jersey DAVID VITTER, Louisiana BENJAMIN L. CARDIN, Maryland LARRY E. CRAIG, Idaho BERNARD SANDERS, Vermont LAMAR ALEXANDER, Tennessee AMY KLOBUCHAR, Minnesota CHRISTOPHER S. BOND, Missouri SHELDON WHITEHOUSE, Rhode Island BETTINA POIRIER, Majority Staff Director and Chief Counsel ANDREW WHEELER, Minority Staff Director (II) CONTENTS Page JUNE 12, 2007 OPENING STATEMENTS Boxer, Hon. Barbara, U.S. Senator from the State of California ........................ 1 Inhofe, Hon. James M., U.S. Senator from the State of Oklahoma .................... 3 Lautenberg, Hon. Frank R., U.S. Senator from the State of New Jersey ........... 5 Isakson, Hon. Johnny, U.S. -

Deadly Dust: Occupational Health and Safety As a Driving Force in Workers' Compensation Law and the Development of Tort Doctrine and Practice
DEADLY DUST: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AS A DRIVING FORCE IN WORKERS' COMPENSATION LAW AND THE DEVELOPMENT OF TORT DOCTRINE AND PRACTICE COMMENTARY George W. Conk* TABLE OF CONTENTS I. A GOOD DEAL............. ................... ..... 1140 II. THE STRUGGLE FOR RECOGNITION OF OCCUPATIONAL DISEASE ..... 1146 III. SILICOSIS: THE KING OF OCCUPATIONAL DISEASES....... ....... 1149 A. Breaking Through the Germ Theory Paradigm- Deadly Dust .......................... ...... 1151 B. The Hawks Nest Tunnel Disaster............. ..... 1152 IV. ASBESTOS: THE MIRACLE MINERAL AND THE NIGHTMARE THAT FOLLOWED ......................................... ..... 1154 A. The Era of Mass Tort Claims-Asbestos. ............. 1157 V. THIRD-PARTY MASS PRODUCT LIABILITY LITIGATION INVIGORATED TORT................................................... 1159 A. The OrganizationalChallenge .................... 1159 B. Expert Testimony-Daubert and the 'Junk Science' Battle: Raising the Quality of Expert Testimony............. 1160 C. Doctrinal Challenges.... ....................... 1167 * J.D. Rutgers Law School (1974), Senior Fellow, Stein Center for Law & Ethics, Fordham Law School. I was delighted to receive Professor Jay Feinman's invitation to comment. Not only did I graduate from Rutgers Law School, but a few years ago, the Fordham Urban Law Journal published my history of the school, People's Electric: Engaged Legal Education at Rutgers-Newark in the 1960s and 1970s, 40 FORDHAM URB. L.J. 503 (2012). This symposium demonstrates that engagement with the lives of citizens remains alive here. And I am delighted to see that Northeastern is a co-sponsor. Northeastern has continued in the 'People's Electric' tradition of service. Richard Daynard of the Public Health Advocacy Institute and Wendy Parmet are two leading writers about public health. And now we have Emily Spieler's carefully researched paper. -
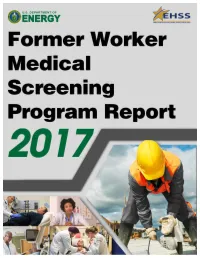
Former Worker Medical Screening Program Report 2017
Partners: STONETURN STC CONSULTANTS UNM 2017 │ Annual Report │Former Worker Medical Screening Program Table of Contents Abbreviations Used in This Report ................................................................................. iii Foreword ......................................................................................................................... v Executive Summary ...................................................................................................... vii 1.0 Program Overview ................................................................................................... 1 2.0 Program Implementation ......................................................................................... 5 3.0 Program Findings .................................................................................................. 13 4.0 Summary ............................................................................................................... 17 Appendix A: Individual Project Descriptions ................................................................. 18 Appendix B: Exams Conducted through the Former Worker Program .......................... 45 Appendix C: Exam Results ........................................................................................... 47 Appendix D: Resources ................................................................................................ 65 Office of Environment, Health, Safety and Security (AU) │ i 2017 │ Annual Report │Former Worker Medical Screening Program This -

Meanderings in New Jersey's Medical History
Meanderings in New Jersey’s Medical History Meanderings in New Jersey’s Medical History Michael Nevins iUniverse, Inc. Bloomington Meanderings in New Jersey’s Medical History Copyright © 2011 by Michael Nevins. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or by any information storage retrieval system without the written permission of the publisher except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. iUniverse books may be ordered through booksellers or by contacting: iUniverse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 47403 www.iuniverse.com 1-800-Authors (1-800-288-4677) Because of the dynamic nature of the Internet, any web addresses or links contained in this book may have changed since publication and may no longer be valid. The views expressed in this work are solely those of the author and do not necessarily reflect the views of the publisher, and the publisher hereby disclaims any responsibility for them. Any people depicted in stock imagery provided by Thinkstock are models, and such images are being used for illustrative purposes only. Certain stock imagery © Thinkstock. ISBN: 978-1-4620-5467-1 (sc) ISBN: 978-1-4620-5468-8 (ebk) Printed in the United States of America iUniverse rev. date: 09/23/2011 CONTENTS Introduction Just for the Fun of It vii 1. “A Very Healthful Air” 1 2. Hackensack’s First Hospital: October—November,1776 5 3. You’ve Got Mail 25 4. The Stormy Petrel of American Medical Education 30 5. -
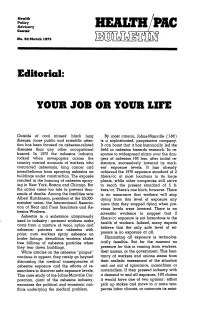
Asbestos-Related It Can Boast That It Has Historically Led the Diseases Than Any Other Occupational Field in Asbestos Hazards Research
Health Policy Advisory HEALTH PAC Center No. 50 March 1973 Editorial: YOUR JOB OR YOUR LIFE Outside of coal miners' black lung By most criteria, Johns-Manville (J-M) disease, more public and scientific atten is a sophisticated, progressive company. tion has been focused on asbestos-related It can boast that it has historically led the diseases than any other occupational field in asbestos hazards research. In re hazard. In 1970 the asbestos industry sponse to widespread alarm over the dan rocked when newspapers across the gers of asbestos J-M has, after initial re country carried accounts of workers who sistance, successively lowered its work contracted asbestosis, lung cancer and ers' exposure levels. It has already mesothelioma from spraying asbestos on achieved the 1976 exposure standard of 2 buildings under construction. The exposes fibers/cc at most locations in its large resulted in the banning of asbestos spray plants, while other companies still strive ing in New York, Boston and Chicago. But to reach the present standard of 5 fi the action came too late to prevent thou bers/cc. There's one hitch, however. There sands of deaths. Among the fatalities was is no assurance that workers will stop Albert Hutchinson, president of the 20,000- dying from this level of exposure any member union, the International Associa tion of Heat and Frost Insulators and As more than they stopped dying when pre bestos Workers. vious levels were lowered. There is no scientific evidence to suggest that 2 Asbestos is a substance ubiquitously fibers/cc exposure is not hazardous to the used in industry: garment workers make health of workers. -

Exhibit D From: Kennedy C
11/28/2018 Case Number: AC 17-0694 Exhibit D From: Kennedy C. Ramos To: "Allan McGarvey"; "Dustin Leftridge" Cc: Edward Longosz ([email protected]); ([email protected]) Subject: Dr. Sicilia Date: Wednesday, November 28, 2018 5:24:02 PM Attachments: ZURICH-HUTT - SICILIA EXPERT REPORT HUTT (11-20-2018) (N0307325xA35AA).pdf Allan and Dustin, Plaintiff is aware of Dr. Sicilia’s general opinions as they relate to the use of, requirements surrounding, and dissemination of information about asbestos in twentieth century America. We have provided multiple dates for Dr. Sicilia’s deposition, including November 6, 13, 15, and 16. Those dates have passed and we have still not heard from Plaintiff whether Plaintiff intends to depose him. Since there has been no response to the deposition dates, and after recently deposing plaintiff’s experts, Dr. Spear and Dr. Hart, Dr. Sicilia’s opinions are reflected in the attached report, with a supplement to follow if necessary when Dr. Hart’s deposition is received. We are providing this report in lieu of the deposition such that Plaintiff will adequately have a complete understanding of the opinions that Dr. Sicilia intends to provide at trial. As before, he remains available for deposition. Please let us know if you would like us to obtain additional dates. Regards, Kennedy C. Ramos, Esq. | Associate **Admitted in Alabama, Virginia and DC ECKERT SEAMANS CHERIN & MELLOTT, LLC 1717 Pennsylvania Avenue, N.W. • 12th Floor • Washington, DC 20006 (202) 659.6675 [email protected] eckertseamans.com Expert Report of David B. Sicilia November 20, 2018 I am an Associate Professor of History and hold the Henry Kaufman Chair of Financial History at the University of Maryland, College Park, MD. -

Objections to March 29, 2017 Order Denying Pan/Nrdc Petition to Revoke All Tolerances and Cancel All Registrations for the Pesticide Chlorpyrifos
Objections to March 29, 2017 Order Denying PAN/NRDC Petition to Revoke All Tolerances and Cancel All Registrations for the Pesticide Chlorpyrifos Submitted by: Earthjustice Objectors: Pesticide Action Network Natural Resources Defense Council United Farm Workers California Rural Legal Assistance Foundation Farmworker Association of Florida Farmworker Justice GreenLatinos June 5, 2017 Labor Council for Latin American Advancement League of United Latin American Citizens Learning Disabilities Association of America Docket No. EPA-HQ-OPP-2007-1005 National Hispanic Medical Association Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION AND SUMMARY ........................................................................................... 1 PRELIMINARY MATTERS.......................................................................................................... 3 I. NO FEE REQUIRED ..........................................................................................................3 II. THE ADMINISTRATIVE RECORD .................................................................................3 III. NO EVIDENTIARY HEARING IS NEEDED IN LIGHT OF THE PURELY SCIENTIFIC ISSUES RAISED IN THESE OBJECTIONS...............................................4 BACKGROUND ............................................................................................................................ 4 I. THE LEGAL FRAMEWORK REQUIRES PROTECTION, PARTICULARLY OF CHILDREN, FROM HARMFUL PESTICIDES ................................................................4 -

The Mount Sinai Hospital 1852-2002 the Sesquicentennial the Mount Sinai Hospital 150Th Anniversary Committee Ellen Katz Chairman Michael A
The Mount Sinai Hospital 1852-2002 The Sesquicentennial The Mount Sinai Hospital 150th Anniversary Committee Ellen Katz Chairman Michael A. Wiener 1852-2002 Vice Chairman The Sesquicentennial Stephen M. Peck Chairman of the Boards of Trustees Nathan Kase, MD Interim President and CEO The Mount Sinai Medical Center and he 1850s were a time of relative peace and prosperity in America. The agricultural and Interim Dean industrial revolutions were gradually transforming our minor nation into a major power. Mount Sinai School of Medicine T The railroads were spreading westward, opening new markets and widening horizons. Barry Freedman Immigrants were filling the cities, fueling the economy with their hopes and dreams. President and CEO The Mount Sinai Hospital But progress came at a price. Cities were growing crowded and polluted, becoming incubators for infectious diseases. Violence and workplace injuries added to the misery of urban life; the average Arthur H. Aufses, Jr., MD* American could expect to live just 40 years. Avi Barbasch, MD Jennifer Peck Barnett In this atmosphere, delicately balanced between promise and peril, a group of philanthropists and Jennie and Richard DeScherer civic leaders gathered to create a hospital for the fast-growing community of Jewish immigrants Sue K. Feld crowding the tenements of lower Manhattan. Thus was born the Jews’ Hospital in New York, join- Jennifer Fiorentino ing the first wave of hospitals that would shape American medicine for generations to come. Diane and Blaine V. Fogg Jeffrey Freed, MD The history of the Jews’ Hospital—soon renamed The Mount Sinai Hospital, a more accurate Kathy and Richard S. -

Deadly Dust: Occupational Health and Safety As a Driving Force In
Fordham Law School FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History Faculty Scholarship 2017 Deadly Dust: Occupational Health and Safety as a Driving Force in Workers’ Compensation Law and the Development of Tort Doctrine and Practice George Conk Fordham University School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship Part of the Dispute Resolution and Arbitration Commons, and the Torts Commons Recommended Citation George Conk, Deadly Dust: Occupational Health and Safety as a Driving Force in Workers’ Compensation Law and the Development of Tort Doctrine and Practice, 69 Rutgers U. L. Rev. 1139 (2017) Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/925 This Article is brought to you for free and open access by FLASH: The orF dham Law Archive of Scholarship and History. It has been accepted for inclusion in Faculty Scholarship by an authorized administrator of FLASH: The orF dham Law Archive of Scholarship and History. For more information, please contact [email protected]. DEADLY DUST: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AS A DRIVING FORCE IN WORKERS’ COMPENSATION LAW AND THE DEVELOPMENT OF TORT DOCTRINE AND PRACTICE COMMENTARY George W. Conk* TABLE OF CONTENTS I. A GOOD DEAL .................................................................................. 1140 II. THE STRUGGLE FOR RECOGNITION OF OCCUPATIONAL DISEASE .... 1146 III. SILICOSIS: THE KING OF OCCUPATIONAL DISEASES........................ 1149 A. Breaking through the germ theory