Indagine Archeologica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
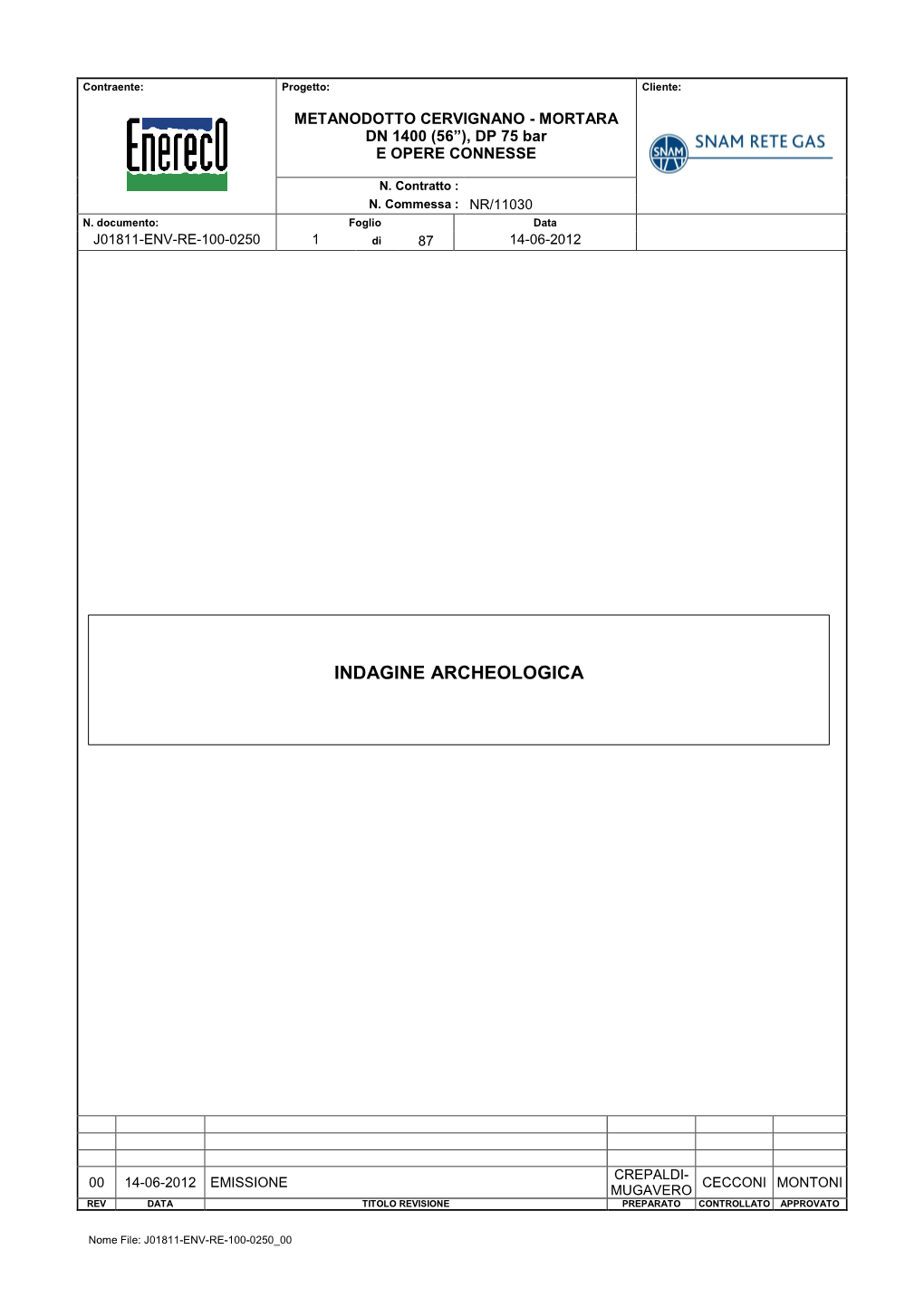
Load more
Recommended publications
-

Provincia Di Lodi
Provincia di Lodi Assessorato alla pianificazione territoriale e settore rurale Servizio pianificazione territoriale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Allegato G Schede relative ad ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18 luglio 2005 Introduzione Le aree individuate sulla Tavola 2.3 – Tavola delle indicazioni di piano: Sistema paesistico e storico-culturale vogliono rappresentare una prima individuazione di ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela contribuendo al disegno strategico del sistema insediativo, del rapporto di questo con il territorio agricolo, oltre che con gli elementi naturali e storico-culturali, nel rispetto delle linee evolutive e delle peculiarità locali. Il fine è di garantire il riconoscimento dei caratteri di “storicità” di alcuni collegamenti infrastrutturali e di alcuni manufatti edilizi e garantire che si operi nella direzione di valorizzare l’identità dei singoli elementi e del contesto con cui gli stessi si riferiscono. Gli ambiti, i quali nella totalità dei casi sono stati individuati in ambito extra-urbano perseguendo politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, sono aree in cui gli strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la rete dei valori ecologico-ambientali, in particolare per predisporre opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di coni visuali”, per tutti quei beni che per localizzazione, consistenza e significato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti. Gli elementi sono individuati a partire dall’archivio SIBA – Sistema informativo dei Beni Ambientali realizzato dalla Regione Lombardia e dal S.I.R.Be.C. -

Page 1 FELICE SACCHI Geologo Ordine Dei Geologi Della Lombardia
FELICE SACCHI Geologo Ordine dei Geologi della Lombardia n° 367 Via Molino 54/A-27010 San Zenone Po (PV) Tel. 0382/79326 E-mail: [email protected] C O M U N E D I S A L E R A N O S U L L A M B R O Provincia di Lodi STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE ALLEGATO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Legge Regionale 12 del 11/03/05 DGR 8/1566 del 22/12/2005 RECEPIMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE DGR 7/7868 e Seguenti R E L A Z I O N E G E O L O G I C A G E N E R A L E MAGGIO 2008 INDICE RELAZIONE ILLUSTRATIVA ......................................................................................................... 2 1. PREMESSE............................................................................................................................... 2 1.1 Ricerca storica e sintesi bibliografica........................................................................... 3 2. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO – CLIMATICO ......................................................... 5 2.1 Termometria .................................................................................................................... 6 2.2 Pluviometria..................................................................................................................... 6 3. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI CORSI D’ACQUA................................................................ 7 3.1 Le acque superficiali....................................................................................................... 7 3.2 Elementi idrografici, idrologici e -

Comune Di Casalmaiocco Provincia Di Lodi
Comune di Casalmaiocco Provincia di Lodi REGISTRO GENERALE COMUNALE DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2005 N. N. DATA REGISTRO DETERMINA DETERMINA SERVIZIO OGGETTO GENERALE 1 1/AGSP 17.01.2005 Amministrazione Generale e Erogazione contributo per l’accesso ed il recupero della Servizi alla Persona prima casa – 3^ bando anno 2002 2 1/TA 21.01.2005 Territorio e Ambiente Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell’art. 16, comma 9. D.P.R. n. 380 del 2001 3 1/EF 21.01.2005 Economico Finanziario Dipendenti Comunali. Liquidazione compensi lavoro straordinario dal 01.11.2004 al 31.12.2004 4 2/EF 26.01.2005 Economico Finanziario Affidamento incarico per la fornitura di carburante ed attività accessorie per l’anno 2005 5 2/TA 01.02.2005 Territorio e Ambiente Impegno di spesa per fornitura di n. 18 lastre per chiusura ossari cimitero comunale 6 3/TA 01.02.2005 Territorio e Ambiente A.T.O. - Versamento quote spese anno 2005 N. N. DATA REGISTRO DETERMINA DETERMINA SERVIZIO OGGETTO GENERALE 7 3/EF 01.02.2005 Economico Finanziario Impegno di spesa per l’acquisto computer progetto Siscotel 8 4/EF 09.02.2005 Economico Finanziario Impegno di spesa per il personale per prestazioni di lavoro straordinario anno 2005 9 2/AGSP 04.02.2005 Amministrazione Generale e Servizi Impegno di spesa per l’acquisto di modulistica per lo alla Persona svolgimento delle elezioni amministrative del 3 e 4 aprile 2005 10 3/AGSP 11.02.2005 Amministrazione Generale e Servizi Elezioni del Pres idente della Giunta e del Consiglio alla Persona Regionale della Lombardia del 3 e 4 aprile 2005. -

Commissione Provinciale Espropri Per La Provincia Di Lodi
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER LA PROVINCIA DI LODI TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI VALEVOLE PER L'ANNO 2009 (1) (EX ARTICOLO 41 - COMMA 4° DEL D.P.R. N° 327/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) N° TIPO DI COLTURA REGIONE AGRARIA N. 1 REGIONE AGRARIA N. 2 REGIONE AGRARIA N. 3 VALORI MEDI euro/mq. (3) VALORI MEDI euro/mq. (3) VALORI MEDI euro/mq. (3) 1 SEMINATIVO 3,75 3,75 3,69 2 SEMINATIVO IRRIGUO (4) 5,36 5,22 4,87 3 RISAIA STABILE 4,26 4,26 4,26 4 PRATO 3,75 3,75 3,69 5 PRATO IRRIGUO 5,36 5,22 4,87 6 PRATO A MARCITA 4,91 4,76 4,76 7 ORTO 5,84 5,84 5,84 8 ORTO IRRIGUO 9,09 8,60 8,38 9 FRUTTETO (2) - 7,14 - 10 VIGNETO - 5,78 - 11 VIGNETO SPECIALIZZATO (D.O.C.) - 10,28 - 12 INCOLTO PRODUTTIVO 1,89 1,89 1,86 13 PIOPPETO (2) 3,53 3,53 3,50 14 BOSCO (2) 1,91 1,91 1,88 15 COLTURE FLOROVIVAISTICHE (2) 9,82 9,82 9,82 REGIONE AGRARIA N. 1 - PIANURA DI LODI (27 Comuni) : Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castirada Vidardo, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Lodi, Lodi Vecchio, Marudo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’ Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Zelo Buon Persico. REGIONE AGRARIA N. -

2020 Buoni Sociali
Comune Misura richiesta dic-20 prot. 172/2020 Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono assistente familiare 400,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 300,00 € Casalpusterlengo Buono care giver 50,00 € Mairago Buono assistente familiare 400,00 € Cavenago d'Adda Buono care giver 300,00 € Cavenago d'Adda Buono assistente familiare 400,00 € Mairago Buono assistente familiare 780,00 € Codogno Buono care giver 300,00 € Codogno Buono Vita Indipendente 800,00 € Codogno Buono care giver 300,00 € Codogno Buono care giver 300,00 € Codogno Buono assistente -

Distretto Ambito Distrettuale Comuni Abitanti Ovest Milanese Legnano E
Ambito Distretto Comuni abitanti distrettuale Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Legnano e Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa 22 254.678 Castano Primo Cortese ; Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnano, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello Ovest Milanese Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Magenta e Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano 28 211.508 Abbiategrasso Ticino, Sedriano, Vittuone; Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cisliano, Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimomdo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone Garbagnate Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Mil.se, Novate Mil.se, Paderno 17 362.175 Milanese e Rho Dugnano, Senago, Solaro ; Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Rhodense Mil.se, Pregnana Mil.se, Rho, Settimo Mil.se, Vanzago Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Corsico 6 118.073 Naviglio Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Bresso, Nord Milano Nord Milano 6 260.042 Cormano e Cusano Milanino Milano città Milano Milano 1 1.368.545 Bellinzago, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago, Basiano, Adda Grezzago, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, 28 338.123 Martesana Vaprio d’Adda, Cassano D’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, -

Progetto Strategico Di Sottobacino Lambro Settentrionale
Progetto strategico di sottobacino Lambro Settentrionale Sorgenti Lambro 1 Asso, Barni, Bellagio, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona Brianza 2 Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Besana in Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Camparada, Casatenovo, Carate Brianza, Cassago Brianza, Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d’Erba, 1 Macherio, Merone, Monguzzo, Monticello Brianza, Nibionno, Renate, Rogeno, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta Lambro collinare 3 Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bulciago, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, La Valletta Brianza, Molteno, Oggiono, Sirone, Sirtori Lambro urbano 4 Brugherio, Cologno Monzese, Concorrezzo, Desio, Lissone, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Sesto San Giovanni Pianura irrigua milanese 5 Carpiano, Carugate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rodano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Tribiano, Vimodrone, Vizzolo Predabissi Pianura irrigua lodigiana 6 Bascapè, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Chignolo Po, Graffignana, Livraga, Lodi Vecchio, Marudo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villanesco, Villanova del Sillaro. -

PGT Casaletto Relagro
REGIONE LOMBARDIA PGT Comune di Casaletto Lodigiano (LO) RELAZIONE AGRONOMICA novembre 2011 Il Tecnico Dott. Giovanni Molina Premessa La presente relazione va a supporto dello studio complessivo di redazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Casaletto Lodigiano. Per la stesura del presente studio agronomico ci si è avvalsi, in parte, dei dati forniti dalla provincia di Lodi, settore agricoltura, anticipando lo studio analitico che la provincia stessa attualmente sta elaborando secondo convenzione con il Comune. Ai dati raccolti si è affiancata una fase di sopralluogo e rilievo in campo, oltre all’analisi dei documenti disponibili sul territorio e la collaborazione con lo staff di progetto del PGT. Considerazioni sintetiche sull’ordinamento colturale prevalente La struttura territoriale del Comune di Casaletto Lodigiano ha una matrice agricola ancora pienamente riconoscibile. L’ordinamento colturale prevalente è di carattere cerealicolo-zootecnico con una prevalenza dell’allevamento di bovine da latte. I dati del SIARL (forniti dalla Provincia di Lodi, Settore Agricoltura, Fonte: Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia, aggiornamento giugno 2011) indicano chiaramente questa prevalenza di ordinamento colturale. Analisi dell’uso dei suoli (impiego e destinazione della SAU - SIARL 2011) L’analisi della SAU (Superficie Agricola Utile) iscritta ai fascicoli aziendali del SIARL, rileva altri elementi utili a caratterizzare la struttura agricola nel comune. Nel complesso la SAU del Comune è di 840 ha di cui 490 ha in capo ad aziende agricole che hanno il centro aziendale entro i confini del Comune stesso, ovvero più della metà della SAU fa riferimento ad aziende del comune. Questo dato indica semplicemente ed empiricamente il grado di radicamento del tessuto agricolo nel Comune, aspetto significativo per un comune che presenta una forma territoriale aperta e certo non accorpata oltre ad avere un tessuto urbano suddiviso in più frazioni. -

Poderi Di Proprietà Della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale
Poderi di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Milano Lotto Podere Comune Bertonico Brusata di Sopra Bertonico Bertonico Brusata di Sotto Bertonico Bertonico Campolungo Bertonico Bertonico Cascina del Ponte Bertonico Bertonico Cascina di Sotto Bertonico Bertonico Case e Orti in Bertonico Bertonico Bertonico Casenove Bertonico Bertonico Ceradello Bertonico Bertonico Chioso Bertonico Bertonico Gallinera Bertonico Bertonico Gora Bertonico Bertonico Guastimone Bertonico Bertonico Mezzano Bertonico Bertonico Monticelli Maggiore Bertonico Bertonico Monticelli Minore e Pila Bertonico Bertonico Pista Bertonico Bertonico Piva Bertonico Bertonico Riserva di Caccia Bertonico Bertonico Bertonico San Carlo Bertonico Bertonico Taccagna Bertonico Bertonico Valmollo Bertonico Bertonico Vigneto di Monticelli Bertonico Brianza Bariana Garbagnate Milanese Brianza Bariola Caronno Pertusella Brianza Bresso Bresso Brianza Calco Airuno Brianza Cascina De Bracchi Casatenovo Brianza Cascina del Sole Bollate Brianza Cassinette Bianche Castello Di Brianza Brianza Cimnago Carimate Brianza Cormano Cormano Brianza La Tombona Peschiera Borromeo Brianza Lomazzo Bregnano Brianza Naresso Besana In Brianza Brianza Nerviano Nerviano Brianza Poglianasca Nerviano Brianza Rovagnate Santa Maria Hoè Brianza Seregno Seregno Brianza Terreni in Peschiera e Segrate Peschiera Borromeo Brianza Vedano Vedano al Lambro Brianza Villanova Bernareggio 1 di 4 Poderi di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Milano Esterni Biola Mandello Vitta -

LODI Catene Scuole Ambito 15032017
Istituzione Istituzione denominazione Scuola comune Scuola denominazione Scuola comune Scuola Sigla Scolastica progressivo Scolastica A A A B B Regione Provincia Ciclo Istruzione Ambito Scuola Capofila B Catena Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC81100D ISTITUTO COMPRENSIVO LODI I LODI 1 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC812009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LODI 2 LODI 2 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC813005 IC DI LODI IV LODI 3 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC814001 IC LODI III LODI 4 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOMM022001 CPIA 1 LODI LODI 5 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC80300E IC- ANTONIO GRAMSCI LODI VECCHIO 6 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC800003 IC FEDERICO FELLINI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 7 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC81500R IC CARLO COLLODI SANT'ANGELO LODIGIANO 8 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC81600L IC RICCARDO MORZENTI SANT'ANGELO LODIGIANO 9 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC80200P IC ANTONIO GRAMSCI MULAZZANO 10 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 SI LOIC80100V IC DI LODI V LODI LOIC805006 IC- ZELO BUON PERSICO ZELO BUON PERSICO 11 Lombardia LO 1 LOMBARDIA AMBITO 0017 NO LOIC800003 IC FEDERICO FELLINI TAVAZZANO CON VILLAVESCO -

Abbadia Cerreto Abbiategrasso Agnadello Agrate Brianza Aicurzio Airuno Albairate Albiate
COMUNI PENDOLARI “COMMUTING” MUNICIPALITIES . Abbadia Cerreto . Bernareggio . Abbiategrasso . Bernate Ticino . Agnadello . Besana Brianza . Agrate Brianza . Besate . Aicurzio . Besnate . Airuno . Biassono . Albairate . Bienate . Albiate . Binago . Albizzate . Binasco . Almè . Boffalora D’Adda . Alzano Lombardo . Boffalora Sopra Ticino . Antegnate . Boltiere . Appiano Gentile . Bonate Sopra . Arcene . Bonate Sotto . Arconate . Borgarello . Arcore . Borghetto Lodigiano . Arluno . Borgo San Giovanni . Arona . Borgo Lombardo . Arosio . Bornasco . Arsago Seprio . Bottanuco . Arzago D’Adda . Bovisio Masciago . Azzano S. Paolo . Breccia . Bagnolo Cremasco . Bregnano . Bariano . Brembate . Barlassina . Brembate Sopra . Barzago . Brembio . Barzanò . Bressana Bottarone . Bascapè . Brignano Gera D’Adda . Basiano . Briosco . Bastida Pancarana . Brivio . Battuda . Brugherio . Bellinzago Lombardo . Bubbiano . Bellusco . Buguggiate . Beregazzo Con Figliaro. Bulciago . Bereguardo . Bulgarograsso . Bergamo . Burago Di Molgora . Buscate . Carvico . Busnago . Casaletto Lodigiano . Bussero . Casaletto Vaprio . Busto Arsizio . Casalmaiocco . Busto Garolfo . Casalpusterlengo . Cabiate . Casarile . Cadorago . Casatenovo . Cairate . Casciago . Calcio . Caselle Lurani . Calco . Casirate D’Adda . Calolziocorte . Caslino D'erba . Calusco D’Adda . Casnate Con Bernate . Calvenzano . Casorate Primo . Calvignasco . Casorate Sempione . Camairago . Casorezzo . Cambiago . Cassago Brianza . Camparada . Cassano D’Adda . Canegrate . Cassano Magnago . Canonica D’Adda . Cassina -

(LO) – PGT Piano Delle Regole – Norme Tecniche Di Attuazione 0
Comune di Villanova del Sillaro (LO) – P.G.T. Piano delle Regole – Norme Tecniche di Attuazione TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................................... 4 CAPO I GENERALITA’ ......................................................................................................................... 4 Art. 1 Ambito di applicazione del Piano delle Regole ..................................................................... 4 Art. 2 Finalità delle Norme.............................................................................................................. 4 Art. 3 Deroghe e modifiche ............................................................................................................. 4 Art. 4 Trasformazione urbanistica ed edilizia ................................................................................. 5 Art. 5 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del P.G.T. .......................................................... 5 Art. 6 Edificabilità ........................................................................................................................... 5 Art. 7 Analisi di rischi ai sensi del D.lgs. 152/06 ............................................................................. 5 Art. 8 Disposizioni relative alle aziende agricole dismesse o in dismissione ................................... 5 Art. 9 Prescrizioni generali finalizzate alla protezione dell’ambiente ............................................. 6 CAPO II INDICI