I Quaderni Del CSDC
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guarantee Options for a Settlement of the Conflict Over Transnistria
Guarantee Options for a Settlement of the Conflict over Transnistria Stefan Wolff ECMI WORKING PAPER #51 November 2011 ECMI- Working Paper The European Centre for Minority Issues (ECMI) is a non-partisan institution founded in 1996 by the Governments of the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, and the German State of Schleswig-Holstein. ECMI was established in Flensburg, at the heart of the Danish-German border region, in order to draw from the encouraging example of peaceful coexistence between minorities and majorities achieved here. ECMI’s aim is to promote interdisciplinary research on issues related to minorities and majorities in a European perspective and to contribute to the improvement of interethnic relations in those parts of Western and Eastern Europe where ethnopolitical tension and conflict prevail. ECMI Working Papers are written either by the staff of ECMI or by outside authors commissioned by the Centre. As ECMI does not propagate opinions of its own, the views expressed in any of its publications are the sole responsibility of the author concerned. ECMI Working Paper European Centre for Minority Issues (ECMI) Director: Dr. Tove H. Malloy © ECMI 2011 2 | P a g e ECMI- Working Paper Guarantee Options for a Settlement of the Conflict over Transnistria Any meaningful consideration of guarantee options requires some assumptions about the nature of the underlying settlement. With this in mind, the following discussion draws on comparative experience in two ways. First, it considers the nature of the conflict over Transnistria in a broader context of similar conflicts elsewhere in order to establish the likely dimensions of a settlement. -

The EU and Transnistria UNISCI Discussion Papers, Núm
UNISCI Discussion Papers ISSN: 1696-2206 [email protected] Universidad Complutense de Madrid España Popescu, Nico The EU and Transnistria UNISCI Discussion Papers, núm. 10, enero, 2006, pp. 247-254 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76701015 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative UNISCI DISCUSSION PAPERS Nº 10 (Enero / January 2006) THE EU AND TRANSNISTRIA AUTHOR:1 NICO POPESCU Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels Introduction EU thinking, assessments and policies towards the conflict in Transnistria have evolved quickly. The turning point towards a more active role occurred in late 2002. Since then, the EU has stepped up its attention and actions. The EU now raises constantly the Transnistria issue in relations with Russia and Ukraine. The Union has also used an array of CFSP instruments to support the conflict resolution process – these have included appointing a EU Special Representative, introducing a travel ban against the Transnistrian leadership, as well as envisaging common actions under its ENP Action Plans with Moldova and Ukraine on conflict resolution in Transnistria. 1. Why More EU Engagement? First, because of enlargement. A 2002 Commission paper on EU approaches to Moldova stated: ‘Moldova’s stability clearly matters to the EU. Within a few years, Moldova will be on the borders of an enlarged EU. It has been destabilised by weak government, armed conflict and secession, near economic collapse, organised crime and emigration […] The EU needs to help Moldova address these problems’2. -

The Role of Germany in the Transnistria Conflict
Przegląd Strategiczny 2020, Issue 13 Bogdan KOSZEL DOI : 10.14746/ps.2020.1.7 Adam Mickiewicz University in Poznań https://orcid.org/0000-0002-7118-3057 THE ROLE OF GERMANY IN THE TRANSNISTRIA CONFLICT HISTORIC BACKGROUND The territory of Transnistria is a special enclave on the left bank of the Dniester River, with cultural and historical traditions markedly different than those in neighbor- ing Moldova. The Ottoman conquests, followed by the partitioning of Poland, made the Dniester a river marking the border between the Russian and Turkish empires. When Turkey grew weaker in the international arena and Russia grew stronger after its victory over Napoleon, the territory – known as Bessarabia – fell under Russian rule until 1918, to be embraced by Greater Romania after the collapse of tsarism (Lubicz- Miszewski, 2012: 121–122). After the Soviet Union was formally established in 1922, the Moscow government immediately began to question the legality of Bessarabia’s inclusion within Romania and never accepted this annexation. In 1924, the Moldovan Autonomous Socialist So- viet Republic (MASSR) was established on the left bank of the Dniester as an integral part of the Ukrainian Socialist Soviet Republic. Before World War II, Germany showed no interest in this region of Europe, believ- ing that this territory was a zone of influence of its ally, the Austro-Hungarian mon- archy, and then of the Soviet Union. In the interwar period, Romania was a member of the French system of eastern alliances (Little Entente) and Berlin, which supported Hungarian revisionist sentiments, held no esteem for Bucharest whatsoever. At the time of the Weimar Republic, Romania became interested in German capital and ob- taining a loan from the Wolff concern to develop their railroads, but Germany shunned any binding declarations (Koszel, 1987: 64). -

Support to Confidence Building Measures Susținerea Măsurilor De Promovare a Încrederii Поддержка Мер По Укреплению Доверия
This Programme is funded by the European Union, co-funded and implemented by the United Nations Development Programme Support to Confidence Building Measures Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii Поддержка мер по укреплению доверия PROJECTS CARRIED OUT OR ONGOING IN THE FRAMEWORK OF "SUPPORT TO CONFIDENCE BUILDING MEASURES" PROGRAMME (MARCH 2012- MARCH 2015) No Project title Budget, EUR Sector Implementing partners Implementation period/Expected dates Creating a sustainable system of business education in Transnistria for beginner Consortium of Chamber of Commerce July 2012 – June 2014 Business 1 entrepreneurs, mid-level managers and 455,500 of Transnistria and SGS Company Development CEOs, as well as creating a sustainable pool Moldova of local business trainers July 2012 – April 2013 Chamber of Commerce of Moldova in Joint business trips to EU for Business 14-18 October – trip to Poland 2 106,300 partnership with Moldovan/Transnistrian entrepreneurs Development November 2012 – Austria “Intereconomiservice” of Transnistria March 2013 - Germany Business consulting services for companies Chamber of Commerce of Moldova in September 2012 – July 2013 Business 3 from Moldova and the Transnistrian region 33,500 partnership with Development “Intereconomiservice” of Transnistria Market Survey of the Microfinance sector Research company "International July – November 2012 and feasibility study creating a microfinance Business Development Alternatives" from 4 37,400 facility in the Transnistrian region Development Moldova in partnership -

FROZEN CONFLICTS' the Challenges of Reconciliation Table of Contents Features
per ConcordiamJournal of European Security and Defense Issues EMERGENCY RESPONSE POST-SOVIET SPACE Civil-military links a must Old approach won’t help define borders BALANCING THE BALKANS PLUS Pillars of progress eroding New Afghan momentum Croatia hosts special forces UNRESOLVED CONFLICTS Further from resolution than ever? Olympic security effort RESOLVING 'FROZEN CONFLICTS' The Challenges of Reconciliation Table of Contents features ON THE COVER Protracted, or “frozen,” conflicts present a challenge to stability and security. Moving Answering away from the status quo while protecting 18 against the potential of renewed violence the distress call is not a simple endeavor. Finding common Civil-military cooperation is a ground upon which all parties can agree has must in emergency response to proven a nearly impossible task. man-made and natural disasters. 26 A balanced view of the Balkans Some believe the Balkan conflict p. is over, but others warn it is on 10 the brink of erupting again. The myth of 'frozen conflicts' 32 Resolving post-Soviet Regional and international support for stabilization could lead to lasting solutions 'frozen conflicts' Cover illustration: per Concordiam staff in places such as the South Caucasus. A strong foundation must be in place for effective regional integration. 38 Russia and the post-Soviet space Taking other interests into account will help Moscow regain a leadership role. 2 perConcordiam p.52 departments 4 Director's Letter 5 Contributors 6 In This Issue 7 Letters to the Editor 8 Viewpoint 64 Book Review 66 Calendar COOPERATION SECURITY POLICY 44 On Corruption's 52 Olympic effort 60 Kazakhstan faces Front Lines Nations collaborate to secure OSCE hurdles Reforms help Tajikistan international sporting events. -

Post-Conflict Rehabilitation Ef- Forts in Transnistria Have to Take Into Account Two Key Features That Char- Acterize the Situation in Moldova
9.c. Post Conflict Rehabilitation in Moldova Nicu Popescu Introduction Since declaring independence in 1991 Moldova has had to face four ma- jor interdependent tasks: building a state, without any tradition of it; managing political transition; restructuring the economy and dealing with the secessionist conflict with its eastern region Transnistria. There has been some progress on the first two dimensions. Moldova has man- aged to assert itself as a state, despite many problems, and democracy has achieved a level, however unstable and modest that is not very often seen in the post-Soviet space. However, the slow pace of economic re- form, the difficult economic situation, and the still unsolved conflict in Transnistria have a tendency to influence negatively some of the positive achievements in the political realm. As noted in the EU’s Country Strat- egy Paper on Moldova: ‘The Transnistrian dispute heavily affects Moldova's foreign relations and economic development. Moldova can only make limited progress towards democratic consolidation and eco- nomic improvements as long as the Transnistrian issue continues’ 222 . Thus, overcoming the Transnistria conflict remains one of the keys to Moldova’s successful transition and the stabilization of the immediate neighborhood of the enlarged NATO and EU. The Transnistrian conflict in Moldova presents a case where post- conflict rehabilitation takes place after a war, but before the terms of a mutually satisfactory peace are agreed. Post-conflict rehabilitation ef- forts in Transnistria have to take into account two key features that char- acterize the situation in Moldova. Firstly, while the active phase of the conflict has ended, there is no agreement between the conflicting parties on the resolution of the conflict and the status of Transnistria. -

Statement on Transnistria Conflict Settlement Talks
PC.DEL/1278/05 22 December 2005 ENGLISH only United States Mission to the OSCE Statement on Transnistria Conflict Settlement Talks As delivered by Ambassador Julie Finley to the Permanent Council, Vienna December 22, 2005 Thank you, Mr. Chairman. Like the European Union, the United States also participated as an observer in the latest round of Transnistria conflict settlement talks that took place in Moldova December 15th and 16th. Unfortunately, the results of this round were disappointing. There was virtually no progress achieved, due mainly to the obstructive attitude adopted by the Transnistrian side. The next round of talks, scheduled for January 26th and 27th in Moldova, will be an opportunity for the sides to reinvigorate their efforts and to demonstrate that they take the negotiations seriously. In particular, we call on the Transnistrian side to comply with both the spirit and words of the protocols from the two previous rounds in the 5 plus 2 format and provide complete military data to the OSCE as soon as possible. We look forward to reviewing the OSCE Mission's plan for a mission to assess prospects for free and fair democratic elections in the Transnistrian region, and we hope that early 2006 will see real progress on proposals to monitor Transnistria's military-industrial enterprises and to transform and internationalize the peacekeeping forces. Mr. Chairman, nothing would help the settlement process more tangibly than for the Russian Federation to resume the withdrawal of its forces from Moldovan territory in fulfillment of its 1999 Istanbul Summit commitment. The United States again reiterates its full support for a peaceful settlement to this conflict that fully respects Moldova's sovereignty, independence and territorial integrity. -

Chisinau 2006 Report on Human Rights Violations in Moldova
CHISINAU 2006 REPORT ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MOLDOVA This publication “A Report on Human Rights Violations in Moldova: 2005 retrospective” was elaborated by Promo-Lex Association experts: Ion Manole 2.5. Right to education 2.7. Electoral rights 2.12. Rights of national minorities 2.13. Rights of sexual minorities Chapter 3 Violation of the human rights in the eastern part of Moldova (Transnistria) Alexandru Postica 2.2. Right to property 2.3. Right to information, free- dom of opinion and freedom of expresion 2.4. Freedom of assembly and association and freedom of reli- gion 2.9. Rights of women Chapter 4 Cases brought against the Re- public of Moldova before the European Court of Human Rights, Decisions adopted in 2005 Sergiu Gogu 2.6. Right to labour and social protection 2.8. Rights of the child Pavel Postica 2.1. Right to life, liberty and personal security 2.10. Rights of detainees 2.11. Rights of migrants and refu- We would like to thank the following persons who gees contributed to this report: Irina Rata, Olga Pilipciuc-Manole, Nicoleta Hriplivii Adrian Diordita, Iulia Lungu, Natalia Vavulea, Oleg Cristal Ion Madiudin PROMO-LEX ASSOCIatION For correspondence: Chisinau MD – 2012, P.O.BOX 89 Promo-Lex Association Tel./Fax: (0-22) 450024; Mobil: 069177101, 069104851 E-mail: [email protected]; WEB: www.promolex.ong.md This publication was financially supported by the Royal Norwegian Embassy. The Royal Norwegian Embassy is not responsible for any The Report is only for free opinions reflected in this publication. distribution 2005 RETROSPECTIVE 2005 RETROSPECTIVE CONTENTS paGE INTRODUCTION..................................................................................................................................5 1. -

Hon. Christopher H. Smith
Testimony :: Hon. Christopher H. Smith Chairman - Commission on Security and Cooperation in Euorpe Good morning and welcome to Ambassador Munteanu, our other panelists, and to everyone joining us today. This morning we will examine the human cost of Moldova’s unresolved conflict with its breakaway region of Transnistria, and the prospects for resolving this almost twenty year-old tragedy. Exactly ten years ago I chaired the first commission hearing focused specifically on Moldova – “Moldova: Are the Russian Troops Really Leaving?” A decade later we can still ask the same question, as a contingent of Russian troops remains in Transnistria notwithstanding specific commitments to withdraw, which the Russian government made at the Istanbul OSCE Summit in 1999. For almost twenty years the Russian government has maintained troops in Transnistria against the wishes of the Moldovan government; and in violation of the Helsinki Final Act; as well as in violation of other international commitments, freely undertaken by the Russian government, regarding the stationing of foreign forces on the territory of another state without the consent of the host government, and regarding respect for the sovereignty and territorial integrity of other states. The Russian Government has aided and supported a despotic and corrupt administration in Transnistria – an illegitimate government which is recognized by no other government in the world, not even the Russian. As a consequence, Moldova’s central government is unable to extend its authority to Transnistria. The administration in Transnistria has managed a sustained campaign to stifle civil society, free media, and all political opposition. Its human rights record is marred by torture and the arbitrary arrest of citizens who differ with the ruling administration, including journalists such as Ernest Vardanean, sentenced to fifteen years in prison on trumped-up charges of espionage. -
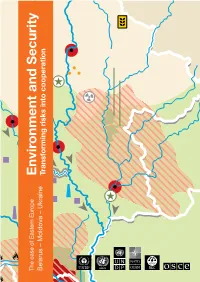
Environment and Security Transforming Risks Into
Environment and security issues in Belarus D a Osveyskiy u LATVIA g 0 50 100 km a Krasny v Daugavplis a Bor Sinsha Drysviaty Lake Novopolotsk Ignalina LITHUANIA Braslav Kozianskiy RUSSIA Lakes Polotsk Z a p . D vi na Vitebsk Smolensk y 1 Environment and Security Environment and Security Environment risks into cooperation Transforming risks into cooperation Transforming t The case of Eastern Europe Belarus – Moldova Ukraine Water-related issues Other pollution issues Important discharges of wastewater in transboundary Main industrial centres water basins Storages of obsolete pesticides Poor to bad water quality 1 Potassium mining (waste and water pollution) Lack of coordination and infrastructure for transborder flow control Forest fires in Chernobyl-contaminated areas Environmental concerns related to military Dams (existing / projected) areas (in use / closed) Energy and radiation issues Important nature 3 Areas exposed to high radioactive contamination due to the Major protected areas / transboundary regions Chernobyl explosion: of high ecological importance 2 Caesium-137 activity above 555 kBq/m 0 250 km Riga 2 LATVIA Plutonium isotopes activity above 4 kBq/m Notes: 1 - National Baltic RUSSIA 2 water quality index Sea LITHUANIA Nuclear power plants (operating / projected / closed ) Vilnius below two. 2 - The RUSSIA Minsk Radioactive waste storage sites (in use / considered) last Chernobyl reactor was stopped Warsaw BELARUS Oil refineries Oil fields in 2000. 3 - Only near-border nature POLAND Gas processing plants areas are shown. Kyiv Brown coal deposits Major peat deposits UKRAINE SLOVAK REPUBLIC Sources: Belarus State University. Atlas of Belarus Geography. Minsk 2005; State Committee for Land Resources, Geodesy MOLDOVA HUNGARY and Cartography. -

The Transnistrian Issue: Moving Beyond the Status-Quo
DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES OF THE UNION DIRECTORATE B POLICY DEPARTMENT STUDY THE TRANSNISTRIAN ISSUE: MOVING BEYOND THE STATUS-QUO Abstract The conflict over the Transnistrian region dates back to the end of the Soviet Union and the establishment of an independent Moldovan state. However, until recently very little tangible progress has been made towards a sustainable conflict settlement. With the resumption of official talks in the 5+2 conflict settlement process, the Transnistrian issue is now relatively high up on the political agenda of all the parties involved, and the need for maintaining this current positive momentum and developing creative solutions has taken on added importance. This study adds to existing publications by offering an up-to-date analysis of the situation in Moldova and the Transnistrian region, placing it in a wider regional context and examining the positions of the key actors in the conflict settlement process. Against this background, and drawing on an analysis of existing proposals for conflict settlement, it offers a number of suggestions how a sustainable settlement could be achieved, emphasising the need to focus on outcomes that ensure a viable Moldovan state. On this basis, recommendations are made about future EU engagement with Moldova, the Transnistrian region, and the partners in the 5+2 conflict settlement process. EP/EXPO/B/AFET/FWC/2009-01/Lot1/41 October/ 2012 PE 457.135 EN Policy Department DG External Policies This study was requested by the European Parliament's Committee on Foreign Affairs. AUTHOR: Professor Stefan WOLFF, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ADMINISTRATOR RESPONSIBLE: Julien CRAMPES Directorate-General for External Policies of the Union Policy Department WIB 06 M 075 rue Wiertz 60 B-1047 Brussels Editorial Assistant: Elina STERGATOU LINGUISTIC VERSIONS Original: EN ABOUT THE EDITOR Editorial closing date: 26 October 2012. -
The Eu and Transnistria Author:1 Nico Popescu
UNISCI DISCUSSION PAPERS Nº 10 (Enero / January 2006) THE EU AND TRANSNISTRIA AUTHOR:1 NICO POPESCU Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels Introduction EU thinking, assessments and policies towards the conflict in Transnistria have evolved quickly. The turning point towards a more active role occurred in late 2002. Since then, the EU has stepped up its attention and actions. The EU now raises constantly the Transnistria issue in relations with Russia and Ukraine. The Union has also used an array of CFSP instruments to support the conflict resolution process – these have included appointing a EU Special Representative, introducing a travel ban against the Transnistrian leadership, as well as envisaging common actions under its ENP Action Plans with Moldova and Ukraine on conflict resolution in Transnistria. 1. Why More EU Engagement? First, because of enlargement. A 2002 Commission paper on EU approaches to Moldova stated: ‘Moldova’s stability clearly matters to the EU. Within a few years, Moldova will be on the borders of an enlarged EU. It has been destabilised by weak government, armed conflict and secession, near economic collapse, organised crime and emigration […] The EU needs to help Moldova address these problems’2. Enlargement stimulated the EU to develop a neighbourhood policy. Second, developments in CFSP and ESDP mean that the EU not only can look East, but that it can also potentially act in the East. What is more, by 2002, the Balkan region had been set more or less on the path towards stabilisation. Serbia’s authoritarian leader Slobodan Milosevic was ousted, FYR of Macedonia had stabilised after the 2001 clashes between the Slavic and Albanian communities and the EU was beginning to pay more attention to its Eastern neighbourhood.